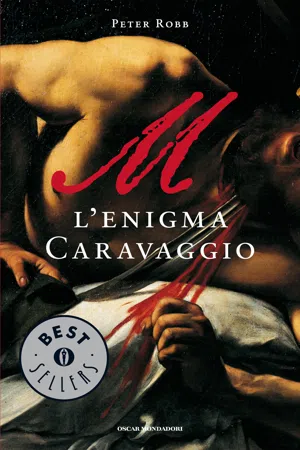![]()
M? M era un pittore. Di lui parla questo libro. Il suo nome era Michelangelo Merisi. Nella sua prima biografia edita, opera di un contemporaneo che l’aveva conosciuto, però è chiamato Amerigi. Nella seconda Merigi. Quando aveva un anno, inoltre, suo padre fu registrato come Merici, e poi, quando aveva cinque anni, come Morisi. In documenti della corte romana il pittore è chiamato Merisio, e in un altro documento, risalente a un anno prima della sua morte, Morigi. Ulteriori capricci della lingua scritta mutarono il suo nome in Morisius, Amarigi, Marigi, Marisi, Narigi, Moriggia, Marresi e Amerighi. Quanto a lui, si firmava Marisi.
Gli amici incerti sul suo cognome lo chiamavano semplicemente Michelangelo, o Michele o Michelagnolo, e chi lo conosceva meno o era incerto anche sul suo primo nome, lo chiamava genericamente Caravaggio, dal nome della cittadina in provincia di Bergamo dove quasi di certo non era nato, ma dove aveva trascorso parte dell’infanzia e da cui provenivano le famiglie dei suoi genitori. M nacque con ogni probabilità a Milano, e lì imparò a dipingere. La sua data di nascita è il 1571, anche se i suoi amici, e tutti fino a epoca recente, pensavano che fosse nato nel 1573, perché, quando si recò a Roma, imbrogliò sull’età togliendosi un paio d’anni. Il genio era più apprezzato se era giovane e, a Roma, M era un esordiente un po’ in ritardo, ancora sconosciuto quando altri pittori suoi coetanei avevano già fatto carriera e lo impiegavano in lavori alla catena di montaggio. Morì nel 1610, probabilmente il 18 luglio, in una località non identificata. Anzi, più che morire, sarebbe meglio dire che scomparve. Il suo corpo non fu mai trovato. Nessuno fu testimone della sua morte o, se qualcuno lo fu, non parlò.
I quindici cognomi e le date e i luoghi di nascita e morte non sono gli unici elementi incerti della sua biografia. Non meno incerto è molto di ciò che avvenne fra quei due punti estremi. Quello che sappiamo oggi lo dobbiamo in gran parte ai ricordi di due contemporanei che scrissero un paio di decenni dopo i fatti, a una decina d’anni dalla morte di M. Le vite degli artisti, a quei tempi, erano brevi. Spesso a viverle, sempre a raccontarle. Le biografie non superavano la lunghezza di una voce di un who’s who o di una guida turistica. Per lo più si trattava di elenchi cronologici di opere con una nota sulla tecnica o un aneddoto qua e là. Le più intelligenti e ambiziose, quelle di Vasari a metà del Cinquecento e di Bellori un secolo dopo, sviluppavano un’idea di pittura che la carriera di ogni artista era chiamata a esemplificare. La vita interiore del singolo artista o le piccole vicende della sua esistenza sociale, alimento base delle biografie moderne, non erano ritenute degne di essere raccontate.
L’idea della vita interiore dispiegò le sue terribili ali un paio di secoli dopo rispetto a quando le vite di quei pittori furono vissute e narrate, e così l’idea, a essa connessa, della grandezza piovuta dal cielo che oggi chiamiamo celebrità. Nell’Ottocento la chiamarono genio. La vita quotidiana dell’artista era ignorata perché tutti sapevano che si trattava per lo più di una vita di lavoro duro e sporco; e, anche con la patina del tempo, soffermarsi sulla fatica altrui non ha mai entusiasmato nessuno. Le prime biografie degli artisti erano distaccate, primitive e assennate. Coloro che le scrivevano erano abbastanza ben informati, vicini a quanto narravano e, nel caso di M, rimangono tuttora la fonte principale delle nostre conoscenze. Le prime biografie edite di M sono tuttavia racconti molto interessati, tagliati su misura per avallare le tesi degli autori. L’interpretazione che entrambe danno dell’artista è assolutamente sospetta. La prima fu scritta da un pittore che, umiliato da M, era deciso a saldare il conto per la Storia. La seconda da un intellettuale il cui sottile intento storico-artistico esigeva una demolizione personale dell’artista.
Ma la mancanza di interesse degli intellettuali del Seicento per la vita privata altrui non è l’unica ragione delle scarse informazioni di cui disponiamo su M. Egli visse in un’epoca di guerra fredda ideologica che, nel tardo Cinquecento, aveva spaccato in due l’Europa non meno profondamente di quanto abbiano fatto nel Novecento le divisioni politiche. L’ascesa del protestantesimo nel nord del continente aveva innescato, nella cattolica Italia, un’involuzione difensiva e totalitaria. La controriforma aveva messo la cultura italiana sul piede di guerra, rivendicando per la Chiesa il totale controllo delle menti e dei corpi. Essa fu lanciata sette anni prima della nascita di M, e condizionò tutta la vita dell’artista. Le sue armi erano la coercizione e la persuasione. Il bastone era l’Inquisizione, grande apparato repressivo che, servendosi di informatori e tribunali segreti, affrontava la devianza ideologica con l’umiliazione, la prigione, la tortura e il rogo. La carota era l’arte, arruolata per servire agli scopi della Chiesa militante e convogliare le energie dell’immaginazione nei canali della dottrina cattolica.
Quella italiana non era una società che si adattasse facilmente al controllo totalitario, e la realizzazione delle ambizioni repressive della Chiesa fu solo intermittente e imperfetta. La rete del terrore aveva delle smagliature, e anche nella peggiore arte di regime c’era quasi sempre qualcosa di interessante. Tuttavia il terrore faceva pesare anche sull’arte le sue conseguenze. Paura e sospetto pervadevano la cultura. Il terrore era in agguato per quello che si leggeva, per i propri comportamenti sessuali, per come ci si vestiva, per quello che si pensava in materia di religione, per quello che si sapeva di scienza, per le proprie posizioni politiche. La vita privata era confinata nella clandestinità. M visse in un’epoca di potere burocratico, di controllo poliziesco del pensiero e di pauroso conformismo, in cui i leccapiedi e i benpensanti fiorivano e le menti originali venivano crudelmente punite o condannate al silenzio.
Nella vita di tutti i giorni ciò significava che, a differenza di quanto avveniva prima in Italia, si viveva per conto proprio, si stava attenti a quello che si diceva e, ancora di più, a quello che si metteva nero su bianco. Non era un’epoca che incoraggiasse il pettegolezzo, il ragionamento, le chiacchiere a tavola, le battute di spirito, il paradosso né le più libere e vivaci attività della mente, nemmeno fra amici. Parlare a briglia sciolta poteva costare la vita. Ebbe termine quella sorta di commercio sociale che fioriva prima fra i potenti e gli artisti da loro protetti, fra clero e intellettuali laici, fra aristocratici e uomini d’affari, fra uomini e donne, fra vecchi e giovani. Venezia continuò nella sua sfolgorante vita promiscua e Firenze nella sua energica resistenza culturale, ma ormai erano delle eccezioni, e altamente sospette agli occhi di Roma. La splendida disinvoltura della cultura urbana italiana era finita. La vita sociale era segnata da circospezione, dissimulazione, diffidenza, e non era certo un’epoca che invitasse a lasciare tracce della propria vita privata, specie se si avevano idee e posizioni o si tenevano comportamenti che potevano attirare un’attenzione indesiderata. Le cose, lo capivano tutti, dovevano restare fra amici. Anche gli alti ecclesiastici, tutt’altro che anticonformisti, tenevano la loro corrispondenza privata in una sorta di codice maliziosamente allusivo, suscettibile di una doppia lettura, e quando trattavano questioni di stato era implicito che le lettere sarebbero state distrutte, o che le informazioni di rilievo andassero trasmesse oralmente.
Non è un caso che, benché M avesse una grafia sciolta e raffinata, le uniche tracce scritte che abbia lasciato della sua vita siano un paio di ricevute buttate giù in fretta. O che, a parte i conti relativi a qualche commissione, gli unici documenti sulla sua vita quotidiana siano rapporti di polizia e verbali di tribunale. È nella natura di una società poliziesca che la gente, certa gente, per il minimo pretesto si rechi dalle autorità a sporgere reclami e denunce, ed è soltanto nelle prolisse, esaltate, volubili, irose o evasive dichiarazioni rese alle autorità locali che oggi si può sentire la realtà della vita quotidiana di quegli anni. A testimoniare della vita comune nell’Italia della controriforma era essenzialmente la fedina penale. E poiché M ebbe la sua parte di scontri con le autorità – più che la sua parte, a dire il vero – le tracce che ne sono state trovate fra le voluminose e tarlate carte che documentano i guai della gente con la legge sono tutto ciò che sappiamo di come egli viveva giorno per giorno.
La critica non ci ha lasciato molto. Le antiche «vita e opere» di M, negli originali italiano, tedesco e olandese, con introduzioni e traduzione inglese a fronte, prendono tutte insieme una quarantina di pagine, per la maggior parte dedicate ai dipinti. Cinquant’anni fa Roberto Longhi pubblicò tutti i lavori critici sull’opera dell’artista di autori italiani, francesi, inglesi e tedeschi fino all’inizio del Novecento in poco più di una cinquantina di paginette, buona parte delle quali occupate dal suo commento. Trecento anni di ricerche sulla vita e l’opera di M stanno comodamente in cinquanta pagine. L’uomo M sopravvive come nome negli archivi, ma i dati d’archivio non ricreano una vita a tutto tondo. Forniscono punti fra i quali tracciare delle linee, forme da colorare, terreni su cui avanzare ipotesi, elementi con cui tracciare un identikit mentale, e le pagine che seguono non sono che un profilo del genere. Un’ipotesi. Uno schizzo destinato a sbiadire con l’emergere di nuove conoscenze, anche se è improbabile che ritrovamenti d’archivio potranno mai rendere il pittore M un personaggio simpatico al lettore: la gente lo ha sempre trovato un uomo spinoso, e i suoi nemici un violento. Coloro che gli erano più vicini non hanno mai parlato. Se lo si vuole conoscere, si può girovagare per qualche palazzo, per vicoli e celle di prigione, aggirarsi nella penombra di qualche chiesa, in qualche porto, in una o due spiagge deserte – che non diranno molto – e si può dare uno sguardo lungo e intenso ai suoi dipinti.
I dipinti. Gli storici dell’arte hanno elaborato un plausibile canone e una cronologia dell’opera di M. È un grande risultato collettivo, frutto di anni e anni di paziente lavoro. Un secolo fa i dipinti dell’artista marcivano ancora per lo più in cantine e soffitte e in chiese in rovina, nascosti da spessi strati di polvere, mentre sotto il suo nome passavano una quantità di goffe copie e grossolane imitazioni opera di pittori posteriori. Riportare M alla vita e alla vista è stata un’impresa lunga, complessa e gravosa. Il nerofumo lasciato dalle candele, strati di vernice giallognola e rozze ridipinture sono stati rimossi da un quadro dopo l’altro. Tele marcescenti, colori crepati, tessuti lacerati sono ritornati, dopo attente cure, a un’esistenza materiale stabile. Immagini che sembravano irrecuperabili hanno ritrovato vita, una vita imperfetta ma reale. Vi sono ancora dipinti da trovare, dubbi da sciogliere, quadri da rimettere in sesto. Ora, però, ci si può muovere attraverso una sequenza abbastanza certa di opere e cercare di porle in rapporto con gli eventi noti della vita di M. È possibile farlo da meno di un decennio.
I dipinti sono il grande segreto di M. Essi conservano ancora, per molti, la peculiare inaccessibilità di un fenomeno palese. Incantano e sconcertano dando l’impressione, come certe opere di Tolstoj e Čechov, di non avere assolutamente nulla a che fare con l’arte. Sembrano andare dritti alla sconvolgente e deliziosa vita stessa, senza la mediazione di alcuna intelligenza formale. L’apparenza, naturalmente, inganna. In un’epoca in cui l’arte era prigioniera prima delle idee, poi dell’ideologia, M intraprese una decisa e solitaria esplorazione di che cosa significasse vedere la realtà delle cose e delle persone. E lo fece con un rigore che non ebbe meno importanza per le origini della scienza moderna che per l’arte moderna, come l’opera di Leonardo un secolo prima, e, in un certo senso, anche più di quella, perché ciò che Leonardo aveva scritto sull’arte divenne realtà artistica solo nelle mani di M: egli rese l’ottica di come vediamo con tanta verità che, quattro secoli dopo, i suoi dipinti appena ripuliti fanno trasalire come brillanti fotografie di un’altra età. Tali immagini erano il frutto di un’attenzione al reale che ignorava le meticolose geometrie dell’arte rinascimentale con lo stesso scrupolo con cui ignorava i dogmi religiosi. Nessun altro pittore aveva mai colto come M la presenza di un corpo vivo.
Eppure egli fu capace di rendere l’arte così incredibilmente oggettiva solo perché rimase assolutamente fedele al proprio soggettivo modo di vedere. Le sue esplorazioni visive mettevano a nudo la sua psiche e la sua sensibilità con una franchezza e un coraggio toccanti: sapeva bene che quello che dipingeva, e il modo in cui lo dipingeva, mostravano lui stesso non meno che i personaggi raffigurati sulle tele. La peculiare onestà personale di M ha più a che vedere con Cézanne che con i pittori a lui precedenti, ed è per questo, in ultima istanza, che egli affascina oggi. È il primo pittore moderno. L’enigma dell’uomo M è che ben pochi degli scarsi eventi noti della sua stupefacente vita sembrano corrispondere alla mente sottile e penetrante riflessa dai suoi dipinti. Fin dall’inizio della sua fama, nei primi anni del Seicento, l’uomo M era noto a Roma come un individuo difficile, violento e antisociale: «stravagante» era la parola usata dai più. E gli eventi successivi della sua vita parvero confermare i primi giudizi con tragica irrevocabilità. Il peggiore e più duraturo effetto della sua storia personale fu che essa si rifletté sulla sua pittura, anzi, fu riflessa sulla sua pittura da intellettuali a lui ostili, distorcendo la natura di ciò che aveva fatto. Eppure, di quella scorza dura, M aveva bisogno per difendere la propria arte e la propria persona in un’epoca violenta e intollerante. C’erano stati anni, prima della fama, in cui era stato felice, sicuro, produttivo, in cui non aveva attratto attenzioni indesiderate.
Le sue prime opere lasciarono a bocca aperta i contemporanei per come sembravano vere. Una sua goccia d’acqua su una foglia li abbagliava. La qualità delle sue carni nude li mandava in delirio. Gli effetti che egli raggiungeva li costrinsero a rendersi conto trasalendo, dopo che nel 1600 ebbe conquistato di colpo Roma, della polemica semplicità del modo in cui vedeva l’arte. Diceva M: dipingi, dipingi dal vero, dipingi ciò che vedi; un «valent’huomo» sa, in pittura, fare «le cose naturali»,1 e soprattutto – anche se questo, benché fosse la sua pratica, non lo disse mai – sa, come sapeva lui, mettere le cose naturali che vede direttamente sulla tela. L’interferenza del disegno preparatorio va dimenticata. Il disegno è convenzionalità, è idee prestabilite, è vita falsificata: questo implicavano le sue parole. M non disegnava.
Una posizione del genere non poteva non portare scompiglio in una professione che vedeva nel duro tirocinio del disegno il fondamento stesso dell’arte. Per non parlare di una Chiesa che, come gli studios hollywoodiani di un’altra epoca, teneva in pugno le principali possibilità di lavoro nel campo, e vedeva nella pittura non un modo per mostrare la vita reale, ma uno strumento per trasmettere una serie di messaggi strettamente controllati. La Chiesa della controriforma chiedeva e otteneva immagini su immagini dei primi martiri cristiani e delle loro raccapriccianti morti. Era il suo modo di ritornare alle proprie radici. A rappresentazioni di torture e morti la gente era abituata; non ci faceva quasi più caso. La sofferenza era la tappezzeria mentale dell’epoca. Ma quando M dipinse una testa mozzata, si vide per la prima volta cosa significava tagliare un collo. M fece vedere come si sentiva un vecchio con le mani inchiodate. L’irrompere della realtà nell’arte religiosa non poteva non dare fastidio, e lo diede. M aveva da poco fatto irruzione sulla scena, che si trovò sotto attacco. I pittori affermati lo odiavano perché sovvertiva la struttura professionale attraverso la quale avevano fatto carriera e perché faceva apparire gli estenuat...