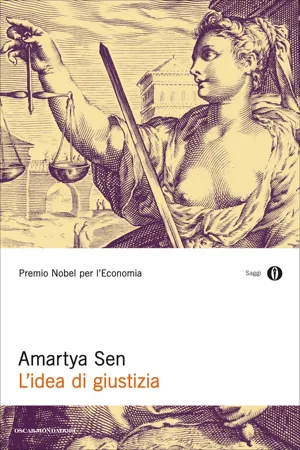![]()
![]()
Ludwig Wittgenstein, uno dei massimi filosofi del nostro tempo, scriveva nella prefazione della sua opera principale, il Tractatus logico-philosophicus, pubblicato nel 1921: «Quello che si può dire, si può dire chiaro; e su ciò di cui non si può parlare si deve tacere».* In seguito Wittgenstein avrebbe rivisto queste posizioni su linguaggio e chiarezza, ma anche all’epoca della stesura del Tractatus il grande filosofo non sempre rispettò la sua impegnativa sentenza. In una lettera del 1917 a Paul Engelmann, Wittgenstein fece questa osservazione, stupefacente ed enigmatica: «Sto lavorando piuttosto seriamente, e mi piacerebbe essere un uomo migliore e più assennato. Le due cose in fondo coincidono».1 Davvero? Essere un individuo più intelligente ed essere una persona migliore sono la stessa cosa?
So bene, naturalmente, che nel moderno inglese d’oltreoceano la distinzione tra «essere buono» («being good») in senso morale e «star bene» («being well») in senso fisico (niente disturbi né dolori, pressione a posto e via dicendo) è venuta meno; ormai da molto ho smesso di stupirmi della sfacciata immodestia degli amici che, quando chiedo loro come stanno, mi rispondono con l’apparente autoelogio «I am very good». Wittgenstein, però, non era un americano e nel 1917 il colorito uso d’oltreoceano era ben lungi dall’avere conquistato il mondo. Scrivendo che essere «migliore» ed essere «più intelligente» sono la stessa cosa, Wittgenstein intendeva con ogni probabilità esprimere qualcosa di importante.
Potrebbe trattarsi in qualche modo del riconoscimento che molti atti di malvagità sono commessi da chi si sta ingannando, per un verso o per l’altro, riguardo alla questione in causa. E non c’è dubbio che la mancanza di intelligenza sia una delle ragioni della mancata scelta morale di operare il giusto: a volte, riflettere su ciò che sarebbe davvero intelligente fare contribuisce a migliorare il nostro comportamento nei confronti del prossimo. La moderna teoria dei giochi ha dimostrato chiaramente che in molti casi è proprio così.2 Tra le ragioni sensate per comportarsi bene si può senz’altro comprendere il profitto che uno ne ricava. Infatti, tutti i membri di un gruppo che seguano regole di buon comportamento a beneficio di ognuno possono trarne un vantaggio davvero notevole; per i membri di un gruppo non è molto intelligente agire in un modo che danneggia tutti.3
Forse, però, Wittgenstein non voleva dire questo. L’intelligenza può anche darci la capacità di riflettere in modo più chiaro sui nostri scopi, obiettivi e valori. Se l’interesse personale è, in fin dei conti, un pensiero primitivo (nonostante le complesse implicazioni appena menzionate), la chiarezza intorno alle priorità e agli impegni più sofisticati che possiamo prendere in considerazione e perseguire dipende perlopiù dalla forza del raziocinio. Una persona può trovare ragioni ben ponderate, oltre al proprio tornaconto, per agire in modo socialmente corretto.
Essere più intelligente può aiutare non solo a capire meglio il proprio interesse, ma anche a comprendere quanto la vita degli altri possa essere toccata dalle nostre azioni. I sostenitori della cosiddetta «teoria della scelta razionale» (nata in ambito economico, poi adottata con entusiasmo da numerosi teorici della politica e del diritto) si sono impegnati per farci accettare la singolare idea che la scelta razionale consiste soltanto nella promozione dell’interesse personale (è questa la non poco bizzarra definizione di «scelta razionale» che ci hanno offerto). Ma non tutti si sono lasciati soggiogare da questa alienante convinzione: c’è una considerevole resistenza all’idea che sia del tutto irrazionale, e stupido, cercare di fare qualcosa per gli altri, se non nei casi in cui questo incrementa il nostro benessere.4
Quello dei «nostri doveri reciproci» costituisce un tema importante su cui esercitare l’intelligenza. È una riflessione che può condurci molto al di là dell’angusto punto di vista dell’interesse personale, fino a farci scoprire che il raggiungimento degli obiettivi su cui abbiamo ben meditato richiede di uscire dai limiti del tornaconto personale.5 Possono presentarsi dei casi in cui è ragionevole limitare il perseguimento esclusivo di obiettivi personali (siano o no dettati dal mero interesse individuale), in nome di regole di comportamento che concedano alle altre persone con cui condividiamo il mondo lo spazio per perseguire i loro obiettivi (anch’essi dettati o meno dall’interesse individuale).*
Dato che precursori della «teoria della scelta razionale» esistevano già all’epoca di Wittgenstein, forse il filosofo intendeva dire che essere più intelligenti aiuta a pensare in modo più chiaro ai propri impegni e alle proprie responsabilità sociali. È stato dimostrato che alcuni bambini si comportano in modo violento nei confronti di altri bambini o di animali proprio perché non sono in grado di valutare adeguatamente la natura e l’intensità del dolore altrui e, in generale, che tale capacità accompagna lo sviluppo intellettuale dell’età adulta.
Non possiamo avere certezze su ciò che Wittgenstein intendesse dire.* È però evidente che egli dedicò non poca parte del suo tempo e delle sue capacità a riflettere sui propri impegni e sulle proprie responsabilità. Non sempre i risultati furono intelligenti o saggi. Nel 1938 Wittgenstein era assolutamente deciso a recarsi a Vienna (proprio al tempo dell’ingresso trionfale di Hitler nella città), incurante del fatto di essere ebreo e di non saper tacere o comportarsi in modo diplomatico; furono i suoi colleghi di Cambridge a impedirglielo.** Comunque sia, molti elementi desunti dalle conversazioni di Wittgenstein provano che era convinto di dover sfruttare le sue facoltà intellettuali per rendere il mondo un posto migliore.***
Critica della tradizione illuminista
Se è davvero questo ciò che Wittgenstein voleva, allora dobbiamo inscriverlo, e in una posizione di rilievo, nella tradizione dell’Illuminismo europeo, secondo la quale il miglioramento della società trovava uno dei massimi alleati nell’esercizio del raziocinio. Promuovere il progresso sociale attraverso il ricorso sistematico alla ragione era una delle tendenze più diffuse nell’animata vita intellettuale dell’Illuminismo europeo, specie nel XVIII secolo.
Lo strapotere della ragione nella linea teorica che prevalse durante l’Età dei Lumi, tuttavia, non si lascia generalizzare tanto facilmente. Come ha mostrato Isaiah Berlin, la stagione illuminista espresse anche varie tendenze di segno antirazionalista.6 Senza dubbio, però, il forte e consapevole affidarsi alla ragione fu tra gli aspetti che più distinse l’Illuminismo dalla tradizione precedente. Nel dibattito politico contemporaneo è diventata comune l’opinione che gli illuministi sovrastimarono le possibilità della ragione; anzi, c’è chi ha affermato che l’eccessiva fiducia nella ragione, che l’Illuminismo contribuì a radicare nel pensiero moderno, non è estranea alla propensione per le atrocità emersa nel mondo postilluminista. Jonathan Glover, l’apprezzato filosofo, ha aggiunto la sua voce nel ben argomentato saggio Humanity: una storia morale del ventesimo secolo: «La visione che gli illuministi avevano della psicologia umana», sostiene Glover, si è rivelata sempre di più «debole e meccanicistica» e «le speranze di progresso sociale che riponevano nella diffusione dell’umanitarismo e della visione scientifica del mondo» ci appaiono oggi piuttosto «ingenue».7 Glover (come altri critici dell’Illuminismo) arriva a individuare un nesso con i tiranni dell’età contemporanea, affermando che non solo «Stalin e i suoi eredi» furono «fedeli seguaci dell’Illuminismo», ma anche Pol Pot «ne fu indirettamente influenzato».8 Tuttavia, dato che non intende cercare soluzioni ricorrendo all’autorità della religione o della tradizione (anzi osserva che «non possiamo sottrarci all’Illuminismo»), Glover concentra i suoi attacchi sulle convinzioni troppo rigide e certe, alle quali contribuisce in modo sostanziale l’eccessiva fiducia nella ragione. La crudeltà dello stalinismo, conclude, ha origine in queste convinzioni.9
In effetti, è difficile contestare l’osservazione di Glover sulla forza delle convinzioni inflessibili, settarie, o confutare la sua tesi del «ruolo dell’ideologia nello stalinismo». L’obiezione da sollevare qui non riguarda il potere nefasto delle cattive idee, bensì la conclusione che in questo modo si possa muovere una critica alla ragione in generale e alla prospettiva illuminista in particolare.10 È davvero corretto imputare alla tradizione illuminista la propensione alle certezze e alle convinzioni infondate da parte di certi crudeli leader politici, considerata l’importanza essenziale che tanti illuministi assegnano al raziocinio nell’elaborazione delle decisioni, e proprio per contrapporsi a ogni fideismo cieco? Certo è che ci si poteva opporre alla «crudeltà dello stalinismo», come infatti fecero i dissidenti, mostrando con argomenti razionali l’enorme distanza tra le promesse e la realtà e additando, al di là delle sue pretese, la ferocia del regime, una ferocia che le autorità sottraevano alla discussione tramite la censura e le epurazioni.
Uno dei principali argomenti in favore della ragione è proprio il fatto che essa aiuta a esaminare criticamente l’ideologia e le cieche convinzioni.* Il migliore alleato di Pol Pot non fu di certo la ragione, ma semmai il fideismo esaltato e privo di qualsiasi spirito critico. Tra i problemi interessanti e importanti che solleva la critica di Glover alla tradizione illuminista c’è la domanda: dove trovare un rimedio al cattivo uso della ragione? E a questa ne segue un’altra, collegata: qual è il rapporto tra la ragione e i sentimenti, tra cui quello della compassione e quello della solidarietà? E ancora: su cosa si fonda la fiducia nella ragione? È giusto considerare la ragione un valido strumento, e in tal caso a cosa serve? Oppure è la ragione a giustificare se stessa e, se è così, in cosa si distingue da una fede cieca e incondizionata? Nel corso dei secoli questi temi sono stati ampiamente dibattuti; è necessario in special modo tornare ad affrontarli qui, perché in questo libro il ragionamento ha un ruolo centrale nella ricerca del concetto di giustizia.
Akbar e la necessità della ragione
William B. Yeats annotò in margine alla sua copia della Genealogia della morale di Nietzsche: «Perché mai Nietzsche pensa che la notte non abbia stelle, ma soltanto pipistrelli e gufi, e la folle luna?».11 Lo scetticismo di Nietzsche sull’umanità e la sua agghiacciante visione del futuro comparvero alla vigilia del XX secolo (il filosofo morì nel 1900). Gli eventi del secolo che stava per iniziare, con le sue guerre mondiali, i suoi olocausti, i suoi genocidi e le altre atrocità, offrono più di un motivo per chiedersi se quello scetticismo non fosse fondato.* Riconsiderando le inquietudini di Nietzsche alla fine del XX secolo, Jonathan Glover conclude che «dobbiamo guardare bene in faccia, con fermezza, alcuni dei mostri che sono dentro di noi» e trovare strumenti e sistemi per «metterli in gabbia e addomesticarli».12
Circostanze come il volgere di un secolo rappresentano per molte persone momenti propizi per fare il punto su ciò che sta accadendo e ciò che si deve fare. Non sempre questo sfocia in riflessioni come quelle di Nietzsche (o di Glover), tanto pessimistiche e scettiche sulla natura umana e sulla possibilità di un cambiamento all’insegna della ragione. Un interessante contraltare, ben più antico, è dato dalle conclusioni a cui approdò in India l’imperatore Moghul Akbar, sull’onda di una riflessione di «fine millennio», più che di fine secolo. Mentre il primo millennio del calendario islamico volgeva al termine, nel 1591-1592 (cioè mille anni lunari dalla fuga di Maometto da La Mecca a Medina, nel 622 d.C.),** Akbar si dedicò a un esame ad ampio raggio dei valori sociali e politici e della pratica giuridica e culturale. A richiamare la sua attenzione erano soprattutto le sfide poste dalle relazioni tra le varie comunità e la necessità di pace e collaborazione fruttuosa, sempre impellente nell’India, già multiculturale, del XVI secolo.
Bisogna ammettere che le politiche attuate da Akbar erano piuttosto inusuali per l’epoca. La macchina dell’Inquisizione girava a pieno ritmo e nel 1600 a Roma Giordano Bruno veniva arso sul rogo come eretico, mentre in India Akbar emanava le sue disposizioni sulla tolleranza religiosa. L’imperatore indiano non solo insisteva sul fatto che tra i doveri dello Stato rientrava quello di assicurare che «nessun uomo sia ostacolato per la sua fede religiosa e a tutti sia permesso di accostarsi a qualsiasi religione desideri»,13 ma organizzava ad Agra, la capitale, incontri di dialogo tra indù, musulmani, cristiani, giainisti, parsi, giudei e altri, inclusi a volte agnostici e atei. Tenendo conto della pluralità religiosa del suo popolo, Akbar pose in vari modi le basi del laicismo e della neutralità religiosa dello Stato. La costituzione laica adottata dall’India nel 1949, all’indomani dell’indipendenza dal dominio britannico, contiene numerosi elementi già contemplati da Akbar nell’ultimo decennio del XVI secolo; fra questi, l’interpretazione del laicismo come equidistanza dello Stato tra le diverse religioni e impegno a non privilegiare alcuna fede in particolare.
L’atteggiamento generale di Akbar verso l’organizzazione degli usi sociali e l’azione politica è ben evidenziato dalla sua tesi che «l’esercizio della ragione» (anziché ciò che egli chiamava «la palude della tradizione») è la via per affrontare i problemi del retto comportamento e le sfide per costruire una società giusta.14 La questione del laicismo è solo uno dei molti casi in cui Akbar insiste sul fatto che dovremmo essere liberi di esaminare se la ragione giustifica o no le consuetudini in uso, o le politiche in atto. Per esempio, Akbar abolì le tasse straordinarie imposte ai non musulmani, giudicandole discriminatorie perché non trattavano tutti i cittadini allo stesso modo. Nel 1582 decise anche di affrancare «tutti gli schiavi dell’impero», perché «è contrario alla dignità della giustizia e della giusta condotta» fare assegnamento sulla «forza».15
Altri esempi delle critiche indirizzate da Akbar alla prassi sociale prevalente al suo tempo si individuano facilmente anche nelle argomentazioni da lui sviluppate. Così, egli era contrario al matrimonio tra bambini, molto comune all’epoca (e purtroppo ancor oggi non del tutto sradicato nel subcontinente indiano), perché – osservava – «la pratica sottintesa» dal matrimonio «è ancora lontana, mentre è immediata la possibilità che qualcuno subisca dei danni». Criticò anche la prassi induista (che sarà riformata solo molti secoli dopo) di non permettere alle vedove di risposarsi, notando fra l’altro che «una religione che nega il matrimonio alle vedove» dovrebbe vedere nel matrimonio tra bambini una mancanza «ben più grave». Sull’eredità patrimoniale Akbar osservò che «la religione islamica assegna alla figlia femmina una porzione minore, mentre una femmina, a causa della sua debolezza, dovrebbe ricevere una porzione maggiore». Un modo di ragionare molto...