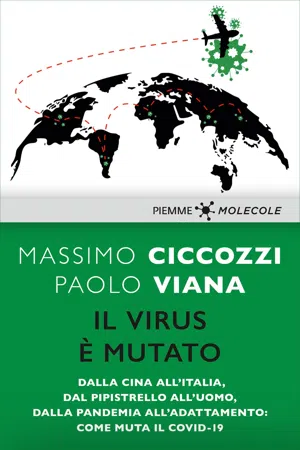Mentre scriviamo, in Italia è in corso un vivace dibattito sul fatto che il Covid-19 possa essere mutato. Sebbene le dichiarazioni riportate sui giornali non rendano giustizia alla complessità delle argomentazioni, anche chi sostiene che il virus non abbia subito mutazioni ha in realtà opinioni più articolate, per la semplice ragione che tutti i virus mutano e tutti gli uomini di scienza lo sanno.
Ciò di cui si discute, come afferma Davide Zella, ricercatore all’Università del Maryland che ha lavorato sia sull’HIV sia sul Covid-19, è «se si riscontri una mutazione funzionale». Come quella annunciata dal presidente della Società Italiana di Virologia, Arnaldo Caruso, il quale a Brescia, su pazienti italiani, avrebbe isolato una variante «estremamente meno aggressiva e geneticamente molto diversa», che presenta nell’RNA delle «mutazioni significative». Queste dichiarazioni sono apparse su giornali e agenzie di stampa all’inizio di giugno.
In realtà, la discussione sul “rabbonimento” del coronavirus si era aperta oltre un mese prima della scoperta di Caruso. Torniamo per un attimo alla seconda metà di aprile. In Italia, in quel momento, la curva dei contagi iniziava ad avere il fiatone. Pressato da Confindustria e dai commercianti, il governo allentava la morsa del lockdown, interrotta poi il 4 maggio. Le luci sul Paese si erano spente la sera del 9 marzo, con l’annuncio del presidente del Consiglio in televisione: «Tutta l’Italia dovrà restare a casa». Ci è rimasta per due mesi. Alla fine, negli ospedali si moriva ancora, ma nel Paese c’era una gran voglia di tornare a vivere. In un simile clima psicologico, il 28 aprile, il quotidiano «Avvenire» titolava «Il virus che si indebolisce». Seguiva una lunga analisi sull’evoluzione genetica del coronavirus, la sua sensibilità alle alte temperature, la pressione selettiva del lockdown, ma anche l’assoluta casualità di quelle mutazioni che, portando a un adattamento del virus, ne avrebbero potuto provocare entro l’estate un rabbonimento.
Nell’articolo, buttata lì, anche la frase «sogno di mezza estate», vergata un mese prima che infettivologi di vaglia come Matteo Bassetti e anestesisti come Alberto Zangrillo confermassero che in corsia il Covid-19 non si vedeva più, che le rianimazioni erano vuote e i malati mostravano sintomi molto più blandi di quelli che all’inizio di marzo avevano fatto temere ai sanitari milanesi di dover ricoverare, in poche ore, 44.000 pazienti (la stima che circolava nei grandi ospedali meneghini la sera del 9 marzo).
Inspiegabilmente, l’ipotesi dell’indebolimento non è stata sottoposta a una verifica scientifica. Con una scelta irrituale, il direttivo della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) l’ha smentita a mezzo stampa. Comportamenti eccezionali in un momento eccezionale, in cui la sicurezza nazionale veniva a coincidere con la profilassi e la ricerca scientifica poteva inciampare nella ragion di Stato. Sedatis motibus, si comprenderà che la questione “mutazioni versus lockdown” era inesistente. Sulla realtà delle mutazioni adattative dei virus esistono delle prove antiche.
È arcinoto che il virus persegua una “fitness”, che rappresenta il suo successo riproduttivo, il quale dipende a sua volta dalla sopravvivenza della specie che lo ospita. Arcinoto è anche che lo strumento di cui dispone per raggiungere questo risultato sono le variazioni casuali che avvengono nell’RNA, ogni volta che si riproduce. Arcinoto è pure che il processo è governato dalle regole probabilistiche. Infine, è arcinoto che vengono selezionate in questo modo le varianti più funzionali alla riproduzione e che esse conducono quasi sempre ad adattare il parassita all’ospite. Insomma, è tutto già scritto sui libri. Infatti, uno dei più prudenti e accreditati studiosi della materia, che appartiene al “partito” dei clinici ma studia con i genetisti le mutazioni del Covid-19, l’infettivologo del Policlinico Gemelli Roberto Cauda, ha dichiarato all’agenzia «Adn Kronos» il 1° giugno 2020, a proposito del calo di contagi e di decessi, che «si tradurrà di certo in pubblicazioni scientifiche, che hanno una valenza diversa rispetto a una dichiarazione, per quanto proveniente da colleghi autorevoli. Ecco, penso che questo sia un aspetto di cui tener conto: aspettiamo gli studi scientifici». Ciò detto, il Covid-19 è mutato almeno due volte, per limitarci agli studi italiani. Uno firmato anche da Cauda.
Secondo il GISAID, che è la banca dati mondiale dei genetisti, da ogni coronavirus dobbiamo aspettarci 24 mutazioni o ricombinazioni importanti all’anno. La metà di quelle che subisce l’agente patogeno dell’influenza. Pur sempre troppe per sperare di trovare un vaccino al Covid-19 che valga per sempre. Mentre un virus a DNA esprime tassi di mutazione analoghi a quelli di una cellula eucariota (che possiede un nucleo, mentre il virus non ce l’ha e per questo si definisce “parassita endocellulare obbligato”), in quanto dispone di enzimi che correggono le replicazioni sbagliate, i virus a RNA non dispongono delle DNA polimerasi e la frequenza di mutazioni è dunque più alta.
La Sars-CoV-2 fa parzialmente eccezione, perché muta moltissimo – fino a un milione di volte più dell’ospite – ma dispone anche di un correttore molto potente, capace di ridurre il numero delle mutazioni. Dettaglio non irrilevante: uno degli studi cui ha partecipato Zella (ancora in corso di peer review) evidenzia in alcuni genomi virali una mutazione anche nel correttore. Già: è mutata la proteina deputata a non far mutare il Covid-19.
Le conseguenze di questa mutazione non sono politiche ma sanitarie: «La capacità mutagenica del virus» scrivono gli autori «dipende da diversi fattori, tra cui la fedeltà degli enzimi virali che replicano gli acidi nucleici, come la Sars-CoV-2 RNA polimerasi RNA dipendente (RdRp). Il tasso di mutazione guida l’evoluzione virale e la variabilità del genoma, permettendo così ai virus di sfuggire all’immunità dell’ospite e di sviluppare la resistenza ai farmaci1». Non è un caso che lo studio sulla polimerasi sia firmato dallo staff di Robert C. Gallo, uno degli scienziati che scoprirono l’HIV, e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Pur avendo studiato anche la Spike, arrivando a scoprire una nuova mutazione, si sono concentrati su una sezione del genoma virale diversa da quelle studiate in tutto il mondo. Condizionare la polimerasi significherebbe, come spiega Zella, «modificare la replicazione e quindi alterare l’infettività del Covid-19». La mutazione individuata dallo studio italo-americano è apparsa per la prima volta in Italia: non era presente nei pazienti cinesi isolati in precedenza ed è diventata dominante. E oggi la mutazione del gene della polimerasi NSP12 è presente in tutti i tamponi positivi effettuati nel nostro Paese. «Ora vorremmo capire» dice Zella «se le mutazioni osservate sulla RNA polimerasi sono resistenti agli antivirali e, dopo le prove di laboratorio, disegnare degli inibitori.» La caccia all’antivirale è già iniziata.
Robert Gallo ha dichiarato che «potrebbero coesistere ceppi europei, nordamericani e asiatici, ognuno dei quali caratterizzato da un diverso schema di mutazione» e bisogna monitorare attentamente la polimerasi del virus, proprio perché la presenza di una mutazione in questo gene potrebbe portare alla resistenza del virus ai farmaci. Attualmente, per il trattamento dell’infezione, sono utilizzati dei principi attivi che prendono di mira proprio gli enzimi della RdRp (Favipiravir, Galidesivir, Remdesivir, Ribavirina, Penciclovir, Galidesivir…) e alcuni potrebbero essere inibiti dalla mutazione identificata. Occorre anche verificare la presenza di mutazioni in altre parti del complesso della polimerasi, parti che hanno la funzione di correggere le mutazioni del virus senza modificare le altre funzioni catalitiche di tale enzima. Alcuni scienziati ipotizzano che, passando dall’Asia all’Europa, il virus sia diventato più contagioso, come vedremo, e che sia anche aumentato il tasso di mutazione.
Se il correttore dovesse mutare e perdere la sua funzione, le mutazioni potrebbero diventare incontrollabili. «Può sembrare spaventoso,» ammette Zella «ma nella maggior parte dei casi le mutazioni sono adattative, in quanto mutando la polimerasi cambiano anche altre proteine, o addirittura letali per il virus».
Per avere un’idea più chiara di cosa significhi un correttore meno preciso ricordiamo che, durante la replicazione, una cellula umana può commettere un errore ogni 100 milioni di nucleotidi incorporati (a ogni replicazione, l’RNA, che ha il compito di riprodurre le informazioni genetiche del DNA e dirigere la sintesi delle proteine, deve associare una base A con T/U e una G con C, e ovviamente può sbagliare), un virus a DNA, che ha comunque un buon correttore, uno ogni milione, e quelli a RNA come il Covid-19 tra mille e diecimila. L’unico virus più impreciso del Covid-19 è l’HIV. Lo studio citato ha individuato otto mutazioni di una certa importanza e «per la prima volta» quella del gene RdRp, in Inghilterra e in Lombardia. Si sospetta, ma non è accertato, che tali mutazioni possano spiegare i diversi tassi di mortalità della Sars-CoV-2.
Gli studi ovviamente vanno avanti. In Arizona, nelle scorse settimane, è stata riscontrata una delazione nella Sars-CoV-2. In pratica sono scomparsi dei nucleotidi nella stessa zona in cui è cambiata la Sars del 2002 prima di sparire. Quest’ultima è una suggestione ma la delazione è reale e fa ben sperare2.
Quando queste evidenze emergono siamo ormai all’inizio dell’estate. Già nel mese di febbraio, però, Thung Phan, dopo aver studiato i cambiamenti intervenuti nei nucleotidi dei virus, scriveva che «la rapida diffusione della Sars-CoV-2 solleva domande intriganti, come ad esempio se la sua evoluzione sia guidata da mutazioni» e rivelava di aver individuato lui stesso ben «novantatrè mutazioni sull’intero genoma della Sars-CoV-23». Dunque, il coronavirus avrebbe iniziato a cambiare fin da prima di febbraio e proprio queste prime mutazioni adattive potrebbero aver indotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a prendere...