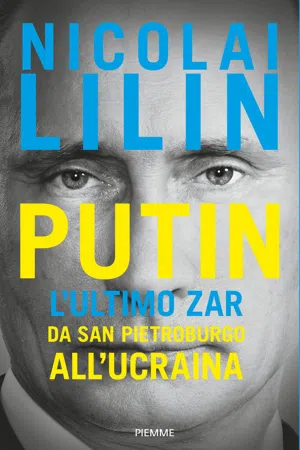Se si dovesse descrivere in maniera sintetica e non volgare il clima che negli anni Sessanta del secolo scorso caratterizzava il vicolo Baskov, a Leningrado, il termine più adatto sarebbe “eterogeneo”. Oggi questa zona fa parte del lussuoso quartiere centrale della “capitale del Nord” (così il popolo chiama San Pietroburgo), ma all’epoca era uno dei tanti luoghi in cui regnava la dottrina sovietica di uguaglianza tra i cittadini, che in pratica si traduceva nel bizzarro e in un certo senso anche romantico mescolamento dei ceti sociali. Ovviamente, nell’URSS non esistevano ufficialmente i ceti sociali, perché il comunismo ne riconosceva soltanto uno: il proletariato. Ma nella realtà quotidiana le cose andavano diversamente: qualcuno stava meglio degli altri, i più ricchi cercavano la compagnia dei propri simili, frequentavano i locali più cari e raffinati, si potevano permettere anche una certa apertura culturale, mentre i lavoratori semplici, quelli che sgobbavano nelle fabbriche per uno stipendio medio, vivevano nel loro mondo. Nonostante l’ideologia, insomma, anche durante il periodo sovietico il reddito era uno dei criteri che definivano la posizione dell’individuo nella società. Tuttavia, se non altro, lo stato cercava di organizzare la vita dei cittadini in modo da evitare la formazione di ghetti, perciò era normale che nello stesso stabile abitassero il direttore della fabbrica e i suoi lavoratori. Così, se oggi nella zona centrale di San Pietroburgo risiedono principalmente persone facoltose, negli anni Sessanta quel quartiere ospitava tutti gli esponenti della vasta “società proletaria”, e facendo un giro tra i cortili si constatava un curioso e un po’ fantasmagorico connubio che poteva ricordare la leggenda della torre di Babele perché, oltre a mischiare i ceti sociali, gli ideologi del partito facevano di tutto per mescolare anche le numerose etnie e i popoli presenti nel paese più vasto del mondo. Nelle sere estive, su quei piccoli cortili circondati dai muri di mattoni rossi le finestre si aprivano per far entrare un po’ di aria fresca, e allora si sentivano le voci delle casalinghe che chiacchieravano, mentre gli uomini, finita la giornata di lavoro, si radunavano attorno alle panchine, sotto gli alberi, per giocare a scacchi o a domino. I bambini bravi (che oltre alla scuola normale frequentavano anche quella musicale) si esercitavano con i loro strumenti, mentre i loro coetanei più “liberi” si sfidavano a “monetina”, un gioco d’azzardo che consisteva nel sollevare da terra e voltare le monete battendole l’una contro l’altra, oppure a tryapka, un gioco simile al calcio in cui i giocatori si passano con i piedi una specie di piccola palla fatta di stracci (da qui il nome tryapka, che in russo significa “straccio”). Dopo l’ora di cena i ragazzi per bene andavano a dormire, mentre i più sbandati, o quelli che addirittura si credevano già dei “piedi scalzi”, ovvero dei giovani criminali, uscivano di casa e si radunavano per fare un giro nel quartiere, farsi vedere dai ragazzi delle bande rivali e marcare la propria zona d’influenza.
Vladimir Putin era nato il 7 ottobre del 1952 in un piccolo monolocale situato al quinto e ultimo piano di una delle tante case comunali del vicolo Baskov. La sua era una famiglia “di lavoratori”, come si sarebbe detto all’epoca per indicare persone di origini semplici. Il padre, anch’egli di nome Vladimir, lavorava come fabbro (forse uno dei mestieri più diffusi e umili tra la classe lavoratrice sovietica) alla catena di montaggio dei telai nella fabbrica di Egorov, dove si costruivano vagoni ferroviari. La madre si chiamava Maria (“Masha” per i familiari). Prima della nascita del piccolo Vladimir Maria lavorava in fabbrica, ma dopo il parto, essendo il suo fisico molto indebolito e ancora segnato dai traumi della guerra, ottenne di essere assunta tra gli “spazzini”, come in Russia chiamano i custodi che tengono in ordine i palazzi e i cortili. Come sede di lavoro le fu assegnato proprio il condominio dove abitava, cosa che le avrebbe permesso di stare accanto al suo bambino, che d’accordo con il marito aveva deciso di non mandare all’asilo: Vladimir era il loro terzo figlio, ma i primi due erano morti precocemente, e dopo questi lutti e le tragiche esperienze della Seconda guerra mondiale la coppia non desiderava altro che godere della semplice vita familiare e trascorrere insieme quanto più tempo possibile.
La famiglia di Putin è di umilissime origini: i suoi bisnonni erano addirittura dei servi della gleba. Quando l’istituto della “gleba” venne abolito e molti contadini si trasferirono nelle città per cercare lavoro nelle fabbriche, gli avi di Putin arrivarono a San Pietroburgo, dove vissero fino alla Prima guerra mondiale. Lo stesso presidente ha raccontato in un’intervista: «Mio padre nacque a San Pietroburgo nel 1911. Quando scoppiò la guerra il nonno, arruolato nell’esercito zarista, partì per il fronte. La vita in città, che era già dura, lo divenne ancora di più senza l’uomo che portava a casa la pagnotta, così per sfuggire alla fame la famiglia si trasferì in campagna, al villaggio di Pominovo, nella provincia di Tver’, patria di mia nonna Olga. La vecchia casa di famiglia esiste ancora, i miei parenti spesso ci passano le vacanze. Fu a Pominovo che i miei genitori si conobbero, e lì si sposarono all’età di diciassette anni».
Spiridon, il nonno paterno di Vladimir Putin, era una persona interessante che merita di essere ricordata. Da ragazzo (si era ancora al tempo degli zar) la famiglia lo aveva mandato a San Pietroburgo per imparare il mestiere di cuoco. In quegli anni per molti contadini fare il salto di qualità nella vita significava inserirsi nella società borghese, ovvero abbandonare la vita nei campi e imparare uno dei nuovi mestieri richiesti nelle città. Le famiglie quindi mettevano da parte i risparmi per permettere ai figli di trasferirsi come aiutanti e allievi presso qualche maestro artigiano, e così fecero i genitori di Spiridon. La scelta del futuro mestiere risultò vincente: il ragazzo dimostrò una tale dedizione che presto cominciò a lavorare nei migliori ristoranti della città, tra i cui clienti c’erano i rappresentanti della nobiltà e dell’alta borghesia. Appena ventenne, figlio di contadini, lo “chef Putin” guadagnava cento rubli d’oro al mese, una somma inimmaginabile per chi come lui proveniva dagli strati umili della società!
Una sera, nel ristorante del centro di San Pietroburgo in cui lavorava, successe un fatto curioso che Spiridon ricordò e raccontò poi per tutta la vita. All’ora di cena entrò un uomo molto importante nella scena politica del paese, un personaggio il cui nome tuonava per tutta la Russia, un gigante siberiano avvolto da un’aura di storie mistiche, leggende urbane, dicerie e sospetti. Era Rasputin, il contadino divenuto santone, che vagava per il paese alternando con invidiabile serenità prediche e orge scatenate. Il suo magnetismo e le sue doti di persuasore, l’innata capacità di «possedere le persone con lo sguardo», come sosteneva chi lo conosceva, lo avevano condotto alla corte dello zar, facendolo diventare amico e consigliere della famiglia regnante. Il suo potere era tale che la fila di persone davanti alla sua casa di San Pietroburgo non si esauriva mai, nemmeno durante la notte. La gente si recava da lui per ogni genere di problema, sperando per suo tramite di far arrivare le proprie preghiere alle orecchie e al cuore dell’imperatore. Quella sera, al ristorante, Rasputin ordinò lo sci, un piatto della cucina povera contadina, una zuppa condita e molto aspra per via della quantità di cavolo utilizzato nella preparazione. Rasputin mangiò con gusto la zuppa preparata da Putin e rimase così soddisfatto da chiederne una seconda porzione, e poi una terza. Finalmente sazio, pretese di conoscere il cuoco. Quando il giovane Spiridon uscì dalla cucina e si presentò al tavolo dell’ospite, Rasputin gli chiese, alla vecchia maniera contadina: «Di chi sei?» (un tempo, infatti, ai contadini si chiedeva di identificarsi con il nome del proprio padrone). «Siamo dei Putin» rispose Spiridon, rispettando la forma di dialogo proposta dal suo interlocutore. «Putin, Putin, Putin…» ripeté pensieroso il santone. Poi mise una mano in tasca, ne estrasse una moneta d’oro e la allungò al giovane, che chinò umilmente il capo e la prese tra le dita con delicatezza. «Bravo Putin, ti benedico per la gloria di Dio nostro Signore e la Russia patria nostra!» disse Rasputin con voce potente, e alzatosi in piedi benedisse il ragazzo con il segno della croce: «Vai con Dio, figlio mio!».
Con l’inizio della Grande Guerra la Russia intera si mobilitò per sostenere il proprio esercito, e il corso della vita mondana si ridimensionò notevolmente. Gli uomini partirono per il fronte, le città si svuotarono, molte attività dovettero chiudere. Spiridon venne arruolato in fanteria e partì, mentre la sua famiglia, come abbiamo detto, si trasferì a Pominovo, in campagna, dove era più facile sopravvivere. Durante la guerra, impressionato dalle disumane condizioni di vita in trincea, Spiridon si avvicinò all’ideologia comunista, che faceva presa sui soldati con i suoi ideali di giustizia sociale e di uguaglianza, e decise di entrare nella nascente organizzazione comunista occupandosi di diffondere manifesti di propaganda fra le truppe, un’attività clandestina che nell’esercito zarista veniva punita con la fucilazione.
Un giorno, durante una missione, Spiridon si trovò quasi faccia a faccia con un soldato austriaco e, un attimo prima che costui potesse sparargli, imbracciò il fucile e fece fuoco, ferendolo alla spalla. Ma quando vide il nemico a terra urlante per il dolore, Spiridon gli si avvicinò per medicarlo, aiutandolo poi a tornare verso le proprie trincee. In segno di gratitudine l’austriaco gli baciò la mano e lo abbracciò. Secondo Vladimir Putin questo episodio rivela l’animo del nonno, uno spirito contadino che ragionava al di fuori degli schemi e degli odi che dividevano il mondo, e che sapeva vedere l’umano persino in quel nemico che qualche attimo prima avrebbe potuto e voluto ammazzarlo.
Tornato dalla guerra, e dopo aver partecipato attivamente alla Rivoluzione bolscevica, lo chef Putin divenne responsabile della cucina nella villa in cui abitavano Lenin, la moglie Nadejda Krupskaya e la sorella di lui, Maria. La famiglia di Lenin amava i piatti di Putin: non c’è quindi da stupirsi se dopo la morte dell’“insostituibile leader del proletariato internazionale” Spiridon fu trasferito in una delle ville di Stalin, a cucinare per il “padre di tutti i popoli” Iosif Vissarionovich. Alla morte di quest’ultimo, al potere arrivò una nuova schiera di leader, primo fra tutti il segretario generale Nikita Krusciov, noto per aver denunciato il culto della personalità del “baffuto” e le disumane repressioni che avevano scosso il paese, tacendo però il fatto che durante il periodo stalinista lui stesso aveva partecipato alla compilazione delle liste dei cittadini destinati alla fucilazione…
Spiridon, ormai anziano, venne trasferito al suo nuovo e ultimo posto di lavoro: la casa di riposo del comitato cittadino del Partito comunista di Mosca, immersa nei boschi vicino alla città di Ilinsk. Qui, a visitare il nonno, arrivava spesso anche il nipote di Spiridon, ovvero il nostro piccolo Vladimir. I vecchi “ingranaggi del sistema”, come venivano chiamati i funzionari del partito ormai in pensione, erano contenti delle visite del ragazzo e giocavano con lui, iniziandolo alle strategie degli scacchi. Quando, molti anni dopo, un programma televisivo dedicato alla vita del presidente Putin rivelò questo piccolo retroscena della sua infanzia, subito la cosa diede spunto a una serie di battute e ironie, e anche sul web fiorirono caricature e barzellette di ogni genere, delle quali almeno una merita di essere citata, per la sua sottigliezza. Diceva così: il piccolo Putin va a trovare il nonno nella casa di riposo per i funzionari del Partito comunista. Lì, uno di loro gli offre una partita a scacchi. A un certo punto, dopo aver dato scacco matto all’avversario, il ragazzo nota che costui continua tranquillamente a giocare. «Ho fatto scacco!» protesta Putin offeso. «Secondo le regole, lei deve eliminare il suo re: ho vinto!» «Sei ancora piccolo» risponde il vecchio con un misterioso sorriso «e non conosci la regola più importante.» «E quale sarebbe questa regola?» chiede il ragazzo, incuriosito. «La regola è che un vero politico inventa da sé le regole del gioco.»
Nonno Spiridon e nonna Olga crebbero sei bambini: quattro maschi e due femmine. Tutti i maschi combatterono nella Seconda guerra mondiale, e due caddero sui campi di battaglia. Il futuro padre del presidente Putin venne ferito durante un’azione, tanto gravemente da essere in seguito certificato come invalido. Solo uno dei fratelli, Aleksandr, tornò illeso: partito al fronte come soldato semplice, era arrivato fino alla conquista di Berlino ottenendo nel tempo molte decorazioni e il grado di tenente, e dopo la guerra insegnò nel collegio militare di Ryazan.
Una delle future zie di Vladimir, Lyudmila, durante la guerra lavorò in una fabbrica di armi a Jukovski, poco lontano da Mosca, dove poi si sposò e rimase a vivere: la sua, probabilmente, è stata la vita meno turbata dagli orrori del conflitto. Ben diverso il destino della sorella maggiore, Anna, che durante l’invasione nazista venne catturata e portata in un campo di concentramento sorto sul territorio dell’attuale Lettonia, e si salvò dallo sterminio solo perché una famiglia tedesca che all’epoca gestiva una delle grandi fattorie della zona scelse lei e il suo bambino come schiavi. Dopo la guerra, “zia” Anna e suo figlio si trasferirono a Petergof, dove lei trovò lavoro in ferrovia. Anna era spesso ospite della famiglia di Vladimir e Maria, e fin da bambino il futuro presidente russo apprese dai racconti di lei l’orrore dei campi di concentramento nazisti. Questo impresse un segno duraturo nella sensibilità di Putin, che già durante il primo incarico presidenziale ebbe duri scontri con la presidentessa della Lettonia, Vaira Vike-Freiberga, la quale, impegnata a ripulire l’immagine storica del proprio paese di fronte alla comunità internazionale, cercava di dimostrare come i campi di concentramento nazisti sorti in Lettonia durante la Seconda guerra mondiale fossero diversi da quelli tedeschi, perché i prigionieri venivano trattati con più “umanità”, e anzi a suo dire lo scopo dei campi lettoni era legato alla necessità di “rieducare” le persone, non di sterminarle. A causa di queste sue posizioni, sulla presidentessa si abbatté in più occasioni l’ira di Putin, che in tutti i discorsi legati a questo tema raccontava episodi delle esperienze vissute dalla zia e dal cugino quando si trovarono sottoposti all’“innocente” rieducazione nazista.
A questo proposito bisogna evidenziare un particolare che ha reso Putin simpatico a gran parte dei cittadini russi e dei paesi limitrofi, coloro che per motivi culturali appartengono al mondo russo pur non essendo cittadini della Federazione: con Putin, nella grande politica è entrato non solo un funzionario, un professionista che ricopre un determinato ruolo pubblico, ma anche e soprattutto un uomo che non ha timore o vergogna di tirare fuori aspetti personali di fronte al mondo intero. Putin, grazie alla sua capacità di comunicazione “selettivamente aperta”, ha dato subito l’impressione di essere una persona estremamente sincera, conquistando i cuori e le menti del suo paese nonostante le molte difficoltà con le quali ha dovuto scontrarsi durante i primi anni del suo incarico, e nonostante le molte pagine buie della sua biografia.
All’inizio del secolo scorso ogni individuo rappresentava una preziosa risorsa per la sopravvivenza della comunità: per questo le famiglie erano vaste e numerose, e una “corte”, come si chiamavano nella campagna russa le case dei contadini, poteva ospitare fino a venti persone. Anche i genitori di Putin avevano un’infinità di parenti: sia quelli della madre, che portavano il cognome di Shelomov, sia quelli del padre, i Putin, erano parecchi e sparsi in tutta la regione di Tver’, a Mosca e San Pietroburgo. Vladimir Putin in gioventù conosceva poco la propria storia familiare: i suoi genitori non ne parlavano volentieri, forse perché, dopo la guerra che aveva devastato il paese, regnava una grande confusione; molte persone erano rimaste uccise ma molte altre ancora erano scomparse senza lasciare traccia, e per tanta gente già martoriata da quegli anni atroci era troppo doloroso dedicarsi alla ricerca dei parenti e alla ricostruzione dei loro destini. In questo i Putin non erano molto diversi da tanti altri cittadini sopravvissuti al conflitto mondiale, che cercavano di godersi la pace in tutta la sua semplicità per quanto possibile, portando sempre nei cuori il terrore di una nuova guerra.
Le radici familiari dei Putin sono state rintracciate grazie alla curiosità dei giornalisti e all’ausilio della chiesa del villaggio degli antenati del presidente. È nei registri della chiesa, infatti, che si sono conservate tracce di battesimi, matrimoni e funerali che riguardano la famiglia e che risalgono all’inizio del Settecento. Vladimir Putin è molto fiero di questo particolare, tanto che durante un incontro con alcuni giornalisti americani lo ricordò in modo tagliente: «Le origini dei Putin risalgono ai tempi dello zar Pietro il Grande, che visse trecento anni fa. A quei tempi gli Stati Uniti non esistevano ancora: forse in questo consiste la nostra principale differenza».
I genitori di Putin trascorsero l’infanzia e l’adolescenza nel periodo forse più tumultuoso della storia della Russia moderna. Erano nati durante l’agonia della Russia zarista, mentre il paese, arretrato tecnologicamente e politicamente, governato da un’amministrazione obsoleta e corrotta, fondato su princìpi in gran parte risalenti a visioni medioevali del mondo e della società, andava a impantanarsi drammaticamente nella Grande Guerra, costretto a misurarsi con i paesi occidentali, ormai più progrediti sotto tutti i punti di vista. La crisi d’identità che la Russia attraversò in quegli anni fu il fertilizzante di una lunga serie di estremismi che fiorirono sul suo territorio lungo tutto il Novecento.
Bambini durante i tempi bui della Rivoluzione bolscevica, i futuri genitori del presidente raggiungevano l’adolescenza mentre fuori dalle loro case tuonava una terrificante guerra fratricida che inceneriva città e villaggi. Poi, con la nascita del nuovo stato sovietico si scatenò una carestia senza precedenti, destinata a rimanere nella memoria popolare come una specie di evento mitologico, vissuto dalle persone semplici e timorose di Dio come la punizione biblica che si abbatteva sulle teste dei russi per aver tradito i valori della monarchia…
Forse dunque non c’è da stupirsi se, proprio nel pieno delle sanguinose repressioni staliniste nei confronti dei cittadini sospettati di ostilità verso il regime comunista, quando nel paese regnava il silenzioso terrore che corrompeva anche le anime più forti, i due giovani innamorati riuscirono comunque a condividere una visione positiva e costruttiva del proprio futuro: erano ormai temprati.
Dal canto suo Vladimir, il padre del presidente, era un comunista convinto e rappresentava anzi un perfetto prodotto della nuova ideologia del proletariato sovietico. Tuttavia, nonostante la sua cieca fede nelle idee del bolscevismo che negava tutte le altre forme di religione, “oppio dei popoli”, la sua sposa lo convinse a celebrare il matrimonio anche in chiesa. Lui accettò anche perché, al di là dell’ideologia, contava la sua appartenenza alla cultura contadina, per la quale i riti hanno un’importanza vitale per l’unione della società e rappresentano un collante nel processo di formazione della coscienza comune. Il matrimonio si tenne così nella chiesa del paese, ma in segreto, per evitare denunce alle autorità sovietiche da parte di qualche vicino troppo “zelante”.
Poi gli sposi decisero di trasferirsi a Leningrado. Correva l’anno 1932, nell’URSS era entrato in vigore il sistema d’identità centralizzato e dunque il passaporto sovietico valido in tutte le Repubbliche: finalmente, la...