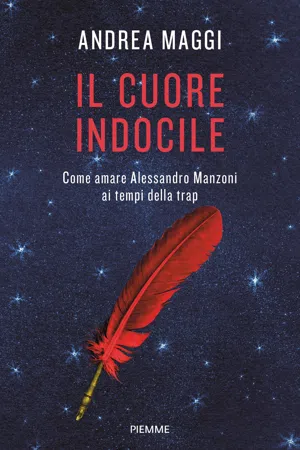Le madri di oggi sono apprensive, ansiose e ossessive, specie coi figli maschi. Non a caso, il maschio italiano, in generale, resta un mammone vita natural durante. Ed era lo stesso anche ai tempi di Manzoni. Da quando Giulia Beccaria si ricongiunge a suo figlio, si dedica completamente a lui. La donna si trova peraltro in una circostanza molto particolare. Nel primo periodo che i due trascorrono insieme, mamma Giulia parla continuamente ad Alessandro del suo amato Carlo Imbonati, ritraendoglielo in un modo un tantino idealizzato. A furia di sentirne decantare le lodi, Alessandro finisce per disperarsi per non averlo conosciuto e, soprattutto, per non aver potuto beneficiare di una figura paterna di tale levatura.
Affascinato dalla bellezza spirituale e dalla purezza di quest’uomo che sua madre ha amato con tutta se stessa, il giovane Manzoni compone il celebre carme In morte di Carlo Imbonati. Per noi questo Imbonati sarebbe un perfetto signor nessuno, se non fosse che dapprima gli fu precettore Giuseppe Parini, che gli dedicò l’ode L’educazione, e che successivamente, divenendo l’amante di Giulia Beccaria, esercitò un influsso postumo nientemeno che sul giovane Manzoni. Quel che ci importa di Carlo Imbonati è ciò che di lui scrive Alessandro, che con quel carme si cimenta nella poesia cimiteriale allora tanto di moda. Non dimentichiamo che il grande Ugo Foscolo di lì a poco avrebbe dato alle stampe il celebre Dei sepolcri.
Come si può notare, Manzoni ha appena passato i vent’anni, ma in fatto di letteratura è sempre sul pezzo. Il suo è un istinto naturale e in molti se ne sono accorti, non solo i suoi corrispondenti di sempre, tra cui Vincenzo Monti, che segue i suoi progressi con estremo interesse, ma adesso iniziano a lodarlo anche i francesi. Il ragazzo ha l’X Factor e promette bene. Proviamo a immaginare quale effetto deve aver sortito il successo, oggi si direbbe di critica e di pubblico, di quel carme su mamma Giulia, immaginiamo come dev’essersi commossa dopo aver letto la dedica: «A Giulia Beccaria – sua madre». Immaginiamo le lacrime materne di commozione nel leggere il carme scritto da quel figlio che adesso tutti adorano, e il pianto di gioia di Alessandro nell’udire la madre singhiozzare mentre legge i versi che le fanno riaffiorare i ricordi del più grande amore della sua vita. Devono essere stati momenti indimenticabili per Alessandro. Quella madre da cui si era sempre sentito abbandonato adesso lo adora incondizionatamente. Sembrano tanto Ghali e sua madre.
Di nuovo Ghali. Cosa c’entra, mi chiedete? C’entra. E molto anche. Poco fa scrivevo: non è un caso se fin da piccolo Lisandrino si cimentò nella stesura di sonetti e odi, come non è un caso se Ghali nell’approcciarsi alla musica si sia dedicato alla trap.
Piaccia o non piaccia, Ghali sa come arrivare al suo pubblico. Lo fa attraverso un genere in voga tra i più giovani, la trap, raccontando il suo vissuto personale. Dai testi che scrive, soprattutto quelli dei brani risalenti all’inizio della sua carriera, racconta di un’infanzia travagliata, di povertà e di violenza, di un padre in galera. Lui, italiano di origine tunisina, nato e cresciuto nella Milano suburbana, canta di un’infanzia trascorsa in un ambiente ostile e di un unico punto di riferimento nella sua vita, quello di sua madre. Vi ricorda qualcuno? A me sì.
Nella canzone Ninna nanna Ghali canta:
Nuba, nuba, nuba, vedo jnoun
E la mia bolla che diventa igloo
E un occhio nero che diventa blu
E il dito medio che rimane su
Uoh uoh uoh, bella!
Sono uscito dalla melma
Da una stalla a una stella
Compro una villa alla mamma.
Con la differenza che la villa mamma Giulia Beccaria già ce l’aveva (ereditò quella a Brusuglio da Carlo Imbonati), praticamente Ghali canta l’infanzia di Lisandrino: la bolla entro cui ha vissuto nel casale della Costa con la balia e poi in collegio, l’occhio nero e il dito medio (chissà quante volte anche Lisandrino si sarà preso a botte con i compagni per quei codini tagliati!) e poi l’uscita dalla «melma», il trasferimento in Francia e la rappacificazione con la madre. Alessandro compone odi, sonetti e in seguito anche carmi imitando lo stile dei suoi idoli, come fanno tutti i giovani all’inizio; ma i talenti si distinguono dai mediocri perché alle loro fonti d’ispirazione aggiungono qualcosa di originale. È il caso di Ghali nella trap, come è il caso di Manzoni nella lirica.
In morte di Carlo Imbonati è di sicuro l’opera più originale della sua giovinezza, tuttavia contiene ancora i residui della tradizione letteraria in voga che non lasciano completamente soddisfatto l’autore, poiché egli vuole trovare uno stile tutto suo, la sua strada, unica e inimitabile. È questo che fanno i grandi. Non vuole rimanere l’emulo di questo o di quell’autore. Non vuole che, leggendo le sue opere, i lettori lo classifichino come un neoclassicista qualunque. Vuole creare un “marchio di fabbrica” dove poter apporre solamente la propria firma e quella di nessun altro. Per quanto il carme gli sia valso persino le lodi di Ugo Foscolo, al tempo l’astro più splendente nel firmamento dei letterati di lingua italiana, Manzoni non è del tutto soddisfatto. Al contrario, è profondamente tormentato. Inquieto, ecco, questo è il termine che mi piace di più.
Come tutti i geni, non spreca il suo tempo adagiandosi sugli allori; piuttosto, un successo non lo induce a insistere sulla strada tracciata, ma lo stimola a tentarne altre più nuove, ripartendo sempre daccapo. Eppure, continuando a scrivere secondo le tendenze del momento, si aggiudicherebbe il favore del pubblico in quattro e quattr’otto. Ma a Manzoni il favore del pubblico interessa relativamente. Il suo sogno non è quello di essere apprezzato dai suoi contemporanei. Alessandro, anche se solo ventenne, vuole trovare la sua strada in campo letterario, la formula che gli consenta di scrivere un’opera fuori da tutti gli schemi convenzionali e talmente eccelsa da essere amata e apprezzata per sempre. Ecco perché il successo immediato non gli interessa. Certo, il suo è un progetto pazzesco, ma Lisander è fatto così. «O victoria o muerte!» griderebbe il comandante Ernesto “Che” Guevara.
Il tormento, i disturbi e le nevrosi di cui Alessandro soffre sin da giovane hanno origini molteplici, ma in parte derivano anche da questo suo genio letterario che lo stimola senza tregua per trovare la sua espressione più compiuta. Lo sforzo creativo in cui è perennemente impegnato, i suoi continui arrovellamenti sullo stile e sulle tematiche gli procurano un frustrante stato di insoddisfazione.
Ma con il carme In morte di Carlo Imbonati Manzoni, pur padroneggiando egregiamente la materia neoclassicista in voga al suo tempo, ci ha messo anche del suo. In opposizione a un Carlo Imbonati, ritratto come l’uomo puro e perfetto che se n’è andato troppo presto, vi è un mondo corrotto che indigna Manzoni tanto quanto lo indignavano le percosse e i maltrattamenti dei padri somaschi. Alessandro nella sua giovinezza matura un’ammirazione viscerale per la virtù e un’insofferenza assoluta per ogni sorta di vizio e di ingiustizia. Come tutti i giovani è un idealista, di conseguenza prova un enorme sdegno nei confronti dei corrotti che soggiogano gli innocenti. Si aggrappa con tutte le forze alle figure che simboleggiano la rettitudine e le allegorizza nelle sue opere. Ne I promessi sposi, per esempio, la purezza è incarnata da Lucia, mentre la rettitudine dal cardinal Federico Borromeo. Nel carme il giovane Alessandro fa dire le seguenti parole all’Imbonati:
Cui, di maestro a me poi fatto amico,
con reverente affetto ammirai sempre
scola e palestra di virtù. Ma sdegno
mi fero i mille, che tu vedi un tanto
nome usurparsi, e portar seco in Pindo
l’immondizia del trivio e l’arroganza,
e i vizj lor; che di perduta fama
vedi, e di morto ingegno, un vergognoso
far di lodi mercato e di strapazzi.
Stolti! Non ombra di possente amico,
nè lodator comprati avea quel sommo
d’occhi cieco, e divin raggio di mente,
che per la Grecia mendicò cantando.
Il «maestro» a cui fa riferimento è Giuseppe Parini, mentre «quel sommo d’occhi cieco» sarebbe nientemeno che Omero. Entrambi vengono portati a esempio di virtù e rettitudine nonché di poeti divenuti grandi senza aver mai sentito la necessità di dover scendere a compromessi con la corruzione del mondo.
Il giovane Alessandro prova disgusto per le bassezze in cui l’animo umano spesso sprofonda e non lo nasconde, anzi, lo dichiara con «giovenil furore», avrebbe detto Ariosto, a costo di farsi addirittura dei nemici. A Lisander importa poco di scontentare qualcuno; è giovane, ispirato da sani principi e non ha paura di niente. Sente di essere dalla parte del giusto, perciò niente lo può fermare. Non sopporta in nessun modo le bassezze, come accade ai ragazzi puri di cuore di tutte le epoche. Con questo carme si è manifestato a pieno un sentimento importante, quel moralismo di Manzoni che poi evolverà in una filosofia più complessa, che ritroveremo in tutte le sue opere. Questo è solo un primo passo e Alessandro sa molto bene che c’è ancora molta strada da fare.
In più di un’occasione scrive ai suoi corrispondenti di sentirsi scontento per le sue opere, sebbene riceva lodi sperticate da destra e da sinistra. Insomma, il nostro giovane autore ha un animo irrequieto: più piace, meno è soddisfatto. Un po’ come Lucio Battisti, che alla fine non sopportava le sue canzoni di maggior successo poiché le giudicava troppo orecchiabili; nient’altro che melodiose furberie piacione, insomma. E in parte il buon Lucio, a mio modestissimo e opinabilissimo parere, aveva ragione, come aveva ragione il giovane Alessandro, a cercare con ostinazione la propria strada senza lasciarsi abbindolare dai bagliori del momentaneo consenso che riscuoteva. Manzoni stava diventando pop; ma dentro di lui si agitava un’anima rock. Aveva ben chiara una cosa: quello che aveva scritto fino a quel momento sarebbe stato in grado di scriverlo anche un altro bravo autore del suo tempo. Lui che non era solo bravo, ma che era un grande, cercava con smania irrefrenabile quello che nessuno tranne lui sarebbe stato in grado di scrivere. Ma di strada ne doveva fare ancora il ragazzo.
A Parigi Alessandro si trova nella capitale della cultura europea. A quel tempo tutti quelli che contano sono a Parigi e ciò che non passa per di là di rado è tenuto in considerazione. Alessandro, poi, è il nipote di quel Cesare Beccaria che gli illuministi francesi hanno amato smisuratamente. Grazie al cognome di sua madre, appena ventenne viene introdotto e apprezzato nei salotti parigini più importanti, uno su tutti quello della vedova del marchese, matematico, filosofo nonché rivoluzionario Condorcet. Quello in particolare è un ambiente decisivo per il destino di Alessandro, poiché tra le personalità che vi gravitano c’è qualcuno che diverrà un riferimento per Manzoni, almeno fino a un certo punto, Claude Fauriel, il convivente della vedova Sophie Condorcet. Tra Alessandro e Fauriel nasce un’amicizia profonda e significativa, destinata a consolidarsi nel tempo, che sarà mantenuta anche a distanza attraverso un intenso scambio epistolare. In una delle sue lettere, Alessandro manifesta a Fauriel il suo pensiero sulla lingua letteraria italiana, che definisce morta, in quanto distante da quella parlata.
Ed è perciò che gli scrittori non possono produrre l’effetto che eglino (m’intendo i buoni) si propongono, d’erudire cioè la moltitudine, di farla invaghire del bello e dell’utile, e di rendere in questo modo le cose un po’ più come dovrebbero essere.
Mentre scrive queste righe, Alessandro sta maturando il proposito di comporre opere in lingua italiana che siano di alta levatura letteraria, ma che abbiano anche una funzione sociale e, per questo, non si rivolgano soltanto a un’élite colta. Si tratta di una rivoluzione letteraria vera e propria e non è poca cosa da fare in Italia al tempo di Manzoni, quando non esiste nemmeno una lingua nazionale, ma soltanto una lingua letteraria. Una rivoluzione analoga nel campo del rap è stata compiuta nel 1992 da Frankie hi-nrg mc, quando fece uscire il suo primo brano singolo, Fight da faida. È un rap unico nel suo genere, poiché dimostra un intenso impegno politico contro la mafia proprio nell’anno delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, graffiante e duro, ma lontano dai toni militanti e antagonisti di altri artisti impegnati politicamente di quel tempo, come ad esempio i 99 Posse. Il linguaggio di Frankie è raffinato ma graffiante, ricercato ma accessibile, misurato ma viscerale allo stesso tempo. Denota una notevole padronanza delle figure retoriche di suono, di cui l’autore si serve sapientemente per enunciare lo sdegno e la rabbia che anima tutto il pezzo. Si veda a titolo di esempio soltanto questo brevissimo passaggio:
Uomini con anime sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbiose oltre ogni limite
dove sono presenti la paronomasia lamine/anime, che aggiunge enfasi alle anime taglienti (dei mafiosi), e l’assonanza crimine/limite che infiamma l’indignazione degli oppressi. Con i suoi versi fluidi e potenti come la corrente di un fiume in piena, Frankie hi-nrg mc arriva diretto a tutti i suoi ascoltatori, dai più ai meno colti. Una vera bomba che esplode nell’universo rap italiano nel 1992, e che sbaraglia tutta la concorrenza, come accadde per Manzoni nel campo della letteratura. Frankie hi-nrg mc realizzò anche una versione hard rock di Fight da faida, prendendo spunto sicuramente da un altro brano dal titolo Bring the Noise dei Public Enemy (del 1987), che nel 1991 il gruppo rap afroamericano ripropose in una versione che definirei hard boiled con la collaborazione degli Anthrax, una delle più grandi band thrash metal, e che diventerà una pietra miliare della storia della musica che chiamare “leggera”, se avete mai ascoltato gli Anthrax, a dir poco è improprio.
Tornando alla ricerca linguistica di Manzoni, il problema – lo sottolinea chiaramente nella sua lettera a Fauriel – è che nel territorio italiano esiste una distanza incolmabile tra la lingua letteraria e quella parlata. L’Italia non è ancora uno stato nazionale, la lingua italiana semplicemente non esiste, come invece esiste quella francese. Manzoni avverte la necessità di un rinnovamento linguistico in letteratura per far sì che le sue opere siano in grado di trasmettere virtù e principi morali se non a livello di massa, per lo meno in modo più ampio. Da qui parte l’inizio di un lavoro faticoso sulla lingua, che approderà al capolavoro I promessi sposi. Ma gli ci vorranno più di vent’anni.
Il giovane Alessandro vive in un mondo pieno di cose che non gli piacciono. Dentro di sé ha maturato un rifiuto per i sistemi educativi troppo rigidi, avendo s...