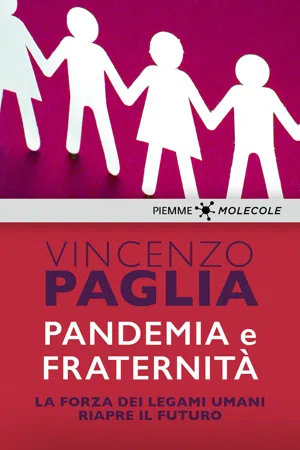
- 64 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La pandemia ci ha ricordato che come individui siamo fragili, e vulnerabili sono la società, le strutture e le sovrastrutture che abbiamo costruito per difendere la nostra vita e i nostri privilegi. Se la pandemia riguarda tutti, allora la risposta migliore è concertata e globale. Nella riflessione del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, fraternità e solidarietà non sono solo valori cristiani, ma le fondamenta sulle quali poggia la sopravvivenza dell'umanità.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Pandemia e fraternità di Vincenzo Paglia in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Theology & Religion e Faith & Lived Religion. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Theology & ReligionCategoria
Faith & Lived ReligionI. L’oggi
1. Umanità e solidarietà. Covid-19 e noi
Una globalizzazione che, lasciata alla sua dinamica spontanea, tende ad accrescere e approfondire le disuguaglianze, sollecita un profondo ripensamento etico del legame sociale. Dobbiamo affermare con forza che, senza l’adeguato sostegno di una concezione cooperativa della vita umana, nessuna regolazione puramente giuridica e nessun ausilio tecnico potranno, da soli, garantire condizioni e contesti relazionali corrispondenti alla dignità della persona.
L’emergenza suscitata dal Covid-19 – è chiaro per tutti, ormai – si sconfigge anzitutto con gli anticorpi della solidarietà. I mezzi tecnici e clinici del contenimento devono essere integrati da una vasta e profonda complicità con il bene comune, che dovrà contrastare la tendenza alla selezione dei loro vantaggi per i privilegiati e alla separazione dei vulnerabili in base alla cittadinanza, al reddito, alla politica, all’età. In caso contrario, la dignità della persona andrà persa insieme alla preziosità dei suoi affetti. La scienza non deve cedere al sovranismo o alla pressione politica; la scienza deve allearsi con la solidarietà e l’umanità. Viviamo in tempi in cui nessun governo, nessuna società, nessun tipo di comunità scientifica deve considerarsi autoreferenziale.
Come diceva papa Francesco nel 2018 alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita – parole che oggi dobbiamo riscoprire – la «bioetica globale ci sollecita dunque alla saggezza di un profondo e oggettivo discernimento del valore della vita personale e comunitaria, che deve essere custodito e promosso anche nelle condizioni più difficili». Quanto sarebbe importante che le decisioni dei governi – penso all’Europa, ma non solo – si prendessero in maniera coordinata. È urgente, direi indispensabile, un tavolo comune.
Nei tempi del Covid-19, l’altro è il mio alleato: oppure la comunità evapora e io stesso sono perso. L’altro è la persona che cammina e mi saluta a un metro di distanza perché tutela me e se stesso; e anche io stando in casa e rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie, agisco in favore del bene comune, per fare in modo che tutti insieme e il prima possibile usciamo dall’emergenza. Non dobbiamo dimenticare l’esperienza di queste settimane difficili e il significato profondo delle limitazioni al muoversi: ci sacrifichiamo per noi stessi e per gli altri.
Ora appare chiaro che questo obiettivo non è affatto il semplice effetto di un algoritmo degli interessi e di un calcolo dei vantaggi. Esso comporta il potenziamento di una logica sociale dell’affezione reciproca, che il cristianesimo, fin dalle sue origini, ha concepito come fraternità universale e ha interpretato come prossimità responsabile fra tutti gli esseri umani. Per i cristiani è un’indicazione di comportamenti che è impressa a caratteri di fuoco nella scrittura evangelica.
Ci sono sembrate metafore di buoni sentimenti, invece vanno prese alla lettera come puri e semplici fondamenti della vita comune: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato… Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 25, 35-40). La fraternità indicata dal Vangelo si può moltiplicare con molti altri passaggi e messaggi diretti di Gesù. Ma per noi oggi, credenti e non credenti, è il momento di compiere un passo in avanti: siamo interconnessi, il mondo è interconnesso e prima riusciamo a comprenderlo, prima saremo una vera comunità globale riunita sotto il segno della fraternità. È un messaggio per tutti: per gli scienziati, i ricercatori, i politici, gli imprenditori, i “nuovi ricchi” e i “nuovi poveri”, tutte le persone di ogni fede e appartenenza politica, sociale, culturale. Il sacrificio che stiamo compiendo ci indirizza sulla strada della solidarietà e della fraternità tra tutti gli esseri umani, senza distinzione. Tocchiamo con mano san Paolo nella Lettera ai Galati: «Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal. 3, 28).
Va intrapresa con decisone la promozione di una visione di “bioetica globale”. La vita si difende e si sostiene riaffermando e agendo in modo che sia potenziato il diritto di ciascuno a un’esistenza degna. E la sfida è cruciale: dobbiamo essere capaci di attrezzarci, anche culturalmente, per trasformare la nostra resilienza in un’opportunità epocale, che ci persuada, una volta per tutte, della necessità di prendere congedo da uno stile individualistico, inospitale e anaffettivo, dei nostri legami affettivi, economici, politici e istituzionali.
La scoperta dell’individuo, propria della modernità e uno dei cardini della stessa democrazia, in realtà, con il potenziamento dell’esclusivo interesse personale ci è sfuggito di mano. Dobbiamo riconoscerlo. Nato come sacrosanta affermazione del valore inviolabile della persona e dell’integrità dei suoi diritti, ha finito per aggredire ed erodere la qualità dei rapporti che rendono bella la vita comune, arricchendo l’umanità dei singoli e scongiurando l’abbandono dei più deboli. L’individualismo, inteso come autodeterminazione e auto compimento, ha portato a una tristissima solitudine divenuta una vera e propria epidemia. L’individualismo ha finito per rendere liquidi ed evanescenti i doveri corrispondenti alla responsabilità delle relazioni che edificano la comunità. La qualità della convivenza è un bene indivisibile: per essere goduto da tutti deve essere responsabilmente condiviso. Il papa ha scritto nell’enciclica Laudato si’: «È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da noi stessi verso l’altro. Bisogna liberarsi dalla coscienza isolata e dell’autoreferenzialità». Ha aggiunto: «Quando siamo capaci di superare l’individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società». Una conversione. Quando si supera l’individualismo, si può cambiare la società. Lo ha ribadito il 27 marzo dal sagrato, vuoto di persone e traboccante di umanità, della basilica di San Pietro, per la preghiera per il mondo: «Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti».
Negli ultimi anni, in Italia, in Europa e in Occidente, siamo stati incalzati dal tema politico della necessità di “immunizzare” il nostro benessere: non solo da ogni minaccia e aggressione, come è giusto, ma anche da ogni possibile forma di solidarietà e condivisione. L’ossessione immunitaria assume connotati quasi deliranti, giustamente stigmatizzati come derive antiumanistiche di una civiltà che arriva a ripudiare i fondamenti stessi della sua cultura civile. Come è delirante, ad esempio, porre l’età come unico e decisivo criterio di cura, di salvezza o di condanna che, ovviamente, relega gli anziani a essere di troppo. La diffusione del virus è una grande lezione: l’umanità si “difende” aprendosi alla vulnerabilità dell’altro, ci “difendiamo” proteggendo l’altro, in pericolo di vita.
Papa Francesco lo ha scritto nella Lettera Humana Communitas dell’11 febbraio 2019 – nel 25esimo dalla fondazione della Pontificia Accademia per la Vita – consegnandoci un mandato preciso: «Dobbiamo riconoscere che la fraternità rimane la promessa mancata della modernità. Il respiro universale della fraternità che cresce nel reciproco affidamento – all’interno della cittadinanza moderna, come fra i popoli e le nazioni – appare molto indebolito. La forza della fraternità, che l’adorazione di Dio in spirito e verità genera fra gli umani, è la nuova frontiera del cristianesimo».
Riaprire la frontiera della fraternità, la promessa mancata della modernità, dimenticata, è determinante per edificare il nuovo futuro delle nostre società. E senza dubbio la fraternità – il prendersi cura – è la nuova frontiera del cristianesimo di domani.
2. Prendersi cura di sé, della famiglia e del pianeta
Gli uomini e le donne dei quali ci sentiamo impegnati a prenderci cura sono tutte creature mortali. E da questo non le guariremo. Eppure, nulla è più universalmente qualificante e commovente della nostra quotidiana lotta contro i segni dolorosi di questa fragilità. Noi lottiamo strenuamente perché non sia l’avvilimento della morte a decidere il valore della vita. Lottiamo perché non sia una volontà egoista o segnata dalla tragicità dei fatti a determinare una nascita, né una malattia a decidere l’utilità di una vita, il valore di una persona, la verità degli affetti. Noi accettiamo la nostra condizione mortale. Resistiamo però all’illusione delirante di poter cancellare il mistero dell’esistenza umana, con i suoi dolorosi segni di contraddizione.
Il lavoro della cura è il nostro impegno a rendere umana questa accettazione, impedendole di diventare complicità. Insomma, noi ci rifiutiamo di fare il lavoro della morte: anche solo simbolicamente. Prendersi cura di una madre, di un padre, di un bimbo, di un anziano, significa aiutare ognuno ad accettare tutta la vita propria e altrui nel ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Pandemia e fraternità
- Introduzione
- I. L’oggi
- II. Verso il domani
- III. Nota della Pontificia Accademia per la Vita
- Copyright