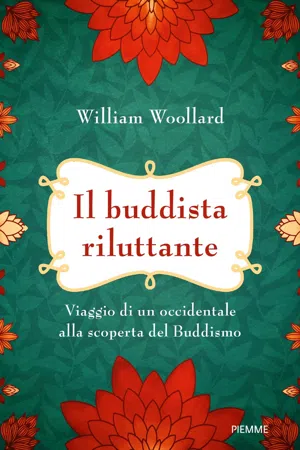All’origine della filosofia c’è lo stupore e così all’origine della scienza: stupore per i dettagli della vita quotidiana e per la vastità dell’universo all’interno del quale sboccia la vita. Al primo contatto con il Buddismo si prova lo stesso tipo di stupore: il Buddismo è pieno di sorprese e non si adatta a nessuno degli stereotipi che la maggior parte di noi acquisisce viaggiando o studiando. Non è una filosofia oscura o astratta e non è nemmeno passiva, scialba o monotona. È invece rivoluzionaria, impegnativa, attiva e sì, anche sorprendente. Educa soprattutto a rendere più ricchi e proficui gli elementi che compongono la vita quotidiana.
Ma questo lo dico dopo molti anni di pratica buddista. Ricordo bene il forte senso di alienazione che mi ispirò il Buddismo quando lo incontrai per la prima volta in Inghilterra: semplicemente non faceva per me, non volevo che entrasse a far parte della mia vita, non ne avevo bisogno. Non avevo il tempo per praticarlo ed ero convinto che non fosse in nessun caso adatto al mio stile di vita frenetico, per quanto il suo sistema filosofico fosse interessante.
Essendo vissuto e avendo lavorato per molti anni all’estero, nel sud-est asiatico e in medio oriente, tra buddisti, induisti e musulmani, conoscevo il fascino di gran parte del pensiero buddista e sapevo che bene si adattava al ritmo della vita locale in cui era nato e si era sviluppato per secoli.
Ma io non avevo bisogno di ulteriori impegni, semmai di maggiore disponibilità di tempo. Sapevo chi ero, e sapevo anche piuttosto chiaramente ciò che volevo dalla vita, ovvero più successo, più notorietà, più soldi, più tempo libero. Ero diventato dipendente dall’entusiasmo e dal ritmo offerti dalla carriera che avevo intrapreso: scrivere, produrre e presentare programmi televisivi. Ogni programma era tanto impegnativo e logorante quanto stimolante e gratificante, e il processo creativo era per me molto simile a una droga. Così abusavo del mio tempo e delle mie energie solo per tenere in vita quell’abitudine. Inoltre, poiché non volevo che quella sensazione finisse, mi accaparravo sempre più lavoro non appena se ne presentava l’occasione, anche se sapevo di averne già più che a sufficienza.
Lavorare in televisione, inoltre, comportava altri motivi per mantenere viva quella specie di dipendenza: un’ampia rete di conoscenze e relazioni stimolanti, oltre all’accesso a beni materiali in quantità superiore al comune.
Ero felice? Se me lo avessero chiesto probabilmente avrei glissato la domanda evitando di rispondere. Riuscivo a tirare avanti senza mai pormi il problema. Per anni ero stato profondamente infelice a causa della rottura del mio matrimonio, che avevo creduto essere molto forte e stabile e che per me era stato fonte di grande gioia.
Avevo sopportato stoicamente il dolore e avevo tirato dritto. Non conoscevo altro modo per gestire la sofferenza. Prendevo la vita come veniva, preoccupandomi per i problemi che mi poneva e cercando di godere il più possibile dei momenti belli. Vivere per me era come andare sulle montagne russe: a volte spaventano a morte e altre divertono e fanno scoppiare dal ridere. Ricordo che stavo particolarmente attento a non usare la parola “felicità” troppo spesso. Mi sembrava che qualunque cosa fosse la sensazione che tentavo di descrivere, fosse già svanita e passata non appena ne parlavo; ritenevo quindi fosse preferibile non dare etichette alle mie esperienze.
Anche se ero stato educato in un ambiente cristiano e anche se la mia vita era impregnata di valori cristiani, da tempo avevo rinunciato alla religione come a una fonte di aiuto o di supporto per i momenti difficili. Non sentivo il bisogno di alcun tipo di impalcatura religiosa a sostegno della mia vita. Le mie scelte erano essenzialmente materiali e razionali. Viviamo in un’epoca intellettuale e credevo, come fosse una verità assoluta, che il metodo migliore di affrontare problemi e difficoltà di qualsiasi sorta fosse quello razionale, analizzando dettagliatamente quegli stessi problemi e difficoltà, fino ad arrivare a una soluzione.
Non avrei mai ammesso neanche con me stesso che in alcuni casi era un compito semplicemente impossibile. Mi era capitato spesso di lambiccarmi il cervello invano, alla ricerca di una via d’uscita che non riuscivo a trovare. Ne risultava una profonda stanchezza spirituale – quella pesantezza che proviene dalla preoccupazione continua – oppure, in molti casi, una profonda frustrazione che poteva esplodere da un momento all’altro e abbattersi come un fulmine a ciel sereno su qualsiasi cosa a portata di mano. Quando le cose iniziarono ad andare male nella mia vita, mi ero guardato attorno per cercare qualcuno o qualcosa su cui far ricadere la colpa – il che aveva aperto la strada alla frustrazione. A quell’epoca venivo spesso definito come una persona irascibile e caustica, ma questo non mi sembrava una qualità negativa, anzi secondo me indicava la capacità di avere la meglio nelle discussioni. In più di una circostanza, durante le riprese in esterni, mi adoperavo perché fosse chiaro sin da subito chi comandava. Credevo che fosse l’unico modo per ottenere, con le risorse di cui disponevo a quell’epoca, la qualità e i risultati cui miravo. Sapevo che non era facile lavorare con me, ma mi ero convinto che la tensione che ne risultava era un prezzo relativamente basso da pagare per ottenere i risultati voluti.
Questo è in sintesi il William che incontrò il Buddismo grazie alla giovane donna che allora era la mia compagna. Sebbene lo considerassi del tutto inutile per la vita che conducevamo all’epoca, una volta entrato nella nostra esistenza, il Buddismo non accennava a scomparire. Sarah era molto attratta dagli insegnamenti buddisti, e iniziò ad andare a varie riunioni. Questo ebbe su di me un effetto significativo. Sostanzialmente passai dal semplice rifiuto all’ostracismo vero e proprio. Il Buddismo era diventato una vera e propria minaccia per la traballante stabilità che mi sforzavo di ricostruire dopo il dolore e il gran tumulto del divorzio. “Buddismo? Che me ne faccio?” pensavo.“Ho già abbastanza problemi così.”
Ma non era tanto facile. Rabbia ed esasperazione non erano sufficienti. Per assicurarmi che questo corpo estraneo fosse bandito e allontanato dalla nostra vita con motivazioni del tutto razionali, dovevo conoscerlo meglio. In poche parole dovevo studiare il Buddismo per essere in grado di controbatterne in maniera convincente le incongruenze, e dimostrare quanto fosse poco adatto o addirittura inutile per la nostra vita quotidiana.
Questo libro rappresenta il tentativo di sistematizzare tutto quello che è successo da allora.
Non in modo cronologico, però, perché non avevo all’epoca la percezione di aver intrapreso un viaggio. Solo se mi volto indietro adesso mi rendo conto della strada che ho percorso e di quali cambiamenti siano avvenuti nella mia vita. Non c’è mai stata una folgorazione che ha portato al cambiamento, né altro di simile. È stato un processo lento, sviluppatosi durante alcuni anni di discussioni, letture e litigi – ah quanti litigi! – di rifiuti e rivalutazioni. Non è stato affatto un percorso facile. Ero molto riluttante per tutta una serie di ragioni: non avevo bisogno della religione, e meno che mai di una religione così stravagante e palesemente estranea come il Buddismo; non volevo far parte di un gruppo specifico che potesse influenzare anche di poco quella che consideravo la mia personalità; soprattutto non credevo che la pratica buddista avesse un qualsiasi effetto duraturo sul modo in cui vivevo e su come percepivo la vita. Come avrebbe potuto? Come poteva una pratica così… strana e apparentemente senza senso, con il suo ripetitivo cantilenare, cambiare la mia vita dall’interno?
Eppure studiando, discutendo e litigando, scoprii che quasi tutto nel Buddismo aveva una logica. I valori di base erano chiaramente stimabili, tutti orientati a creare una società compassionevole, costruttiva, dedita alla creazione di valore, in cui vivere e allevare con serenità i propri figli. E potevo vederne gli effetti sulle persone che incontravo alle riunioni e ai seminari. Si sforzavano di essere ottimiste e intraprendenti nonostante i gravissimi problemi che stavano affrontando, e in più erano molto generose e incoraggianti nell’approccio con gli altri. Non c’era ombra di sgradevolezza né di caustico cinismo, atteggiamenti che si incontrano così frequentemente nella società di oggi.
Pian piano capii di essere arrivato a una fase cruciale della mia vita, uno di quei momenti difficili in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi, e in cui ci si rende conto di dover prendere quella che potrebbe rivelarsi una decisione definitiva.
È difficilissimo ottenere profondi cambiamenti nella vita. Anzi, forse è la cosa più difficile. Mi ritrovavo con una esistenza incanalata su una strada apparentemente ben definita, comoda, di discreto successo, e non percepivo in me alcun bisogno religioso. Eppure mi ero imbattuto in qualcosa che sembrava portare immensa ricchezza e maggiore spessore non solo alla mia vita personale ma anche a quella di coloro che mi vivevano attorno. Prendere coscienza di questa potenzialità non rese più facile la battaglia interiore.
Oggi mi capita di incontrare molte persone che sono esattamente nella stessa situazione. Cercano qualcosa di più per la loro vita, qualcosa di non ben definito, che viene espresso in modo altrettanto vago; ciò non di meno è qualcosa di reale e persistente. Incontro spessissimo persone del genere: si tratta di gente di tutte le età, giovani e anziani, per molti dei quali ciò che più conta è il possesso, l’avere tutto quello che si può desiderare. Ma, conoscendoli meglio, spesso si scorge una punta di malessere – niente di preoccupante, giusto la sensazione che manchi qualcosa. Qualcosa che sia in grado di offrire una dimensione più ampia e profonda di quella che possono dare il lavoro e il divertimento, o che può venire dal misurarsi con le preoccupazioni materiali che assorbono la maggior parte delle nostre giornate.
Al giorno d’oggi abbiamo tutti molto da fare, tanto da non riuscire a portare a termine tutto quello che ci sembra necessario; è facile avere la vita quasi completamente occupata da “sciocchezze”: impegni di tutti i tipi, spostamenti continui e rapidi tra riunioni, eventi, feste, o da un pub all’altro. Ma sicuramente siamo animali spirituali, anche se facciamo di tutto per convincerci del contrario. Il fisico e il materiale non ci bastano. Anche quella cantante che negli anni Ottanta cantava con grande convinzione e intensità:
«This is a material world
… and I’m a material girl»
ha cercato in seguito, la consolazione di una religione efficace.
Forse non molto tempo fa, quando la dimensione spirituale era appannaggio delle religioni che fungono da fondamenta alle diverse società del mondo, questa sarebbe stata la soluzione giusta anche per la maggior parte di noi, ma oggi non è più così, e la religione ufficiale non rappresenta più una valida alternativa. Sentiamo il bisogno di una profonda esperienza spirituale, ma sempre più spesso rifiutiamo la struttura e soprattutto il formalismo della maggior parte delle religioni. Per quanto strano possa sembrare, ritroviamo la dimensione spirituale più facilmente in quei libri – sempre più numerosi – esposti nel reparto delle librerie dedicato all’auto aiuto, che propongono vari consigli su come arricchire e approfondire la nostra vita, o darle una direzione più chiara. Come si spiegherebbe altrimenti il boom dei libri che pretendono di insegnarci a vivere?
Credo che i miei amici buddisti mi perdoneranno se affermo che in un certo senso il Buddismo ha il piede in entrambe le scarpe, nel senso che funge da straordinario collegamento. Ha lo spessore di un sistema filosofico ben strutturato, profondo e onnicomprensivo, ma è anche un vero e proprio “fai da te”. Infatti la vera essenza del Buddismo sta nell’insegnare a se stessi l’arte di vivere felicemente.
Sono molto consapevole di tutto ciò quando entro in contatto con degli estranei. Se si arriva a parlare di Buddismo, noto spesso un lampo di interesse nei loro occhi – vogliono sapere più di quello che può essere spiegato in una breve conversazione – ma allo stesso tempo c’è una sorta di riluttanza a essere coinvolti in qualcosa di apparentemente estraneo e fuori dal mondo come il Buddismo. Condivido pienamente quell’opinione. Nessuno vuol essere considerato strano dai propri amici; perlomeno questo era il mio caso. Sebbene siamo convinti di vivere in una società multiculturale, il tessuto culturale su cui è fondata l’Europa rimane il Cristianesimo occidentale. Anzi, questo vale anche per tutte le ex colonie europee sparse per il mondo, dalle Americhe all’Australia. Un tipico esempio di questa radicata eredità culturale è rappresentato da chi magari non va a messa da anni, ma è comunque perfettamente a proprio agio entrando in una chiesa alla ricerca di un momento di tranquillità o per l’improvviso bisogno di pregare un dio che non conosce. La stessa persona troverebbe molto più difficile, se non addirittura impossibile, entrare in un tempio buddista per recitare o meditare. Significa che alla maggior parte di noi occidentali la parola Buddismo non offre appigli familiari cui aggrapparsi, mentre il Cristianesimo, anche a chi non è veramente cristiano, ne fornisce a bizzeffe. Il solo menzionare il Buddismo suscita alla mente tutta una serie di vaghi stereotipi: una filosofia vasta, indistinta, occulta, senza confini precisi; immagini di templi nel sud-est asiatico che ospitano immense statue del Budda, monaci vestiti di arancione, o le ruote di preghiera tibetane.
Da qui la domanda che dà il titolo a questo capitolo, cosa intendiamo per Buddismo?
Il Buddismo e le altre religioni
Spesso si rende meglio l’idea di una cosa qualsiasi descrivendo quello che non è piuttosto che quello che è. Quindi, parlando di Buddismo, è più utile paragonarlo almeno in parte alle religioni che conosciamo meglio. Nel fare ciò mi preme sottolineare che in nessun caso intendo esprimere dei giudizi, solo delle osservazioni. Sono pienamente concorde con un’affermazione del grande storico e filosofo umanista Arnold Toynbee: «L’incompatibilità tra la visione buddista e quella giudaica della realtà non vuol dire che una delle due è falsa. Secondo me indica solo che ogni visione, essendo umana, è parziale e imperfetta».
Giusto.
Il Buddismo è ateo – o umanistico – nel senso che non prevede la figura di un dio creatore onnipotente comune invece a molte delle grandi religioni del mondo come il Cristianesimo, l’Islamismo, l’Induismo o l’Ebraismo. La forma precisa della natura divina varia ovviamente da una religione all’altra, ma in termini strutturali da una parte c’è Dio – o comunque una o più divinità responsabili della creazione che hanno quindi un ruolo importantissimo nella vita degli esseri umani – e dall’altra c’è tutta l’umanità. Le due parti, quella divina e quella umana – cioè noi – sono separate da un abisso invalicabile, perché è impensabile che gli uomini possano diventare divini. La comunicazione tra le due sponde di questo abisso avviene, almeno inizialmente, sotto forma di comandamenti dettati dalla divinità – regole da rispettare per vivere in modo corretto – e di preghiere, lodi o suppliche da parte delle persone. Lo scopo basilare della vita è stabilire il giusto rapporto con Dio, sia in termini di preghiera e ringraziamenti per il dono della vita, sia di suppliche per ottenere aiuto quando i problemi della vita diventano opprimenti. Ovviamente il concetto del Dio cristiano antropomorfico si è evoluto col passare dei secoli, ma alla base delle funzioni religiose cristiane c’è ancora la figura del padre divino che ha donato la vita agli esseri umani, tant’è che le preghiere funebri sottolineano che «il Signore dà la vita e il Signore la toglie».
Al contrario, l’umanesimo buddista affonda le sue radici nella vita dei comuni mortali. A volte viene definito umanesimo dinamico perché il suo scopo principale è quello di orientare la vita intera delle persone nella direzione più positiva possibile, ma soprattutto perché nega esplicitamente l’esistenza di una forza creativa al di fuori della vita stessa. Ne consegue che anche i Budda sono normali esseri umani. Possono essere straordinari per via della loro saggezza e della profondità delle loro intuizioni, o per la capacità di guidare gli altri, ma non gli si attribuiscono poteri o parentele divine, né dichiarano di avere una linea di comunicazione preferenziale con Dio. Al contrario, sottolineano sempre la loro normale essenza umana. Il Buddismo afferma che tutti gli esseri umani hanno latente dentro di loro la “buddità” – e latente è una parola chiave perché la buddità non ha niente a che vedere con la perfezione o con l’elevazione, ma è molto semplicemente descritta come una grande qualità, o strumento, che tutti abbiamo dentro di noi e di cui dobbiamo imparare ad avvalerci. Il Buddismo essenzialmente rafforza il potere della persona, insegnandole a usare tutte le risorse a disposizione, sia spirituali sia intellettuali, per creare valore tanto nella propria vita quanto in quella degli altri, e per aumentare, se così vogliamo dire, la somma totale di felicità.
Dall’umanesimo buddista ovviamente scaturiscono profonde implicazioni. Per esempio, poiché il Buddismo non ha a che fare con Dio o altre divinità, dobbiamo stare attenti a come usiamo o a come reagiamo ai termini “fede” e “preghiera” che si incontrano spessissimo negli scritti di tutte le religioni, Buddismo compreso. Non essendoci un dio in cui credere o a cui rivolgere le preghiere, in un contesto buddista queste due parole significano qualcosa di diverso.
Prendiamo come esempio il conflitto interreligioso, che è sicuramente uno dei problemi più scottanti e impegnativi della nostra epoca. Poiché non gli si può attribuire nessuna particolare definizione di divinità, il Buddismo non ha barriere e non esclude niente e nessuno. Nel Buddismo non esiste la barriera che separa la definizione islamica di divinità da quella cristiana, quella cristiana dalla giudaica o quella giudaica dall’induista. Include veramente tutto e in questo senso è un sistema filosofico di enorme portata. Arriva a includere il rapporto dell’uomo con se stesso, e poi con la società, il rapporto della società con l’ambiente circostante, e quello dell’ambiente con l’universo. Lo si potrebbe immaginare come una serie di cerchi concentrici che si irradiano dall’individuo, e si allargano fino a raggiungere gli angoli più nascosti dell’universo.
Il secondo tratto distintivo, se così vogliamo chiamarlo, che su di me ha avuto un grande effetto, è stato comprendere che il Buddismo non è moralista, nel senso che non ci sono dogmi o comandamenti stilati da una autorità esterna per stabilire come si deve vivere. Questa è una differenza fondamentale, perché siamo abituati all’idea che tutte le religioni abbiano una serie di regole comportamentali da osservare.
Per esempio il Cristianesimo ha i comandamenti, l’Islamismo e l’Ebraismo hanno rigidi codici che regolano p...