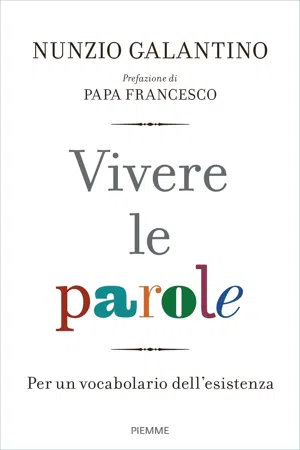![]()
![]()
Limite: parola e contenuti ricchi di un’affascinante complessità. Dal latino limes, connesso a limus, obliquo, e limen, soglia. Il Dizionario etimologico Rusconi fa riferimento a manufatti che è possibile ancora oggi incontrare, precisando che «i Romani chiamavano Limiti le pietre che segnavano i confini: erano sacre e non potevano rimuoversi essendo sotto la protezione di una divinità detta Limite o Termine…». Nasce quindi sotto il segno della sacralità questo termine e tale resta, con tutta la sua varietà di significati, quando si parla del limite in riferimento alla persona.
L’attualità sollecita l’inserimento di questa parola in un ideale dizionarietto di antropologia, ma a studiare questa attenzione è anche il filosofo Remo Bodei, il quale, nel suo ultimo saggio intitolato non a caso Limite, scrive: «Le religioni non stanno prendendosi la loro rivincita sulla modernità dal momento in cui gli Stati che la rappresentano non sono più in grado di tutelare in misura sufficiente la sicurezza e il benessere promessi ai propri cittadini, né di dare alle loro vite un senso più pregnante?»1. Senza entrare nei particolari di questo orizzonte interpretativo, pur molto documentato nel testo, mi sembra che quella che Bodei tende a vedere come la rivincita delle religioni sugli Stati è solo – ma non è affatto poco! – la capacità che alcune religioni hanno di considerare il limite come radice di apertura.
Come d’altra parte avviene in un corretto orizzonte antropologico: il concetto di limite non è mai immediatamente risolvibile in quello di imperfezione. Anzi, una consapevole accettazione del limite apre la strada ed è capace di alimentare il fascino delle frontiere. C’è chi addirittura ha teorizzato, come lo psicoterapeuta Ricardo Peter, un’esplicita «antropologia del limite»2. A sostenerla teoricamente viene posta l’accoglienza del limite come inizio del desiderio di apertura verso l’oltre, se non proprio come esplicito segno della nostalgia dell’Altro.
Dietrich Bonhoeffer, oltre ad accettare il limite come inizio di apertura, vi vede il passo decisivo che la persona è chiamata a compiere per entrare nella condizione di responsabilità. Il limite finisce così per essere positivamente il luogo della presa d’atto dell’umanità e dell’unicità dell’uomo. «L’uomo è un essere che vuole comprendere la sua unicità: non la sua animalità» afferma Abraham Joshua Heschel «ma la sua umanità! L’uomo richiede di essere umano.»3 E lo fa, aggiungo io, accogliendo il suo limite. Questo non significa un elogio del limite tout court, né accoglienza acritica e quasi rassegnata dell’imperfezione; è, piuttosto, elogio dell’essere umano che si realizza e si spende in un orizzonte fatto, sì, di limite, ma contemporaneamente consapevole di essere chiamato a realizzazioni capaci di dare senso pieno alla sua esistenza. Un razionalismo esasperato rende impossibile l’accoglienza del limite e ritiene assurdo riconoscergli un senso.
Condivido così un passaggio di Peter, che afferma: «Mentre la ragione trova nell’errore un ostacolo sul cammino, l’intuizione sembra cavarsela meglio, considerando l’errore come la premessa di un successivo sviluppo del potenziale umano»4. Esattamente come Simone Weil, che vedeva nell’errore la fonte di energia dell’uomo, e come Johann Wolfgang von Goethe, che si spinse a riconoscere l’amabilità dell’uomo proprio nei suoi limiti. Una corretta concezione della persona nella quale trovano integrazione il senso del limite e il fascino delle frontiere può rappresentare la strada per depotenziare una visione concorrenziale, se non proprio antitetica, tra religione e modernità. E diventare luogo aperto di dialogo.
![]()
«Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni» (Albert Einstein). Dal greco krìsis (scelta), dal verbo krino (distinguere) e intesa nel suo significato etimologico, crisi è una scelta o, meglio, una scelta richiesta in un punto di svolta, in un momento decisivo. Proprio per questo richiede una decisione forte. L’etimologia ci restituisce pertanto il senso positivo di una parola e di un’azione che – a detta di Einstein – contribuisce a fare emergere il talento di ciascuno; nel lavoro, lungo il decorso di una malattia, nelle attività di un governo e di fronte a problemi spesso incomprensibili. La crisi può rappresentare l’opportunità per una scelta che magari non siamo del tutto disposti a fare o che pensiamo di non essere in grado di fare.
A ben guardare ciò che avviene attorno e dentro di noi, esistono sostanzialmente due tipi di crisi: una di natura congiunturale e una crisi di natura strutturale. Sappiamo che una civiltà si caratterizza, tra l’altro, per un quadro di valori condivisi. Finché resiste il quadro dei valori inerenti la vita comune (lavoro, famiglia, diritti), le crisi storiche che si succedono sono crisi congiunturali: cambia l’equilibrio interno, ma tiene il quadro generale dei valori. Di quando in quando, però, e senza scadenze fisse, il quadro dei valori condivisi entra in crisi; nel senso che la cultura omogenea di un popolo non tiene più, cadono le strutture giuridiche e sociali perché ritenute ormai inadeguate. Insomma cambia la civiltà: si perdono i valori che fino a quel momento avevano rappresentato il cuore di una civiltà e di una cultura. La crisi, in questo caso, diventa strutturale.
Nello spazio e nel tempo del cambiamento che caratterizza ogni crisi strutturale viene chiesto un gesto forte, una scelta per trovare altri quadri di valori e/o per recuperarne alcuni. Tale gesto fa fatica a imporsi: i contenuti fondanti della nuova civiltà sono ancora imprecisi, fluidi, non chiari perché ci troviamo ancora nel bel mezzo dei processi di cambiamento dove il modello di ieri non regge più e il modello di domani non l’abbiamo ancora. Un periodo di crisi strutturale richiede un cambiamento profondo che non risparmia nessuno. Non risparmia le democrazie, non risparmia i totalitarismi, non risparmia il capitalismo, non risparmia il socialismo, non risparmia la Chiesa. Capita sempre più spesso che tutti anelino al cambiamento, ma… guai a chi lo promuove sul serio!
Per uscire da una qualsiasi crisi strutturale, c’è bisogno di intelletto per leggere i segni dei tempi, tenere presenti alcuni orientamenti di fondo e inventare il domani, in attesa di una nuova crisi perché «la crisi non è passeggera, ma è come una condizione permanente della nostra esistenza» (Paul Ricoeur).
![]()
A rendere difficile la comprensione e l’accoglienza dell’umiltà tra gli atteggiamenti che permettono, ancora oggi, all’uomo di realizzarsi in pienezza sono due modi errati di abitarla. Il primo è quello del rinunciatario; di chi confonde cioè l’umiltà con la rinunzia a riconoscere e accettare la verità di sé e degli altri per timore di doversi spendere per essa e di dover scegliere a partire da essa. Il rinunciatario è la caricatura dell’uomo umile. C’è, poi, il modo di pensare e di agire dell’arrogante, che poggia le sue parole e i suoi gesti sulla convinzione di bastare a se stesso.
Il termine umiltà deriva da humus, che significa suolo, terra. L’umiltà collega l’uomo alla terra, come alla sua origine. Nei miti sumeri e babilonesi il primo uomo viene creato con materiale preso dal suolo. Lo stesso si legge nel libro della Genesi: l’uomo viene creato da Dio e plasmato dalla polvere della terra, animata dal suo «alito di vita» (Gn 2, 7); un modo per affermare, da un lato, la caducità e la debolezza dell’uomo e, dall’altro, per riconoscerne la grandezza.
È capace di umiltà solo chi è consapevole della sua origine, fatta di fragilità e di grandezza; solo chi è consapevole di non essere artefice assoluto né padrone indiscusso di sé e del mondo. Solo chi non è affetto dalla sindrome del Padreterno vive nell’umiltà e lascia che l’umiltà segni le sue relazioni. Francesco d’Assisi voleva essere minor, vale a dire piccolo, umile per poter essere vicino agli altri, fratello di coloro con cui vive. Per Francesco «l’ideale non è cercare di essere sufficienti a se stessi, ma di condividere quanto si riceve e di accettare di aver bisogno degli altri fin nei piccoli particolari della vita quotidiana»1. Per Simone Weil «l’umiltà è soprattutto una qualità dell’attenzione»2 ed è la virtù più necessaria per conoscere la verità.
Purtroppo oggi l’umiltà è stata bandita su input di Nietzsche perché si vede in essa un impedimento alla piena realizzazione di sé. Al posto dell’umiltà si afferma sempre più la hybris, ben nota nel mondo greco; si afferma cioè la tracotanza, accompagnata appunto dalla presunzione di chi ritiene che essere umile significhi darsi per sconfitti in partenza e quindi condannati a rinunziare alle proprie ambizioni e potenzialità. Ma, per gli stessi Greci, la superbia era all’origine del disordine, della perdita dell’armonia e della mancanza di bellezza. Un pensiero che, per altri versi, non smette di trasmetterci papa Francesco, per il quale la vera grandezza dell’uomo sta nella sua umiltà, nel farsi “piccolo”. Senza l’umiltà l’amore resta bloccato. Con l’umiltà, invece, si apre la strada dell’amore vero, che incontra l’altro senza pregiudizi e senza presunzione e, nello stesso tempo, libera le energie necessarie per condividere il bene e per costruire un mondo più vivibile.
![]()
«Vivo in quella solitudine che è penosa in gioventù, ma deliziosa negli anni della maturità.»1 Composta da solus che, secondo alcune fonti, deriva a sua volta da sollus, solitudine rimanda a “intero” e che non ha bisogno di altro per completarsi, indipendente. Sembrerebbe quindi una condizione esclusivamente positiva. La letteratura, le arti, le scienze non smettono di narrare, disegnare e affermare i valori dell’unicità e della completezza. I capolavori letterari, le intuizioni filosofiche, le scoperte scientifiche non solo si affermano – a ragione – perché uniche, ma sono il frutto del lavoro, della sensibilità e del pensiero – più che di un’unica persona – di una persona unica.
Senza scomodare Max Stirner, che nel suo L’unico e la sua proprietà ha estremizzato il concetto di individuo, la condizione di solitudine oggi stenta a presentare la sua faccia positiva. La solitudine, più che completezza, evoca mancanza; più che all’unicità rimanda all’idea di abbandono. La paura di essere soli e di restare soli provoca la frenesia per incontri e relazioni talvolta poco significative. «Troppo frettoloso è il solitario, nel tendere la mano a colui che incontra» ha affermato Friedrich Nietzsche.
Un tempo, per motivi demografico-statistici (eravamo di meno), geografici (il pianeta era sconosciuto) e tecnologici (non esistevano i moderni mezzi di comunicazione capaci di annullare distanze e barriere), tutti eravamo più soli. La nostra percezione di contempor...