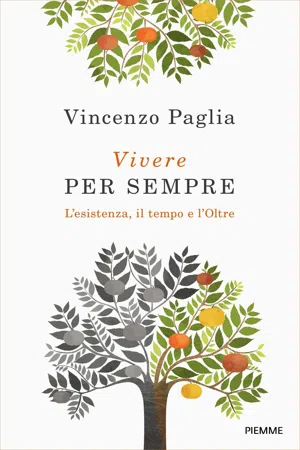Mortali, ma non per la morte
Perché parlare della vita dopo la morte? E soprattutto, possiamo parlarne insieme, ascoltandoci seriamente, credenti, non credenti e “non saprei”? Il pensiero della vita è il pensiero dell’umana resistenza all’immenso spreco causato dalla morte, qualora venisse pensata come estinzione totale. È comunque evidente che, una volta o l’altra, tutti siamo trafitti da questa paradossale evidenza. Sì, la morte, liquidata frettolosamente come un destino che ci fa finire nel niente, non può che apparire come uno spreco ingiustificabile della vita umana che conosciamo. Ma considerare così la nostra morte, senza indagare a fondo, diciamolo ruvidamente, è un’offesa alla nostra intelligenza. Per quanto fragili, vulnerabili, fallibili, noi esseri umani siamo vincolati da un patto d’onore con lo spirito, il pensiero, la coscienza, gli affetti, la libertà e la giustizia. In virtù di questo patto con la qualità spirituale della nostra vita, milioni di uomini e donne, ogni giorno, si sentono responsabili del valore non meramente organico e utilitaristico della loro esistenza, mettendo in gioco la loro vita in nome della dignità di quel patto, che li rende umani. Una manciata di intellettuali, nel cuore stesso dell’umanesimo europeo, appare impegnata a convincerci che non c’è alcuna radice trascendente di questa qualità spirituale. E che non c’è per essa nessuna destinazione, dato che il ciclo della vita materiale è totalmente indifferente a un oltre. La nostra vita spirituale si consuma e si estingue con il nostro organismo, perché non ha un senso diverso e una reale destinazione.
Viene da chiedersi come mai siamo stati – e siamo ancora in misura preponderante – così inguaribilmente sciocchi, per millenni e proprio su questo argomento, dato che siamo stati così intelligenti su molti altri. Paura della morte? D’accordo. Ma ogni giorno milioni di uomini e di donne sfidano questa paura per ragioni totalmente differenti da quelle che ci sono consigliate da una natura che ci raccomanda adattamenti più vantaggiosi. È poco saggio liquidare chi guarda oltre come se fosse semplicemente vittima della paura e della superstizione. Senza contare il fatto che c’è qualcosa di perverso in questo gioco, se consideriamo la forma che esso ha preso nella nostra cultura corrente.
Da un lato veniamo richiamati alla realtà della inviolabile differenza umana: coscienza, linguaggio, libertà, decisione, onore, dignità, giustizia, amore. E nessuno di noi può dire di essere il creatore e il padrone di tutto questo. Siamo consapevoli che è parte del naturale bagaglio di ciascun uomo e di ciascuna donna. E per questo ci battiamo contro i determinismi della natura e i fallimenti della storia: anche a costo di rinunciare al denaro che se li vorrebbe comprare e alla violenza che li vorrebbe annullare. Quante volte ci viene ripetuto che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino! Questa dimensione propria dell’uomo rappresenta la forza di cui disponiamo per combattere ogni ingiustizia. Questa forza è talmente reale che, quando decidiamo di attingere a essa, noi crediamo di corrispondere alla verità che è scritta nella nostra natura spirituale, persino quando manca un risultato conforme alla sua bellezza e alla sua giustizia.
Dall’altro lato, però, siamo ossessivamente martellati da un racconto della scienza che ci incoraggia a pensarci più realisticamente, come una popolazione di organismi particolarmente ingegnosi che eseguono programmi di vita prescritti e indirizzati dalla casuale aggregazione di elementi fisico-chimici, i quali – inopinatamente – si sono poi dotati di leggi e regole di funzionamento implacabili, dei quali siamo essenzialmente in ostaggio. Non c’è un vero scopo nell’organizzazione del caos che precede, non c’è un senso morale nelle regole che ne conseguono. La vita cerca di sopravvivere, il suo godimento è fine a se stesso: questo è tutto. Nel non senso dell’origine è scritto anche il senso della destinazione: il niente. Siamo una «parentesi fra due nulla» (J.-P. Sartre).
Mi sembra evidente che il fatto di essere sottoposti, come ormai avviene platealmente, alla pressione di questo duplice racconto, che visualizza due visioni del senso della nostra vita in collisione frontale tra loro, produce una condizione psichica semplicemente insostenibile. I segni del cedimento, individuale e collettivo, sono palesi. La nostra tendenziale indipendenza dell’etica – è un’opzione incerta, di risultato incerto – e la nostra crescente dipendenza dalle sostanze psicotrope (chimiche o digitali, non importa, purché funzionino) procedono insieme. L’instabilità della vita psichica e la corruzione del legame sociale vanno indagate più coraggiosamente: il vuoto di senso della vita oltre la nostra morte è l’epicentro dello svuotamento d’amore per la nostra vita.
Certo, siamo pieni di paradossi. Ma è così che siamo irriducibilmente “umani”. Siamo capaci di sbarrare la strada alle pulsioni della sopravvivenza e del godimento, per aprire tempo e spazio alle passioni dello spirito, alle ingiunzioni della giustizia, alle creazioni del pensiero, alla tenacia del voler bene. Eppure, ci sono metodo e intelligenza anche nella nostra incomparabile capacità di distruggere ogni affetto per il bene comune, di tradire la parola data e giurata, di avvilire la dignità dell’altro fin dentro l’anima. Le casualità delle combinazioni degli atomi e dei determinismi degli adattamenti evolutivi non sanno nulla di tutto questo. Noi sì. Infatti, quando cerchiamo di riconoscere e di decidere il senso della nostra vita, e siamo disposti a tutto purché ce ne venga riconosciuta la libertà, la dignità, la responsabilità, pretendiamo risposte umane da altri esseri umani. E noi facciamo questo ogni giorno, nel bene e nel male. Sprizziamo gioia quando si apre un senso per l’amore, siamo disperati quando si chiude per la libertà. Non è una cosa che abbiamo imparato a fare per semplice riflesso della natura cosmica e per imitazione del comportamento animale.
La qualità umana della nostra vita – che si incarna nella irriducibilità dell’uomo e della donna – precede la nostra esperienza del mondo e si impone alla nostra esistenza. Nello stesso tempo, essa si rivela come destinata a essere accolta liberamente. E noi speriamo che sia proprio così. Ossia che non venga né dalle stelle, né dall’oroscopo, né dalla chimica, né dalla fisica. E neppure da noi stessi. Insomma, che sia vera: una giustizia del senso che non ci tolga la libertà, ma che non sia semplicemente inventata da noi. In altre parole, destinata a noi, come una promessa che anticipa le istruzioni della vita.
Non siamo nati semplicemente per assecondare la vita, siamo nati per fronteggiarla, per aiutarla, per trasformarla, per renderla migliore per tutti e particolarmente per chi fa più fatica a viverla. Vale la pena spendere così la propria vita, anche se richiede una responsabilità davvero impegnativa. Il senso della vita che noi cerchiamo incessantemente è anche quello che orienta il nostro desiderio più profondo. Una volta che siamo entrati nella dimensione del linguaggio – ossia degli affetti e dei pensieri umani – non possiamo fare nessuna esperienza della vita senza riconoscere in essa una vicinanza, o una lontananza, dal giusto senso che la vita dovrebbe avere, per essere come deve essere. Siamo l’unica creatura in grado di pensare e di dire: «Non dovrebbe accadere», «Non è giusto che accada», anche di fronte all’inevitabile o all’irreparabile.
Non siamo una parentesi tra due nulla
L’idea che ci siamo inventati una vita “oltre la morte” per anestetizzare la paura della morte è un’idea debole, troppo debole. Un po’ come l’altra di esserci inventati “un dio” come proiezione dei nostri fantasmi di perfezione o dei nostri deliri di onnipotenza. In realtà queste illusioni non nascono spontaneamente, se un qualche presentimento di verità – pur corrotto dalla nostra volontà di potenza – non offre argomento per pensare una verità all’altezza di quelle proiezioni. La lezione biblica è chiara: Adamo ed Eva poterono coltivare la loro fantasia di immortalità autocostruita e la loro allucinazione di una onnipotenza divina egocentrica solo perché il ricordo del Dio creatore e della sua promessa poteva essere insidiata da un sospetto maligno. Noi, uomini e donne, in effetti, cerchiamo di vivere sin da ora una vita degna della nostra “anomalia”, in quanto esseri “spirituali”, perché la potenza dell’anima che abbiamo misteriosamente ricevuto in dono ci impone l’interrogativo sul senso della vita. Non ci interrogheremmo se fossimo semplicemente un aggregato di bisogni biologici, di pulsioni riproduttive. Noi non giudicheremmo la vita, come facciamo, dal punto di vista di un senso spirituale che la trascende, se non ne fossimo già sempre giudicati. Che ne siamo consapevoli oppure no.
Questo è il “miracolo” dell’esistenza umana, in quanto “umana”. Dentro la nostra vita abita – e opera – una promessa che non ci siamo fatti da noi. E però ce la trasmettiamo, irrevocabilmente, di generazione in generazione. Tutti la ereditiamo, la troviamo e ne viviamo. Pensare di sopprimere la domanda sul senso della vita, cercare di ridicolizzarla, agire per intimidirla, anche in un solo bambino, è un peccato contro lo Spirito. È a questo che si riferisce Gesù, prima di tutto, quando rimprovera duramente i suoi e la folla a proposito dello “scandalo” recato ai bambini. Il peccato contro lo Spirito, aveva spiegato, è la colpa – irreparabile – di chi sconfessa le opere di Dio, ossia le opere della liberazione dal male del corpo e dell’anima, dichiarandole opere del Maligno, sortilegi, superstizioni, illusioni.
Purtoppo lo spirito del tempo ha preso una brutta piega, a questo riguardo. Il peccato “contro lo Spirito” si è fatto spudorato, prepotente, aggressivo. Gli spiriti bassi cercano di lucrarne vantaggi, e seducono molti, impiegando a sproposito presunte verità della scienza della natura e della vita. Le potenze mondane della ricchezza e del dominio appaiono particolarmente interessate alla trasformazione dei popoli in gruppi intenti alla propria individuale ricerca del benessere, più che alla comune felicità dell’abitare assieme il mondo come un’unica, grande, famiglia umana. Non c’è onore, per l’uomo e per la donna, in questa alternativa. Il Vangelo è venuto a segnare un’altra strada: i miracoli di Gesù lo dimostrano chiaramente e senza eccezioni. Non di solo pane vive l’uomo. Ma anche di amicizia, di amore, di vita spirituale. Il pane a chi ha fame, a costo di fare un miracolo per moltiplicarlo, è sacrosanto. E su questo saremo giudicati. E c’è bisogno anche di spirito, di affetti, di amore. La stoffa della nostra vita eterna si forma nella qualità della fraternità che è la sostanza della dignità umana. Quando cerchiamo affetti e legami della vita all’altezza della nostra dimensione corporale-spirituale, tutto in noi resiste alle potenze che vorrebbero trasformarci in soggetti consumatori e in oggetti di consumo. Il problema diviene più grave se non abbiamo più le parole per dirlo. Facilmente ci rassegniamo al presente, pur di sopravvivere. Il Vangelo ci offre le parole per vivere nella pienezza della dimensione umana; ci invita a osare miracoli, pur di raggiungerla. Se avessimo fede, i pani si moltiplicherebbero e la montagna si getterebbe in mare. Purtroppo, gli spiriti bassi delle potenze mondane, per anestetizzarci dal senso della vita e rimuovere così il nostro concetto del tempo, lo trasformano nel tempo dell’orologio che batte gli ottusi rintocchi di un presente senza memoria e senza futuro. Un presente da consumare, prima che sia troppo tardi, salvo scoprire che è sempre già troppo tardi, perché l’attimo è sempre fuggente. Siamo come senza passato e senza futuro. Quello che non consuma e non si consuma, della nostra vita – il meglio di noi, che è un miracolo reale, non un mito illusorio – rimane senza origine e senza destinazione.
Prima di addentrarmi nella riflessione che vorrei condividere con il lettore su questo punto cruciale mi si permetta una franca confessione. Quando ho alluso a coloro che si accaniscono contro il piano di realtà della vita propriamente umana, denunciandolo come illusione irrazionale e superstizione religiosa, ho parlato di una “manciata di intellettuali”. Mi spiego brevemente.
Parlo così perché sono profondamente convinto che disponiamo di una vastissima classe intellettuale, di grande apertura mentale e finezza analitica, che è seriamente interessata alla prospettiva e alla necessità di un nuovo umanesimo, che faccia di nuovo volare alto il senso della nostra avventura umana. Questa competenza e questa passione sono trasversali al diverso posizionamento esistenziale nei confronti della fede religiosa (e specificamente cristiana). Il fondamentalismo antireligioso e l’ateismo dogmatico di quella manciata di intellettuali di cui parlo non li rappresentano degnamente, proprio come il fondamentalismo religioso e le profezie apocalittiche non rappresentano gli autentici credenti. Eppure, anche grazie all’ambivalente efficacia dei nuovi media, la spregiudicatezza dei liquidatori di ogni riflessione sulla trascendenza della vita che ci siamo trovati in dono simula una rappresentanza sociale e culturale che non corrisponde affatto alla realtà.
Personalmente – ma è un’esperienza che è facilissimo riconoscere come condivisa – incontro con straordinaria emozione, per ragioni professionali e anche personali, persone di grande valore intellettuale che sono seriamente infastidite dalla rozzezza con cui la certezza del vuoto della nostra vita oltre la nostra morte è professato con l’arroganza del superuomo di complemento. La rimozione del tema, che svuota semplicemente la vita in cui siamo nati e viviamo, così come la sua riduzione a qualche vaga fantasia sul riciclo dell’energia cosmica (fino a che morte non sopraggiunga, anche lì), spegne il pensiero. E si vede. Il cristianesimo, certamente, quando parla di risurrezione dei morti a una nuova vita dei cieli e della terra nel grembo dell’intimità di Dio, spinge la riflessione oltre ogni umano azzardo. Personalmente, è questo il filo rosso che lega le mie riflessioni. E tuttavia sono convinto che rimanere interlocutori della destinazione della vita umana oltre la morte è l’unico modo per prendere sul serio i vuoti della vita che ogni giorno dobbiamo sfidare se vogliamo rimanere umani. La certezza che il vuoto della vita oltre la morte sia colmato dalla risurrezione e dal suo riscatto chiede certamente una fede. Non è affatto scontato, tuttavia, che la certezza di quel vuoto abbia la ragione dalla sua parte. Dobbiamo essere intellettualmente più leali con i miracoli che la qualità spirituale della nostra vita compie già ora in noi, a dispetto della nostra fallibile fragilità.
Sono convinto che credenti e non credenti debbano ritrovare una nuova alleanza anche nella riflessione sul tema della vita oltre la morte. Il silenzio sulle “cose ultime” ci avvelena anche la nascita. E ci fa perdere contatto con la realtà del varco che Dio stesso si apre in essa – non senza di noi! Una volta per tutte. Una volta per sempre. Il passaggio è anticipato da una quantità di segnali. Da decifrare. Insieme.
La dittatura del presente e l’eredità della vita
Il tempo dell’orologio è ottuso e crudele. Il suo tic-tac sempre uguale è perfettamente indifferente alle storie di vita, insensibile alla vita che c’è dentro. Cerchiamo di mettercene sempre di più, ma ce ne sta sempre meno. Cerchiamo di fermarlo sul presente, e intanto lo acceleriamo convulsamente per non perderlo. Bisogna fare tutto subito, perché il tempo è sempre denaro e le opportunità sfumano rapidamente. Non ne abbiamo mai abbastanza (per fare cosa?). In compenso, esso sembra aver preso un’accelerazione impossibile: non gli stiamo più dietro. Il tempo che passa, e deve essere inseguito affannosamente, ha una velocità che supera la nostra possibilità di controllo, di pensiero, di valutazione. E qui sta la sua crudeltà. Il tempo dell’orologio è pieno di scadenze e ride della nostra rincorsa. È il tempo della pancia e delle emozioni, non il tempo della testa e dei pensieri. Zygmunt Bauman, con esempi magari un po’ passati, scriveva già nel secolo scorso: «Nella vita quotidiana non troviamo spesso l’occasione di porci domande di tipo escatologico. C’è da governare il bestiame, raccogliere i covoni nei campi, pagare le tasse, fare da mangiare, riparare il tetto, studiare una relazione oppure scriverla, spedire una lettera, compilare un formulario, fare i compiti o correggere quelli degli altri, andare a un appuntamento, portare a riparare il registratore, comprare i biglietti del treno… Prima che ci sia il tempo di pensare all’eternità, è già ora di andare a letto per recuperare le forze in previsione di un’altra giornata piena di cose da fare o da rifare»1. Le potenze mondane, però, sono felici della nostra impossibilità di trovare il tempo per pensare, riflettere, giudicare, godere insieme delle fantastiche risorse dello spirito che riempiono il tempo di vita e si liberano dalla schiavitù delle scadenze.
L’eternità sperata per il compimento della vita secondo lo Spirito non è però da pensare semplicemente come una vita senza tempo. È una vita liberata dal tempo dell’orologio, che rende irreparabile il passato, ottuso il presente, incerto il futuro. L’eternità della vita secondo la verità e la promessa della fede cristiana non è neppure una vita semplicemente “senza corpo”. È la vita che si dispiega in un “corpo risorto”, ossia nella spazialità pura di un’esistenza sensibile agli affetti, emozionata dalle scoperte, beata della prossimità di Dio con tutte le creature “visibili e invisibili” che prendono vita dall’affezione creatrice in cui vuole essere riconosciuto. Durante l’esistenza terrena, noi siamo chiamati, come in un tempo di iniziazione, a prepararci per vivere un futuro che ora percepiamo confusamente – «come in uno specchio», come in un “filtro oscuro”, dice san Paolo – nei riflessi di questa bellezza della immensa creatività di Dio alla quale siamo chiamati a partecipare, nel nostro passaggio alla vita secondo lo Spirito, per sempre.
La perdita di questo sfondo – sia una fede, sia una speranza, sia un presentimento, sia pure un semplice atto di resistenza umana in favore della dignità di questa vita – ci ha introdotti in una grande depressione. L’ossessione del presente, senza sfondo di affezione creatrice, senza futuro di riscatto definitivo, è sintomaticamente bipolare: siamo attraversati da euforie di massa e da rabbie collettive che corrispondono a uno stato di eccitazione permanente, anche per futili motivi. Mi sono convinto che lo stato di deprivazione indotto dalla rimozione di ogni promessa di destinazione dell’enorme ricchezza della nostra vita secondo lo spirito è molto vicino alla forma della “malattia mortale” disegnata da Kierkegaard. L’oscuramento delle “c...