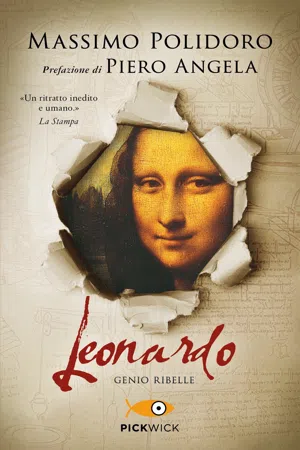A Milano il governatore del re, Charles d’Amboise, si era dato da fare per trovare a Leonardo e a noi che facevamo parte del suo seguito una sistemazione più adatta di quella provvisoria nel suo palazzo. Ci furono così messe a disposizione alcune sale nella parrocchia di San Babila, nei pressi della Porta Orientale. C’era una grande sala di lavoro e poi camere per la notte riservate al maestro, a Salaì, al garzone Lorenzo e a me.
Lorenzo era quello che Leonardo spediva a fare le commissioni più spicce o di cui si serviva per i lavori meno precisi. Io iniziai subito il mio compito di riordino delle migliaia di carte e fogli sparsi che riempivano i bauli che ci eravamo portati appresso da Firenze, sia quelli che erano in casa del Martelli sia altri che il maestro aveva recuperato da un deposito a Santa Maria Nuova.
Quanto al Salaì, pur svolgendo diversi incarichi per il maestro, andava e veniva come gli pareva, ma mi sorprese parecchio scoprire non solo che Salaì non era il suo nome, ma anche che egli non era affatto un orfano come avevo creduto fino a quel momento.
Lui mi aveva raccontato di essere stato adottato da Leonardo quando ancora era un bambino di dieci anni e io mi ero immaginato che egli fosse stato trovato per strada, a mendicare, e con quei suoi occhioni languidi gli avesse intenerito il cuore. Invece, giunti a Milano venni a sapere che i suoi genitori non solo erano vivi e vegeti ma risiedevano in una casa rustica costruita sul fondo di una vigna che apparteneva proprio a Leonardo.
È un terreno di sedici pertiche, che sorge nei pressi di Porta Vercellina e che Ludovico il Moro, poco prima della caduta per mano dei francesi, aveva donato al maestro come gesto di riconoscenza per i tanti anni di lavoro che gli aveva dedicato1. Leonardo vi era particolarmente affezionato, perché ogni tanto lungo il viaggio ne aveva parlato come di un suo piccolo tesoro, ma da un documento capitatomi tra le mani quando iniziai il mio lavoro in San Babila seppi che la vigna era stata data in affitto, e poi in uso gratuito, a tale Pietro Caprotti da Oreno, il quale aveva anche la procura per stipulare atti con i vicini per conto di Leonardo da Vinci e del figlio Giangiacomo di Oreno. “Salaì”, per l’appunto!
Ero allibito. Qui era un viziatissimo giovane uomo, che viveva come figlio adottivo del maestro, e pure aveva una famiglia che avrebbe potuto occuparsi di lui. E questa famiglia non solo occupava le proprietà del maestro ma addirittura pretendeva che egli provvedesse al sostentamento del giovanotto.
Da un’altra annotazione che mi capitò sotto gli occhi, infatti, vidi che il maestro aveva segnato l’inizio dei pagamenti regolari da parte dei tesorieri regi: «Addì… d’ottobre 1508 ebbi scudi 30». Subito dopo però aggiungeva: «13 ne prestai a Salaì per compiere la dote alla sorella».
Nonostante il padre di Lorenziola, una delle due sorelle di Salaì che stava per andare in sposa, fosse vivissimo, toccava al maestro dotarla per il matrimonio!
Fui così incuriosito che volli saperne di più sull’arrivo di “Giacomo”, come effettivamente si chiamava.
Il primo indizio lo trovai su un manoscritto che apparteneva a una serie di studi sulle luci e sulle ombre. Sul frontespizio, dove aveva scritto: «Addì 23 d’aprile 1490 cominciai questo libro e ricominciai il cavallo» quando, scosso dai dubbi del Moro, Leonardo si era messo con più convinzione a lavorare al progetto del monumento equestre, trovai più sotto un’altra annotazione.
«Iacomo venne a stare con meco il dì della Maddalena nel 1490, d’età d’anni dieci».
Una sera, passeggiando a lato del Duomo, il maestro mi avrebbe spiegato che gliel’aveva portato il padre, il quale non riusciva a sfamare tutte le bocche della sua famiglia, perché lo prendesse con sé come garzone. Era sporco e vestito di stracci, ma la simpatia e la bellezza del viso di quel bambino lo colpirono parecchio. Egli accettò di prenderlo con sé, ma immediatamente si accorse di che pasta era fatto per davvero Giacomo. Quella sera, Leonardo si limitò a dirmi che era veramente pestifero e che, per questo, gli aveva dato il soprannome di Salaì, cioè Saladino, che stava a significare piccolo demonio, ripreso da un’opera del fiorentino Luigi Pulci, il Morgante, che il maestro ricordava da quand’era alla corte di Lorenzo de’ Medici.
Tuttavia, rovistando tra le sue carte, avrei presto trovato il motivo di quel soprannome. È un lungo elenco di lamentele di cui il maestro volle da subito tenere nota.
«Il secondo dì gli feci tagliare due camicie, uno paro di calze e un giubbone» scriveva Leonardo il giorno dopo averlo preso in bottega «e quando posi i denari a lato per pagare queste cose, lui me li rubò dalla scarsella e non fu mai possibile farglielo confessare, benché ne avessi la certezza – lire 4.»
E questo era solo il secondo giorno.
Il terzo se lo portò appresso a cena a casa dell’amico architetto Giacomo Andrea da Ferrara e lui «cenò per due e fece male per quattro»: ruppe tre caraffe, versò il vino e andò a concludere il pasto… dove è meglio non dire.
Il 7 settembre rubò a un allievo, Marco d’Oggiono, la penna a punta d’argento del valore di 22 soldi. La si cercò dappertutto e alla fine fu ritrovata nella cassa di Salaì.
Il 26 gennaio, nel corso dei festeggiamenti per le nozze del Moro, andarono a casa di Galeazzo da Sanseverino, campione di giostra della corte sforzesca, per preparare i costumi da lui richiesti. «Spogliandosi certi staffieri per provarsi alcune vesti da uomini selvatici, che là comparivano, Giacomo si avvicinò alla scarsella d’uno di quelli, la quale era sul letto con altri panni, e tolse i denari che dentro vi trovò: 2 lire e 4 soldi.» Un mese dopo Giacomo trovò una pelle turchesca che un pittore pavese, Agostino Vaprio, aveva regalato al maestro per farne un paio di stivali. Corse a venderla a un ciabattino, ricavandone ventidue soldi. Il maestro riuscì a fargli confessare che cosa ne avesse fatto di questi soldi: si era comprato anici e confetti.
Il 2 aprile toccò a un altro allievo, Giovanni Boltraffio, finire alleggerito del suo graffio d’argento.
Il lungo elenco di lamentele si concludeva con il calcolo delle spese sostenute nel 1490 per vestire il Salaì: «Un mantello, lire 2; camicie sei, lire 4; tre giubboni, lire 6; quattro paia di calze, lire 7 soldi 8; vestito foderato, lire 5; quattro paia di scarpe, lire 6 soldi 5; una baretta, lire 1; stringhe, lire 1».
E sul margine del foglio un giudizio deciso sul ragazzo, forse redatto all’inizio del loro rapporto, ma probabilmente ancora valido parecchi anni dopo: «Ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto».
Avrei tanto voluto domandare a messer Leonardo perché mai continuasse a sopportare un individuo simile, che si approfittava così apertamente della sua benevolenza e che non restituiva con il suo lavoro, o anche solo con la sua educazione, nemmeno un grammo di quanto riceveva, poiché anche nella pittura, per quanto tentasse di imitare il maestro, la sua mano era tutt’al più mediocre. Ma presto ebbi modo di scoprire che i sospetti che erano nati in me sul rapporto esistente tra il maestro e Salaì probabilmente erano fondati.
Di nascosto, qualcuno dei garzoni pagati a cottimo, che venivano in giornata a lavorare per il maestro, e avevano fatto capire in più modi di non avere in simpatia Salaì, aveva scarabocchiato una sua goffa caricatura su un foglio del maestro. Lo avevano disegnato di profilo, tutto azzimato in uno dei suoi completini nuovi, con i capelli lunghi ben pettinati e un gran nasone. Sotto, accanto al nome “Salay”, avevano aggiunto un buco a forma di toppa penetrato da un membro virile. Il significato era più che evidente e mi sentii profondamente imbarazzato.
Se il maestro voleva bene a Giacomo, nonostante tutti i suoi evidenti difetti, era qualcosa che riguardava solo lui e nessuno aveva il diritto di deriderlo o giudicarlo per questo. E poi, considerato quanto gli piacesse andare contro certe regole, non potevo escludere che in fondo Leonardo poteva provare un certo piacere a sbalordire il prossimo accompagnandosi a un personaggio del genere.
Decisi così di sequestrare quel foglio e farlo sparire, per evitare che il maestro o Salaì potessero vederlo e rimanerci male.
Tuttavia, Salaì a parte, sin dal primo giorno del nostro arrivo a Milano notai un cambiamento in Leonardo. Sembrava molto più forte ed energico, sorrideva più spesso e mi pareva come in preda a un’eccitazione, una febbre che lo portava a lavorare senza risparmiarsi.
Oltre all’incarico per il Trivulzio, circa il quale ancora attendevamo conferma, il maestro sembrava avere mille curiosità da soddisfare. Ogni giorno compilava elenchi di cose da fare e, come nel resto dei suoi scritti, si rivolgeva a se stesso dandosi indicazioni su ciò che intendeva mettere in atto.
Ne ho ritrovato uno a caso, ripiegato tre volte su se stesso perché egli si portava questi elenchi in scarsella, in modo da poterli consultare ogni volta che ne avesse l’occasione. Riporto solo alcune delle voci che vi sono presenti:
Calcola le misure di Milano e periferie.
Trova un libro che tratti di Milano e delle sue chiese, che dovrebbe essere al cartolaio sulla strada per Cordusio.
Chiedi al maestro di aritmetica come si può trasformare un triangolo in quadrato.
Chiedi a messer Fazio una lezione sulle proporzioni.
Chiedi ai frati di Brera di mostrarti il Liber de Ponderibus.
Parla a Giannino, il Bombardiere, del perché la torre di Ferrara sia murata senza scappatoie.
Chiedi a Benedetto Portinari com’è andare sul ghiaccio nelle Fiandre.
Esamina la balestra del mastro Giannetto.
Trova un esperto di idraulica e chiedigli come si riparano chiusure, canali e mulini secondo lo stile lombardo.
Cerca di ottenere Vitolone, che è nella libreria di Pavia.
Chiedi delle misurazioni del sole che il mastro Giovanni Francese ha promesso.
Sono elenchi di libri da trovare, come il De Ponderibus, un testo sulla meccanica, o quello del Vitolone, cioè il polacco Witelo, sull’ottica, problemi da risolvere, curiosità da soddisfare.
Qualunque cosa, anche quella che a un altro potrebbe parere una sciocchezza o una follia, lui se la segna per tentare poi di darvi una risposta.
In un altro elenco ho trovato queste due curiose annotazioni:
Va’ ogni sabato alla stufa e vedrai dei nudi.
Fa’ gonfiare il polmone d’un porco e guarda se cresce in larghezza e in lunghezza, oppure solo in larghezza e non in lunghezza.
Posso capire che a volte, forse, avesse bisogno di trovare in fretta, mancandogli modelli sottomano, dei corpi nudi da ritrarre. Ma a che mai poteva servirgli sapere come si gonfiava il polmone d’un porco? Probabilmente quando la lessi pensai che questa fosse solamente una sciocchezza, ma mi sarei sbagliato e anni dopo avrei scoperto il perché.
O ancora, un’altra volta annotò questa esigenza: «Scrivi la lingua del picchio e la mascella del coccodrillo».
Un’assurdità a prima vista, invece la curiosità nasceva dall’esigenza di capire dove nascesse la potenza del primo nel colpire le cortecce senza danneggiarsi il cervello e come facesse la bocca del secondo ad aprirsi così tanto. Il tutto all’interno di una serie di studi sull’anatomia degli animali e sulla comparazione degli stessi, qualcosa che probabilmente non ha ancora pensato di fare nessun altro al mondo2.
Al di là di queste curiosità di tipo naturale, per lo più, egli si era anche rimesso all’opera con i pennelli.
Avevamo nuovamente posizionato sui cavalletti i dipinti ai quali stava lavorando in quel periodo. C’era la Sant’Anna, di cui ho già avuto modo di scrivere e che sembrava ormai quasi giunta a completamento; c’era l’altro quadretto coperto dal telo, che ancora non ero riuscito a farmi mostrare, e poi c’era un altro quadro che arrivava dal deposito di Santa Maria Nuova.
Era una grande tavola dipinta in verticale su cui era raffigurata una donna nuda abbracciata a un grande cigno. Era una raffigurazione di un classico episodio della mitologia greca, quello secondo cui Zeus assunse le sembianze di un cigno per sedurre Leda, moglie del re di Sparta Tindaro, di cui era follemente innamorato. Da quell’unione carnale contro natura furono generate due uova, dalle quali nacquero due coppie di gemelli: i Dioscuri Castore e Polluce, Clitennestra ed Elena, la donna che fu all’origine della guerra di Troia.
Nello straordinario dipinto del maestro, anch’esso ormai quasi terminato, Leda era in piedi e abbracciava il collo del grande cigno accanto a sé che, a sua volta, con un’ala posata sul fianco della donna, ricambiava il gesto di affetto. In terra, da due grandi uova dischiuse uscivano i quattro bambini frutto di quell’unione illegittima.
In primo piano c’era un prato di fiori ed erbe riprodotti con una perfezione e una precisione assolute, mentre sullo sfondo un paesaggio di rocce e, oltre un piccolo lago artificiale, alcune case donavano profondità.
Per dipingere quella figura dalle curve tanto morbide e le forme così piene, un appunto di suo pugno mi rivelava che il maestro aveva preso a modelle le giovani donne che dimoravano presso un tale Jacomo Alfeo, alla Pusterla dei Fabbri, vicino a Porta Vercellina, non distante dalla sua vigna, dove probabilmente egli le aveva notate. Ebbi il dubbio che si trattasse di un lupanare e che questo Alfeo ne fosse il padrone e mi domandai se il maestro frequentasse anche quel genere di posti.
La testa e il volto della Leda, però, che si distoglie pudicamente dal cigno, mi ricordavano un viso che avevo già veduto: erano infatti gli stessi lineamenti che comparivano in un altro volto disegnato mostratomi dal maestro, quello della Scapigliata. Mi domandai se la donna con quel viso esistesse per davvero e se avesse un particolare significato per lui.
Per questi e forse altri motivi, trovavo quel dipinto straordinario. Era in effetti il suo primo quadro in cui vedevo un nudo integra...