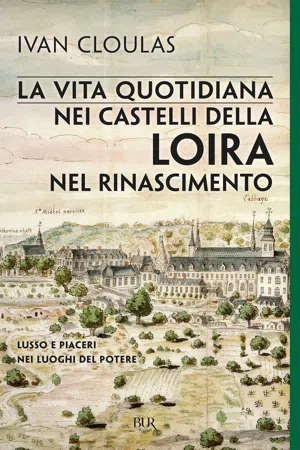Dopo l’improvvisa, violenta morte del re Enrico II, avvenuta il 10 luglio 1559, e l’ascesa al trono del giovane Francesco II, la corte di Francia, sconcertata, assistette a un nuovo, completo rivolgimento di poteri. Allontanata dal seguito del nuovo re, Diana di Poitiers fu costretta a cedere Chenonceaux alla regina vedova, Caterina.
La regina Caterina si vendica
L’ex favorita non si arrese senza battaglia: riteneva infatti che il suo diritto di proprietà fosse solidamente affermato, alla fine delle lunghe procedure che abbiamo descritto. Nell’ottobre del 1559, tre mesi dopo la morte del re, nonostante le pressioni esercitate su di lei dalla regina Caterina, Diana inviò il suo procuratore alla commissione per la riforma dei costumi di Turenna cui si proponeva di prendere parte come signora di Chenonceaux. La regina passò alle minacce. Il Consiglio reale aveva infatti constatato un deficit notevole delle finanze dello Stato e si pensò di colmarlo ordinando la restituzione dei doni concessi a privati da Francesco I e da Enrico II. Diana si sentì attaccata da questa misura e si mostrò attenta alla soluzione offerta da Caterina: scambiare il castello di Chenonceaux con quello di Chaumont. Esso apparteneva alla regina madre dal 31 marzo 1550, quando lo aveva acquistato per 120.000 lire da Charles-Antoine de la Rochefoucauld e da sua moglie Antoinette d’Amboise. Chaumont era allora un fiero edificio ricostruito, intorno al 1475, da Charles d’Amboise, fratello del cardinale ministro di Luigi XII.
Il dominio da esso dipendente era vasto e redditizio: almeno 4800 lire l’anno, il fitto dovuto nel XVI secolo. Chenonceaux rendeva la metà ma – anche a prezzo di una perdita pecuniaria – la regina madre si tolse la soddisfazione di scacciarne l’amante di suo marito e di occupare un castello splendidamente abbellito dai lavori realizzati proprio da Diana.
È possibile che in autunno, prima della conclusione dello scambio, Caterina avesse soggiornato a Chaumont. Era ancora scossa dal recente lutto e dal dolore per la partenza delle figlie, Elisabetta verso la corte del marito, Filippo II di Spagna, Claudia verso la Lorena in compagnia del marito, il duca Carlo III. Più tardi si diffuse la voce che avesse consultato un «veggente» in una torre del castello di Chaumont. Ne parlano o vi alludono Simon Goulart, Nicolas Pasquier, André Favin de Thou e Brantôme. Ma si tratta di resoconti di dubbia autenticità. Essi parlano sia di Nostradamus sia di Cosimo Ruggieri, ma è altamente improbabile che entrambi i personaggi potessero essere presenti a Chaumont a quell’epoca. In uno specchio magico sarebbero apparsi prima i figli di Caterina, quindi il loro successore, Enrico di Navarra, il futuro Enrico IV. Le immagini dei principi avrebbero fatto tanti giri intorno allo specchio quanti sarebbero stati gli anni del loro regno. Questo aneddoto fantasioso è sicuramente leggendario. Se Caterina si recò a Chaumont fu certamente per passare in rivista il suo antico dominio prima di cederlo a Diana. L’atto di scambio fu stipulato al castello di Blois. La corte vi si era ritirata all’inizio del novembre del 1559 dopo aver dimorato a Fontainebleau e a Saint-Germain: i medici di Francesco II gli avevano raccomandato il clima della Turenna «perché quella contrada aveva il migliore e più gentile clima del regno». Non ne conosciamo la data esatta. Comunque la transazione fu registrata alla presenza del re negli ultimi giorni del 1559, a opera dei notai Huguet e Aubert. Il cardinale di Lorena rappresentava la regina madre e François Marcel, consigliere del re, membro del suo Consiglio privato, la duchessa di Valentinois. Il fedele esattore di Chenonceaux, André Bereau, assistette all’atto in compagnia di un altro consigliere e maggiordomo ordinario del re, il signor de la Menardière. La ratifica ebbe luogo qualche mese più tardi al castello di Chinon: il 10 maggio 1560, ma Diana aveva incaricato il suo segretario Canette di prendere possesso di Chaumont fin dal 27 aprile. Tuttavia non andò mai ad abitarvi: si ritirò nei suoi domini di Limours, poi ad Anet, dove morì il 25 aprile 1566, a sessantasei anni e quattro mesi, bella come sempre.
Un lutto sontuoso
Nell’estate del 1559, mentre si trattava lo scambio di Chenonceaux, la corte di Francia inalberava superbe tenute da lutto e i conti reali ne serbano la traccia.
Il re Enrico II era appena morto quando la regina Caterina e le principesse chiamarono a corte due sarti, Jean Delaunay di Tours ed Édouard de la Catte. Il primo confezionò una veste di panno nero adorna di strisce di velluto, un’altra di satin grigio adorna di festoni di satin e catenelle d’oro, una terza di taffetà nero con cordoncini intrecciati con fili d’argento, una di satin nero adorna di velluto e ricamata con del cordoncino d’oro, una di serge di seta nera con passamaneria d’oro, le maniche coperte di bottoncini di fili d’oro intrecciati, una di satin nero con passamanerie d’oro e d’argento, una di taffetà nero gallonata e adorna di una striscia di mazzetti d’oro, un’altra ancora di velluto nero «tutta decorata con intagli a losanga» ricamata con cordoncino d’argento e adorna di bottoni d’oro, un’altra sempre di velluto ricamata con catenelle d’argento, cinque corpini «alla spagnola» traforati e ricamati, adorni di bottoni d’oro e di jais, una veste di taffetà nero adorna di taffetà ricamato a mazzetti d’oro (destinata alla giovane regina Elisabetta che si apprestava a raggiungere il marito Filippo II in Spagna), un’altra veste «di damasco nero a scaglie tutto intorno, tagliate a riquadri, con bordi di velluto e con cordoncini d’oro», un’altra sempre di velluto, con le maniche traforate, l’orlo adorno di mezze losanghe traforate, bordate d’oro e arricchite con satin bianco, un’altra ancora adorna di catenelle d’oro, due vesti di crêpe con frange d’oro arricciato, un’altra di taffetà nero con catenelle d’argento, un’altra ancora con passamaneria d’argento alle maniche gallonate, una di damasco bianco con corsetto e maniche di tessuto d’argento, quest’ultima forse in un primo tempo destinata alla regina Caterina che certamente la rifiutò perché non volle portare il lutto bianco tradizionale delle regine di Francia. Il conto di questo sarto comprendeva un’altra veste di velluto nero «con colletto alto traforato e decorato con un bordo di frange d’argento intrecciate», quindici corpini di velluto e damasco, di vari colori, ricamati d’oro e d’argento e infine altre due vesti, una di velluto e l’altra di satin nero.
Il tutto per 220 lire e 7 soldi. Il secondo sarto, Édouard de la Catte è iscritto nel bilancio reale per 62 lire 10 soldi e 2 denari. Fu incaricato di vari lavori: una veste di taffetà nero vellutato, con il collo «alla spagnola» adorno di seta nera e bianca, con cordoncini e fili d’argento, una veste di serge nero con maniche di seta e teletta nera, un grande mantello da sera di stamigna nera foderato di taffetà e adorno di seta, una veste con un «cuscinetto a crinolina (vertugale) di stamigna», un corpino di taffetà nero foderato di marocchino con una gonna analoga, una veste di stamigna con le maniche adorne di «traliccio di Germania», un paio di camiciole adorne di bottoncini di seta, una veste di serge di Firenze, una crinolina di taffetà, un mantello di stamigna da portare a cavallo, un mantello di serge di Firenze con le maniche asportabili, un’altra veste di stamigna e inoltre otto copricapi di taffetà, quattro paia di cappelli a corno, sei «mascherine» e quattro colletti.
Le fatture pagate ai sarti riguardavano solo la confezione delle vesti della regina e delle sue figlie. Il prezzo delle stoffe è invece riportato nel conto presentato da Catherine Pichonnat, vedova di Jean Dollu, mercante di stoffe: 1625 lire, 7 soldi e 6 denari, e in quello di Jean Després, un altro commerciante di stoffe, che ammontava a 5952 lire, 13 soldi e 6 denari. I due conti comprendevano le aune di tessuto consegnate alle dame della corte che dovettero a loro volta farsi confezionare vesti da lutto.
A parte l’abbigliamento della famiglia reale, vennero rinnovati i guardaroba di tutti i signori del seguito e gli abiti dei loro servi: la spesa totale ammontò a 31.891 lire e 10 soldi!
Il lutto, portato per mesi, cedette però a poco a poco il posto – all’arrivo a Blois – alla brillante vita di corte. Il giovane Francesco II, salito al trono, aveva assegnato ai fratelli minori un seguito personale.
Ognuno dei giovani principi ebbe così intorno a sé un vero seguito di cortigiani e una schiera di domestici.
Il seguito della principessa Margot
La futura regina Margot, che aveva allora sette anni, disponeva di un seguito degno del suo rango. Il conto delle spese della servitù conservato presso gli Archivi Nazionali, per un anno e mezzo, fino al dicembre 1560, enumera le persone addette al suo servizio: tre dame, fra le quali figura la governante, Charlotte de Vienne, signora di Curton, quattro damigelle d’onore, cinque cameriere che a loro volta avevano un’altra «donna» al loro servizio, un precettore, un elemosiniere, un cappellano, due chierici di cappella, tre segretari, due maggiordomi, due panettieri, due scalchi, due scudieri tagliatori, due scudieri di scuderia, due chirurghi, un farmacista, quattro valletti di camera, un sarto, due valletti di guardaroba, due uscieri di camera, due uscieri di sala, un maresciallo degli alloggi, tre furieri, due addetti alla dispensa con tre aiuti, quattro addetti alle cantine con tre aiuti, due scudieri di cucina, due capocuochi, due «ortolani», due addetti alla cura dello spiedo e due garzoni di cucina, un verduriere, due facchini, due inservienti di cucina, un pasticciere e il suo aiutante, un impastatore di pane, un guardaposate, tre addetti alla frutta e due aiuti, due addetti alla fureria, due lavandaie, un merciaio, due vasai, un macellaio, due valletti per le damigelle d’onore, un controllore e due chierici, un tesoriere.
In tutto un centinaio di persone seguivano ovunque la giovane principessa. Le spese per il mantenimento di questo personale erano per il primo anno di cui abbiamo la registrazione di 17.640 lire, per quello successivo di 19.000 lire. Bisogna aggiungere anche una ventina di addetti alle scuderie: due lacchè, quattro valletti appiedati, due palafrenieri e i loro due aiutanti, quattro mulattieri incaricati di occuparsi delle lettighe (chariots branlants) di Margherita, un maniscalco, un furiere di scuderia, un valletto per i paggi, un sellaio, un addetto al cibo per le cavalcature, pagati tutti con lire 1743 l’anno. A queste somme vanno aggiunte quelle necessarie al mantenimento di tre muli da lettiga, di tre cavalli che trainavano la carrozza (chariot) della principessa, di altri tre che tiravano quella della sua governante, due per la carrozza della camerista, due per la carrozza della «governante delle ragazze» e quattro che trasportavano i bagagli delle damigelle d’onore. Era ancora, comunque, un tenore di vita da ragazzi! Una decina d’anni più tardi, nel 1573, la regina avrà nelle sue scuderie quarantadue cavalcature. Nel 1560 le spese complessive di scuderia per un anno furono di ben 9230 lire e 2 soldi. Oltre al mantenimento delle cavalcature esse comprendevano l’abbigliamento delle damigelle d’onore, dei paggi e dei lacchè che si spostavano seguendo la principessa, i finimenti dei muli, dei cavalli da tiro e di quelli da montare, la decorazione delle lettighe di velluto nero e di satin nero e cremisi e bauli di cuoio per il trasporto degli effetti personali del seguito e della principessa. I mantelli, casacche (sayes), giubbe e altri capi d’abbigliamento dei paggi e dei lacchè ammontavano al prezzo di 429 lire, 17 soldi e 6 denari.
Le spese della piccola principessa erano a imitazione di quelle per il seguito della regina, così come quelle dei suoi fratelli. Tutta questa organizzazione era pronta nell’autunno del 1559. Effettuata la redistribuzione dei posti e delle cariche onorifiche, la corte si apprestò a riprendere, a Blois, il solito ritmo delle cerimonie e dei ricevimenti sontuosi: la regina madre, solidamente insediata nel suo potere e arricchita anche del bel dominio strappato alla rivale, avrebbe potuto godersi un meritato riposo.
La congiura degli scontenti
Nell’inverno del 1560, però, la regina Caterina non ebbe tempo di occuparsi della sua nuova proprietà di Chenonceaux. Il potere reale era minacciato: il giovane re Francesco II, diciassettenne, soffriva di una infezione cronica delle fosse nasali e delle orecchie. Era debole di carattere e dominato da Maria Stuart, la principessa inglese che aveva sposato pochi mesi prima di salire al trono. La giovane donna, maggiore di due anni, di temperamento vivace, seguiva fedelmente i consigli dei suoi zii materni, il duca Francesco di Guisa e il cardinale Carlo di Lorena, arcivescovo di Reims.
I principi di sangue reale Antonio di Borbone, re di Navarra, e Luigi, principe di Condé, non potevano tollerare a lungo quella intromissione nelle vicende interne dello Stato. I Guisa erano avversari feroci del partito protestante il cui capo era – al di fuori della casa di Borbone – l’ammiraglio di Francia Gaspard de Coligny, nipote del connestabile di Montmorency. Il Condé ordì una congiura nell’ottobre del 1559 al fine di allontanare definitivamente i Guisa dalla persona del re. La piccola nobiltà ugonotta dell’ovest e del sud della Francia si schierò numerosa agli ordini del «capitano muto», come si faceva chiamare segretamente il principe di Condé.
Per due generazioni gli appartenenti alla piccola nobiltà avevano vissuto nel benessere partecipando alle guerre che la Francia aveva continuamente condotto al di là delle Alpi. Dopo la pace di Cateau-Cambrésis del 1559, con la quale la Francia si ritirava definitivamente dall’Italia, essi avevano dovuto far ritorno ai domini di campagna dove vivevano molto modestamente. Le loro rendite fondevano al sole: l’arrivo massiccio in Europa dell’oro e dell’argento dell’America spagnola provocò, con l’aumento del denaro circolante, un rialzo dei prezzi di dimensioni catastrofiche. Dagli inizi del secolo, la moneta aveva perso il 50% del suo potere d’acquisto. Era necessario sempre più denaro liquido per acquistare di che vivere mentre le rendite fondiarie, che erano rimaste stabili ed erano espresse in una moneta di conto, la lira tornese, costituivano una fonte sempre più scarsa di denaro corrente. I nobili di provincia, accorrendo sotto la bandiera dei nemici dei Guisa, stringendosi nella Lega, speravano che i principi del sangue avrebbero rinunciato alla politica di pace con l’estero imposta alla Francia dalla Spagna: la ripresa delle guerre avrebbe dato loro la prosperità.
Il responsabile del reclutamento era un gentiluomo del Périgord, Jean du Barry, signore di La Renaudie. Attivissimo, si spostava per il regno sotto il falso nome di Laforêt e aveva allestito dei depositi di approvvigionamento per le truppe a Tours, Orléans e Châteaudun. Agli inizi di febbraio, aveva radunato a Nantes i capi delle varie bande del regno e aveva dato loro le ultime istruzioni: la congiura si era assicurata complicità a corte e i congiurati avrebbero potuto facilmente entrare nel castello di Blois.
Ma il piano, così bene ordito, fu sventato per un capriccio reale. Il giovane re lasciò Blois il 3 febbraio per andare a caccia nelle vaste foreste dei dintorni. I signori di alto rango lo seguirono: ma si sentivano minacciati e perciò si facevano inviare rapporti dalle loro spie. Il 18 febbraio, fra Montoire e Marchenoir, il duca di Guisa fu raggiunto dal suo segretario Milet, venuto appositamente da Parigi con l’avvocato Pierre des Avenelles che portava informazioni preoccupanti sui movimenti di La Renaudie.
Questi si era di recente recato a Parigi e si era stabilito presso l’avvocato, vicino a Saint-Germain-des-Près: Des Avenelles apparteneva come lui alla Chiesa riformata. La Renaudie, che per questo se ne fidava, ricevette i suoi emissari e gli fece capire che i congiurati sarebbero passati all’azione fra il 6 e il 10 marzo. L’avvocato, lealista e corrotto dalla speranza di una generosa ricompensa, non esitò ad avvertire Guisa.
La corte ripiega ad Amboise
Fu presa così la decisione di trasferire la corte ad Amboise la cui posizione solidissima permetteva una difesa assolutamente sicura. Fu necessario restaurare le stanze a lungo disabitate, ammobiliarle e rivestirne le pareti di arazzi. Il 22 febbraio l’insediamento era completato. Il duca di Guisa consigliò di chiamare a corte il principe di Condé e l’ammiraglio di Coligny per costringerli a rompere la solidarietà con i cospiratori. Solo Coligny accettò: egli in passato av...