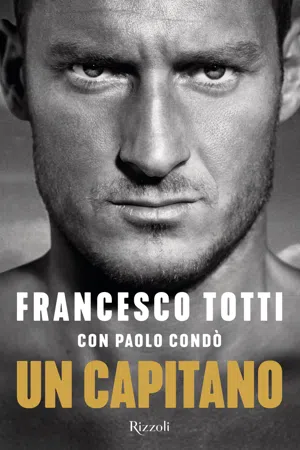Mio cugino Angelo mima gesti impazienti. «Vai! Vai!» sussurra, ma con la faccia di uno che sta urlando. Io sono totalmente paralizzato, pelle d’oca alta così, mi vorrei sotterrare per la vergogna.
L’altoparlante ha appena chiamato il mio nome per il premio di capocannoniere del torneo, è una bella sera d’estate e l’intera tribuna del campo della Fortitudo si è messa ad applaudire, saranno duemila persone. E io ho appena sei anni.
«Totti. Francesco.» Breve pausa del dirigente. «Ma dov’è andato? Francesco?»
Angelo mi batte le mani davanti al viso, come a dire ehi, svegliati, tocca a te. Gli rispondo con l’espressione brutta, quella che fa venire le rughe sulla fronte. Facile per lui, il mio amico d’infanzia più caro, figlio del fratello di mamma: ha sempre avuto la faccia tosta, soprattutto con gli adulti, e non soltanto perché è di dieci mesi più grande.
«Francesco!» Alla fine il dirigente mi ha visto, e mi chiama a voce alta, attirandomi con la sua manona, «Vieni, vieni», sembra che tutti ripetano due volte ogni parola, come se fossi tardo di comprendonio, e invece sono soltanto timido. Molto timido. Mi faccio forza, un bel respiro e salgo le scalette per arrivare in cima alla tribuna, lì dove i premi vengono consegnati.
Gioco nella Fortitudo da un annetto, è il campo sotto casa, nel cuore del quartiere. Tutti i bambini di Porta Metronia sono iscritti, così ogni estate viene organizzato un torneo, dodici squadre da otto giocatori, noi siamo il Botafogo e abbiamo vinto in finale sul Flamengo: il capitano è un altro, e quindi stasera sono venuto qui tranquillo, tanto sarebbe toccato a lui ritirare la coppa. Non sapevo che ci fossero pure i trofei individuali. Il dirigente mi consegna la targa, da qualche parte ci sono anche mamma e papà ma non li vedo, mentre Angelo – che ovviamente è in squadra con me – sorride soddisfatto perché pensa che io abbia vinto la timidezza. Macché. Vorrei ancora sprofondare, ma una volta che duemila paia d’occhi ti hanno individuato non puoi più fare finta di niente. Penso confusamente che sarebbe educato ringraziare, ma l’idea di parlare al microfono non è neanche considerabile. Tengo lo sguardo fisso a terra e appena avverto che la stretta di mano del dirigente si è un po’ allentata me la svigno, sperando che la gente sia già concentrata sulla premiazione successiva. Scendo veloce i gradini, riguadagno il campo e l’abbraccio protettivo dei miei compagni di squadra, qualcuno vuole guardare la targa, io mi piazzo proprio al centro del gruppetto, perfettamente nascosto. Un fischio segnala che l’altoparlante è di nuovo in funzione. La voce del dirigente è monocorde, non sembra cogliere la notizia: «Miglior giocatore del torneo: Totti Francesco». Oh, no.
Timido, certo. Silenzioso, soprattutto. Ci metto parecchio a parlare correttamente, quasi cinque anni: fatico a mettere assieme le sillabe, tanto che mamma mi porta regolarmente dal logopedista per capire se esiste qualche problema serio alla laringe. «Non si preoccupi» la rassicura lui dopo aver eseguito i vari test. «Francesco deve soltanto “partire”. Faccia conto una macchina col freno a mano tirato. Ecco, deve rilasciarlo.» Ha ragione. Come succede a tutti i bambini, una volta iniziato non ci penso più.
Ragionando a posteriori su quella ritrosia a esprimermi, è probabile che incidesse anche la tristezza per nonno Costante, il padre di mia mamma, che dopo l’amputazione di una gamba era venuto ad abitare con noi, e non stava bene. Aveva lavorato per tutta la vita alla manutenzione delle celle frigorifere, ed evidentemente gli sbalzi continui tra caldo e freddo gli avevano portato la cancrena. Dormivamo nella stessa camera e ogni sera, fingendo di essere già nel sonno, seguivo con crescente impressione gli sforzi di mia madre per sfilargli la protesi e posarla accanto al termosifone. Ai miei occhi lei gli tirava via la gamba, e la cosa mi spaventava moltissimo. Una notte, dopo aver atteso che nonno russasse, mi alzai e quatto quatto andai a toccare la protesi, scoprendo che era di legno. Tornai di corsa a letto, rischiando di svegliarlo, e nascosi la testa sotto il cuscino. Più avanti, quando già andavo a scuola, le sue condizioni si aggravarono e mamma chiese a una vicina, la signora Schibba, se poteva ospitarmi per qualche tempo: papà prese una poltrona-letto e la sistemò a casa sua, io andavo a scuola con Flavia e Roberta, le figlie della signora, e quindi mi trovai bene. Quando nonno Costante mancò, mamma, mettendo a posto le sue cose, mi fece vedere la tessera di socio vitalizio della Roma. Ne andava molto orgoglioso.
Mi capita spesso di rimanere a casa da solo. E sono un po’ fifone. Succede al mattino, perché papà va in banca a lavorare, mio fratello Riccardo è a scuola – ha sei anni di più – e mamma deve pur andare a fare la spesa. Si raccomanda di tutto e poi esce, io sono ancora a letto, e due minuti dopo aver sentito la chiusura della porta e i suoi passi sulle scale, cominciano le paure. Avverto una presenza nelle altre stanze, rumori strani, scricchiolii, qualcosa che struscia a terra, un suono attutito, forse metallico. Allora mi rannicchio sotto le coperte fingendomi morto, e penso che quando il ladro – perché certamente di là c’è un ladro – verrà a ispezionare la camera rimarrà sorpreso e intristito dalla presenza di un bambino morto, e se ne andrà. Come strategia è un po’ lugubre, ma funziona perché nessuno è mai entrato per controllare, o almeno nessuno ha mai alzato le coperte. Di più: quando mi convinco di averla scampata un’altra volta accendo il televisore – papà ne ha comprato un secondo, più piccolo rispetto a quello che abbiamo in salotto, e me l’ha piazzato in camera: regalone – cerco CHiPs, che è il mio telefilm preferito, e alzo il volume al massimo per non sentire più rumori inquietanti. Dopo qualche minuto mamma fa irruzione nella stanza trafelata, mica l’ho sentita rientrare, e abbassa di colpo: «Ma sei matto? Così diventi sordo!». Metto un po’ il broncio, ma in realtà sono felice di aver superato un’altra prova di solitudine, e soprattutto che lei sia tornata. (Detto fra noi, la paura non se ne è mai andata del tutto: ancora oggi, a casa, se di notte parte l’allarme io fingo di dormire e lascio che sia Ilary ad alzarsi per controllare…)
CHiPs mi piaceva perché conteneva i sogni dell’epoca: due poliziotti americani di pattuglia in moto sulle autostrade della California. Cosa puoi desiderare più di una Harley-Davidson? Al pomeriggio arrivavano prima Magnum, P.I. e poi, naturalmente, Holly e Benji: non conosco giocatori della mia generazione che da bambini non si siano divorati i cartoni dei piccoli calciatori giapponesi. Però erano anni in cui la strada esercitava un richiamo fortissimo, perché nel quartiere ci si conosceva tutti e le mamme si sentivano tranquille a lasciarti uscire, tanto c’erano decine di occhi a controllarti. Quelli dei negozianti di via Vetulonia, per esempio, che se non avevano clienti non rimanevano dietro ai banconi come succede oggi, ma si piazzavano sulla porta o direttamente fuori, sul marciapiede, e lì chiacchieravano fra loro, con i passanti e pure con noi bambini. I loro figli erano tutti miei amici. C’era Antonio, detto il Morto perché era sempre pallido, c’era Bambino, c’erano i due Giancarlo, Pantano e Ciccacci, e poi Marco e Sonia, i figli del barista, oltre ovviamente al mio inseparabile cugino Angelo. Una vera combriccola, ma di bravi ragazzi: mai combinato nulla di grave. Ehm, quasi mai.
Una volta, avrò avuto dodici anni, Angelo, Bambino e io scendiamo in strada senza pallone e vediamo che, all’interno del cortile della scuola, due fratelli stanno palleggiando. Non fanno parte della compagnia a pieno titolo perché si fanno vedere solo di tanto in tanto, devono avere genitori molto insistenti sullo studio. Però ci si conosce, e quindi diamo per scontato di poterci aggiungere: a quel punto ne mancherebbe soltanto uno per un bel tre contro tre. Invece quelli non ce la passano, pensa che soggetti: «Il pallone è nostro e voi non ci giocate», gnè gnè gnè, e più noi insistiamo più loro, scambiandosi sempre la palla con attenzione per tenerla fuori dalla nostra portata, si allontanano. Bambino è il più fumantino, quello che in certe situazioni prende l’iniziativa: recupera la catena con la quale lega la bicicletta al palo e comincia a passarla sulla cancellata della scuola, ottenendo un rumore sinistro. Ma i due sono proprio testardi, di mollare con le buone non ne vogliono sapere, e alla fine partono gli spintoni. Non c’è match, a quell’età conta quanto sei grosso ma anche quanto tempo hai passato in strada. I fratelli scappano lasciando il pallone lì, a nostra disposizione. Cominciamo a giocare felici di aver vinto quel braccio di ferro, e la lite è presto dimenticata. Da noi. Peccato che a fine pomeriggio, quando torniamo a casa, troviamo le mamme in attesa davanti al portone. Furibonde, mai viste così. Sono appena rientrate dal commissariato di via Cilicia. Per farla breve, i genitori dei fratelli antipatici hanno fatto un esposto per l’aggressione e il furto del pallone, e gli agenti – che ci conoscono – hanno convocato le nostre mamme per comporre la questione senza ulteriori denunce. Nell’accordo, oltre al costo della palla, c’è ovviamente la promessa di una solenne punizione, e per qualche giorno ci dobbiamo scordare i pomeriggi a zonzo per il quartiere. E non finisce qui, l’indomani a scuola ci aspetta il resto: sono in classe quando si sente bussare alla porta, è la professoressa Paracallo – un autentico donnone, insegna musica – che butta dentro la testa, si scusa con l’insegnante in cattedra e mi si rivolge con dolcezza sospetta: «Francesco, potresti uscire un attimo, per favore?». Non posso non andare, anche se sento puzza di bruciato. Infatti. Appena esco lei – fulminea – mi cattura un orecchio con la presa a due dita: con l’altra mano sta tenendo Angelo nello stesso modo, sorda alle sue proteste. Così, portati letteralmente per le orecchie, ci conduce in giro per l’intero istituto, senza risparmiarci un piano: nel frattempo suona la campanella dell’intervallo e tutti i ragazzi che escono dalle aule ci vedono e ridono. Devono esserci anche quei due dannati fratelli, lì in mezzo a sghignazzare. Vergogna assoluta, totale.
Naturalmente non è un caso che la peggiore delle mie “imprese” abbia avuto per oggetto un pallone. Papà mi ha raccontato che a soli otto mesi, in vacanza a Porto Santo Stefano, davo spettacolo spingendo con i piedi sulla spiaggia di sassi il Super Santos arancione che mi aveva regalato, primo di una lunga serie. Non per fare il fenomeno, ma di solito a otto mesi i bambini nemmeno camminano: io invece portavo a spasso il pallone, e pure su una superficie irregolare. Addirittura ci dormivo, mi hanno raccontato: niente giocattoli, nemmeno Jeeg Robot, che all’epoca andava a ruba. Solo il Super Santos, si vede che intuivo l’influenza che avrebbe avuto sulla mia vita.
Scendevo in strada ogni giorno. Tornavo da scuola – che voleva dire attraversare la via perché la Manzoni era proprio lì, davanti a casa –, mangiavo qualcosa e mi sedevo sul balcone a studiare, non per godermi il fresco ma perché appena individuavo un volto conosciuto potevo precipitarmi giù gridando a mamma che mi stavano aspettando tutti. «Hai studiato?» era l’anticamera della sua resa, perché io di rimando gli urlavo tre sì e subito dopo ero troppo lontano per sentire eventuali repliche.
La compagnia dei ragazzini era composta da una trentina di noi, e percepivamo il quartiere come fosse il più bello di Roma: popolare ma non povero, pieno di corti nelle quali giocare, e soprattutto animato dalla gente per strada a tutte le ore. La mia famiglia era molto estesa, la domenica capitava spesso di andare a trovare i parenti a Trastevere oppure a Testaccio: erano gite piacevoli, ma io mi sentivo veramente bene soltanto a Porta Metronia. Tanto calcio, tante corse, tanti scherzi innocenti: per un periodo ci fu la moda di suonare ai citofoni, e anziché scappare il divertimento consisteva nel rispondere usando un nome famoso. Io ero fissato con Gerry Scotti. «Chi è?» «Gerry Scotti!» e allora sì che me la davo a gambe. A calcio giocavamo in cortile ma anche in strada, perché non esisteva ancora l’orario continuato e alle due i negozi abbassavano la saracinesca regalandoci, a volte fino alle cinque, le migliori porte che potessimo desiderare. La gente non ne era felice, perché ogni pallone calciato violentemente contro le serrande provocava un rumore esagerato e le conseguenti proteste, ma nessuno di noi se ne curava. Giocavamo “alla tedesca”, ovvero con passaggi corti e al volo, classico esercizio da marciapiede per evitare che la palla vada in strada. Nell’anno dello scudetto abbiamo segnato un gol così, al Perugia: tanti tocchi sotto porta senza che il pallone cadesse mai a terra. Il problema più grave lo avevamo quando il cortile della scuola era chiuso e la palla ci finiva dentro. Toccava citofonare al custode, tipo un po’ burbero, sperando di trovare suo figlio Gigi, nostro coetaneo: un ragazzo che non usciva quasi mai, molto solitario ma buono e gentile nell’animo, altro che i due fratelli della denuncia. Si sobbarcava sempre la seccatura di recuperarci il pallone, una, due, tre volte a pomeriggio. Gli volevo bene, per questo.
Non è semplice individuare il momento preciso dell’infanzia nel quale mi sono reso conto del talento, perché è sempre stato così, fin da Porto Santo Stefano. Voglio dire che non si tratta di un superpotere arrivato a me per qualche disegno del destino, come succede nei fumetti, ma di un’abilità innata. Forse una prima forma di consapevolezza è arrivata con Paperelle, il gioco di mira che impari da bambino. Una fila di ragazzi si dispone in cima a una scalinata – noi ci divertivamo davanti alla Manzoni – e al via si muove prima in orizzontale e poi, scendendo i gradini, in diagonale fino alla base. Distante una decina di metri, il tiratore tiene davanti a sé alcuni palloni, con i quali deve colpire appunto le “paperelle” prima che abbiano completato il loro percorso. È un esercizio semplice solo in apparenza, perché devi centrare una serie di bersagli in movimento mantenendo la calma man mano che si avvicinano a fine tragitto e il tempo comincia a scarseggiare. I palloni a disposizione di un gruppo di ragazzini, poi, sono diversi tra loro: c’è quello di cuoio pieno d’aria, quello sgonfio, quello di plastica, quello da pallavolo… Devi colpire ciascuno con la giusta forza, che non è mai uguale. Be’, la prima volta che ci provo – avrò avuto cinque o sei anni – centro tutti i bersagli.
A ripensarci adesso, ricordo l’incredulità sui volti di Angelo e degli altri. «Rifallo» dice qualcuno, e io ripeto l’esercizio sbagliando però un tiro. Sento la rabbia crescermi dentro, perché sono molto competitivo e, se perdo, pure un po’ rosicone; avverto che quell’errore, l’unico a fronte di una dozzina di colpi andati a segno fra prima e seconda serie, rischia in qualche modo di sporcare la prestazione. È l’espressione sulla faccia di Angelo, come sempre, a dirmi che lo stupore non s’è annacquato nemmeno un po’. Allora provo un’emozione tra l’allegria e l’incredulità: mi sembra troppo bello per essere vero, ma ho la sensazione di saper fare bene il gioco che più mi appassiona.
Nel corso della carriera mi è stato ripetuto più volte che la fortuna mi ha baciato in fronte. Quando entra in confidenza con qualcuno, mia madre si spinge però a raccontare di un altro bacio, e devo dire che persino io stenterei a crederle, se il suo racconto non fosse avvalorato da una fotografia. La storia risale alla prima elementare, quando l’intera scuola viene ammessa a un’udienza papale in Vaticano, nella celebre sala Nervi. Spingendo e sgomitando, mamma riesce a guadagnare la transenna, lì dove è certa di trovarsi a un passo da Giovanni Paolo II; e quando il papa compare all’inizio del percorso che lo condurrà davanti a lei, mi prende in braccio. Sono vestito con una tuta così gialla che sembra la divisa sportiva del Vaticano, e sono biondissimo: un autentico angioletto, insomma. Quando mi passa accanto il papa, che sta accarezzando i bambini protesi dalle braccia delle madri, mi dedica un leggero tocco della mano sui capelli, e mi pare già tanto. Procede altri due metri e poi, improvvisamente, si ferma. Si blocca anche mamma, che stava per posarmi a terra. Giovanni Paolo II si volta, torna indietro di due passi, si china su di me e mi bacia in fronte. Non so come ci riesca, ma mia madre per fortuna non perde i sensi, e così non rovino a terra. L’amica che la accompagna comincia a gridare: «Fiorella! Il papa ha scelto Francesco! È tornato indietro per baciarlo!», e mentre scoppia il caos nel giro delle madri della mia classe, qualcuno le sfila il portafogli dalla borsa. L’attenzione collettiva si sposta rapidamente sul furto, che viene scoperto quasi in diretta, ed è un bene perché il dietrofront del papa ha prodotto in mamma un vero choc. Ancora oggi, quando torniamo sull’argomento, lei sostiene la tesi che quel giorno io sia diventato in qualche modo il Prescelto, come in America chiamano LeBron James. La mia carriera starebbe lì a dimostrarlo. La storia è suggestiva, e avvalorata dalla foto che venne scattata in quell’istante; ma il Signore ha cose più importanti di cui occuparsi della diffusione del talento calcistico. Giovanni Paolo II mi baciò in fronte perché ero biondo e indossavo una bella tuta gialla. Fine della storia.
A Paperelle divento rapidamente imbattibile. Non sbaglio mai un colpo, per divertirci dobbiamo giocare a squadre con i più scarsi sempre al mio fianco, in modo che io debba preoccuparmi non soltanto di centrare i miei bersagli, ma anche di correggere i loro errori. Eppure vinco lo stesso, eliminando i miei prima che arrivino a metà strada e dedicandomi poi agli altri. La perizia è data da due fattori. Il primo è il colpo secco: la palla rimane attaccata al collo del piede per una frazione di secondo soltanto, e subito parte una traiettoria molto tesa e veloce, se anche volesse il bersaglio non farebbe in tempo a scansarsi. Ho segnato un gol così all’Inter, qualche anno fa a San Siro, su passaggio di Gervinho: palla molto secca nell’angolino dal limite dell’area, uno degli ultimi gol proprio belli, il primo di un 3-0. Il secondo fattore è la capacità di controllare in un istante i palloni che arrivano da chi deve raccoglierli, e li lancia alla rinfusa nella zona di tiro. Quasi tutti sprecano tempo a rincorrerli, perché hanno sbagliato lo stop e la palla è schizzata via lontana. A me non succede, grazie alla tecnica, e nelle gare a squadre i secondi guadagnati in questo modo sono decisivi.
Vincere è bellissimo, ma quello che mi piace veramente è sentire addosso la fiducia dei compagni, sicuri del risultato quando sono in squadra con me. La responsabilità non è mai stata uno stress, fin dai giorni di Paperelle, e ci sono stati alcuni calci di rigore in partite importanti nei quali il pensiero, prima della battuta, è tornato al cortile della scuola. Ma questo ve lo racconterò più avanti. E giuro che anche ai tempi di via Vetulonia l’emozione si faceva sentire. L’emozione, e la prospettiva del guadagno economico: papà mi allungava ogni giorno mille lire per la merenda, e io le risparmiavo perché quando ci giocavamo il gelato vincevo sempre. Ero una tale sentenza che, quando una volta mi successe di perdere, spesi una fortuna perché tutti se ne approfittarono: nessun Arcobaleno, il ghiacciolo che costava meno, tanti Twister, panna e cioccolato, roba da ricchi. E quando gli ricapitava l’occasione…
Credo che il primo ad aver percepito la dimensione del mio talento sia stato proprio papà Enzo. Diminutivo di Lorenzo, ma lo chiamano Sceriffo perché ama tenere tutto sotto controllo, e di qualsiasi cosa uno abbia bisogno, tempo mezz’ora e lui la procura: insisteva sempre per portarmi a piazza Epiro, dove c’è il mercato, perché lì giocavano i ragazzi più grandicelli, e quindi il test era più duro. Mi accompagnava in piazza e, sapendomi timido, chiedeva direttamente lui se potevo aggregarmi. All’inizio c’era qualche reticenza, mi vedevano piccolo e temevano di farmi male, ma a un adulto è difficile dire di no. Così venivo aggiunto a una formazione e in breve, davanti allo sguardo sornione e soddisfatto di papà, succedeva che la partita venisse interrotta perché il mio ingresso l’aveva squilibrata. «Rifamo le squadre», e immancabilmente il primo chiamato ero io. Anzi, chiamavano Gnomo, il mio soprannome di quegli anni perché di crescere non ne volevo sapere e mamma, dopo avermi portato dal medico e avergli chiesto con una certa grinta – manco fosse colpa sua – perché diavolo fossi ancora così piccino, cominciò a propinarmi la pappa reale. All’epoca andava di gran moda, una specie di pozione magica del druido di Asterix, ma al palato era un’autentica schifezza. Meglio la carnitina, altro prodotto per la crescita che aveva almeno il pregio del gusto all’amarena. Quando ho letto dei problemi che Messi ha superato da bambino in Argentina, mi sono sentito molto solidale. Io sono “partito” a dodici anni, e Gnomo è finito in fretta nel baule dei soprannomi dimenticati.
Quando passi tante ore per la strada diventi inevitabilmente un figlio del quartiere, nel senso che tutti ti conoscono, perdonano le tue sciocchezze – i gavettoni ai conducenti dell’Atac, che non avevano l’aria condizionata e d’estate viaggiavano con i finestrini abbassati –, controllano che non ti metta nei guai e ti trattano con affetto. Per esempio il tappezziere che aveva il negozio accanto al mio portone, il signor Corazza, quando fummo tutti un po’ cresciuti cominciò a interrompere le partite per proporci dei lavoretti discretamente retribuiti: cinquecento lire per portare una poltrona al pianoterra, mille per un divano al secondo piano, e faceva in modo che ce ne fosse per tutti perché noi quei lavoretti ce li saremmo strappati l’uno con l’altro, i soldi cominciavano a fare comodo. Io li spendevo soprattutto al flipper, perché nel bar del signor Lustri ero il primatista su tutte le macchi...