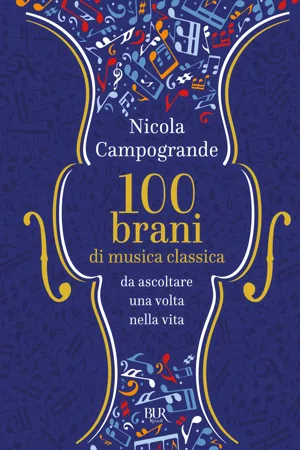
- 256 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
100 Brani di musica classica da ascoltare una volta nella vita
Informazioni su questo libro
Quello della musica classica è un universo vasto e pieno di bellezza, che a prima vista può disorientare ma che, con la giusta guida, può essere scoperto in tutta la sua meraviglia. In queste pagine Nicola Campogrande - compositore di fama internazionale e grande divulgatore - indica al lettore quali sono i 100 brani che vanno ascoltati almeno una volta nella vita, spaziando dalle origini alla musica degli autori viventi. Da Monteverdi a Bach, da Stravinskij a Pärt, passando per Mozart, Beethoven, Verdi, Schubert, Bartók, sfilano tutti i più grandi compositori dal 1300 a oggi, e ciascun brano preso in esame è presentato in modo semplice ma esauriente, con aneddoti sulla vita dell'autore e riferimenti alla nascita dell'opera. Un'introduzione chiara e appassionante da leggere e ascoltare, in cui ogni brano rappresenta un affascinante tassello di quel meraviglioso mosaico che è la musica classica.
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Informazioni
Guillaume de Machaut (1300-1377)
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
Carlo Gesualdo da Venosa (ca. 1560-1613)
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione
- Nota sui titoli dei brani
- 100 Brani di musica classica da ascoltare una volta nella vita
- 1. Guillaume de Machaut (1300-1377). Messe de Nostre Dame
- 2. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). Missa Papae Marcelli
- 3. Carlo Gesualdo da Venosa (ca. 1560-1613). Madrigali
- 4. Claudio Monteverdi (1567-1643). Vespro della Beata Vergine
- 5. Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Secondo libro di toccate
- 6. Henry Purcell (1659-1695). Fantasy upon One Note
- 7. François Couperin (1668-1733). Pièces de clavecin
- 8. Antonio Vivaldi (1678-1741). Le quattro stagioni
- 9. Jan Dismas Zelenka (1679-1745). Missa Dei Filii
- 10. Georg Philipp Telemann (1681-1767). Tafelmusik
- 11. Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Pièces de clavecin en concerts
- 12. Georg Friedrich Händel (1685-1759). Messiah
- 13. Johann Sebastian Bach (1685-1750). Concerto Brandeburghese n. 3
- 14. Johann Sebastian Bach (1685-1750). Suites per violoncello solo
- 15. Domenico Scarlatti (1685-1757). Sonate per clavicembalo
- 16. Karl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Concerto per il cembalo concertato n. 1 in fa maggiore Wq. 43
- 17. Franz Joseph Haydn (1732-1809). Quartetto in re maggiore op. 76 n. 5
- 18. Luigi Boccherini (1743-1805). Quintetto per archi in mi maggiore op. 13 n. 5
- 19. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Concerto per clarinetto e orchestra
- 20. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Sinfonia n. 41 “Jupiter”
- 21. Ludwig van Beethoven (1770-1827). Sinfonia n. 3 “Eroica”
- 22. Ludwig van Beethoven (1770-1827). Concerto per pianoforte e orchestra n. 4
- 23. Ludwig van Beethoven (1770-1827). Sinfonia n. 9 “Corale”
- 24. Carl Maria von Weber (1786-1826). Concerto per clarinetto e orchestra n. 1
- 25. Franz Schubert (1797-1828). Sinfonia n. 8 D. 759 “Incompiuta”
- 26. Franz Schubert (1797-1828). Die schöne Müllerin
- 27. Hector Berlioz (1803-1869). Sinfonia fantastica
- 28. Felix Mendelssohn (1809-1847). Sinfonia n. 4 “Italiana”
- 29. Fryderyk Chopin (1810-1849). Notturni
- 30. Robert Schumann (1810-1856). Dichterliebe
- 31. Robert Schumann (1810-1856). Concerto per pianoforte e orchestra
- 32. Franz Liszt (1811-1886). Studi d’esecuzione trascendentale
- 33. Richard Wagner (1813-1883). Preludio e morte di Isotta
- 34. Giuseppe Verdi (1813-1901). Messa da Requiem
- 35. César Franck (1822-1890). Sonata per violino e pianoforte
- 36. Bedrich Smetana (1824-1884). La Moldava
- 37. Anton Bruckner (1824-1896). Sinfonia n. 8
- 38. Johann Strauss figlio (1825-1899). Sul bel Danubio blu
- 39. Johannes Brahms (1833-1897). Sonata per violoncello e pianoforte n. 2
- 40. Aleksandr Borodin (1833-1887). Nelle steppe dell’Asia centrale
- 41. Camille Saint-Saëns (1835-1921). Il carnevale degli animali
- 42. Modest Musorgskij (1839-1881). Quadri di un’esposizione
- 43. Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893). Sinfonia n. 6 “Patetica”
- 44. Antonín Dvořák (1841-1904). Concerto per violoncello e orchestra n. 2
- 45. Edvard Grieg (1843-1907). Suites da Peer Gynt
- 46. Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908). Sheherazade
- 47. Gabriel Fauré (1845-1924). Requiem
- 48. Leoš Janáček (1854-1928). Quartetto n. 1 “Sonata a Kreutzer”
- 49. Ernest Chausson (1855-1899). Sept Mélodies op. 2
- 50. Edward Elgar (1857-1934). Variazioni “Enigma”
- 51. Hugo Wolf (1860-1903). Lieder
- 52. Isaac Albéniz (1860-1909). Iberia
- 53. Gustav Mahler (1860-1911). Sinfonia n. 1
- 54. Claude Debussy (1862-1918). Prélude à l’après-midi d’un faune
- 55. Richard Strauss (1864-1949). Quattro ultimi Lieder
- 56. Paul Dukas (1865-1935). L’apprendista stregone
- 57. Jean Sibelius (1865-1957). Valse triste
- 58. Erik Satie (1866-1925). 3 Gymnopédies
- 59. Aleksandr Skrjabin (1872-1915). 24 Preludi per pianoforte op. 11
- 60. Sergej Rachmaninov (1873-1943). Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
- 61. Arnold Schönberg (1874-1951). Verklärte Nacht
- 62. Gustav Holst (1874-1934). I pianeti
- 63. Charles Ives (1874-1954). The Unanswered Question
- 64. Maurice Ravel (1875-1937). Bolero
- 65. Maurice Ravel (1875-1937). Ma mère l’Oye
- 66. Fritz Kreisler (1875-1962). Liebesleid
- 67. Manuel de Falla (1876-1946). Siete canciones populares españolas
- 68. Ottorino Respighi (1879-1936). Pini di Roma
- 69. Béla Bartók (1881-1945). Danze popolari rumene, per piccola orchestra
- 70. Béla Bartók (1881-1945). Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
- 71. George Enescu (1881-1955). Rapsodia romena n. 1
- 72. Igor Stravinskij (1882-1971). Le sacre du printemps
- 73. Zoltán Kodály (1882-1967). Musica corale
- 74. Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Bachianas brasileiras n. 5
- 75. Bohuslav Martinů (1890-1959). Divertimento per pianoforte (mano sinistra) e piccola orchestra
- 76. Sergej Prokof’ev (1891-1953). Sonata per violino e pianoforte n. 2
- 77. Darius Milhaud (1892-1974). Le boeuf sur le toit
- 78. Federico Mompou (1893-1987). Canciones y Danzas
- 79. Paul Hindemith (1895-1963). Six chansons per coro a cappella su testi di Rilke
- 80. George Gershwin (1898-1937). Rhapsody in Blue
- 81. Francis Poulenc (1899-1963). Sonata per clarinetto e pianoforte
- 82. Aaron Copland (1900-1990). Rodeo, suite dal balletto
- 83. Joaquín Rodrigo (1901-1999). Concierto de Aranjuez
- 84. William Walton (1902-1983). Façade
- 85. Dmitrij Šostakovič (1906-1975). Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
- 86. Olivier Messiaen (1908-1992). Quatuor pour la fin du temps
- 87. John Cage (1912-1992). Sonatas and Interludes per pianoforte preparato
- 88. Benjamin Britten (1913-1976). Serenata per tenore, corno e archi
- 89. Leonard Bernstein (1918-1990). Ouverture da Candide
- 90. Astor Piazzolla (1921-1992). Las cuatro estaciones porteñas, per violino e orchestra d’archi
- 91. György Ligeti (1923-2006). Lux Aeterna
- 92. Luciano Berio (1925-2003). Quattro versioni originali della “Ritirata notturna di Madrid” di Luigi Boccherini sovrapposte e trascritte per orchestra
- 93. Arvo Pärt (1935). Fratres
- 94. Steve Reich (1936). Music for 18 Musicians
- 95. John Adams (1947). Harmonielehre
- 96. Heiner Goebbels (1952). The Horatian – Three Songs
- 97. Michael Daugherty (1954). Metropolis Symphony
- 98. Tan Dun (1957). Water Concerto, per percussioni ad acqua e orchestra
- 99. Giovanni Sollima (1962). Violoncelles, vibrez!
- 100. Jaakko Mäntyjärvi (1963). Canticum calamitatis maritimae
- Glossario
- Indice alfabetico degli autori
- Copyright