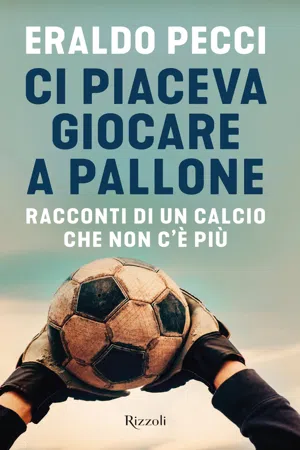Era il 6 gennaio del 1963, giorno della Befana. Avevo sette anni. A Cattolica, dove vivevo, era appena nata una società calcistica denominata Superga 63. Superga in onore e ricordo della tragedia nella quale perì tutta la squadra del Torino, il Grande Torino di Valentino Mazzola e i suoi impareggiabili compagni; 63 in quanto anno di fondazione del nuovo club.
Cattolica ai tempi era un bel paese affacciato sul mare Adriatico e, oltre alla pesca, aveva cominciato da qualche anno a vivere di turismo. Erano già attivi degli alberghi e altri stavano per essere costruiti. Noi paesani intanto affittavamo le camere delle nostre case. Se le affittavamo tutte, e in agosto succedeva, ci ritiravamo a dormire in cantina, altrimenti ci si stringeva in quattro o cinque in una stanza o si mettevano dei letti in sala da pranzo, persino in cucina. Poi, durante l’inverno, ci si costruiva da soli qualche stanza, aggiungendola sopra o di fianco alla casa esistente, e così, anno dopo anno, “gronde” di sudore e olio di gomito, cambiale dopo cambiale, condono dopo condono, sono nate pensioncine e alberghetti che hanno rappresentato il turismo in Romagna per molti anni. Diversi esempi di quelle costruzioni sono ancora lì a fungere da testimoni.
Nel dopoguerra le coppie italiane sfornavano figli, c’era lavoro, fiducia nel domani e le famiglie numerose erano la regola. Anche a Cattolica noi bambini eravamo in molti e il calcio era lo sport di gran lunga più praticato. Bastavano uno spicchio di terra e un pallone e si poteva giocare tutti, passando pomeriggi indimenticabili.
Organizzando il torneo della Befana, il Superga 63 mirava ad accaparrarsi dei calciatori in erba da vestire in futuro con la sua casacca. Il club indossava infatti solo casacche, non possedeva maglie: casacche nelle quali quando correvi si infilava il vento gonfiandoti la schiena e rendendo la corsa più difficoltosa. Ancora non sapevo che a Torino la Juve era conosciuta come la goeba (la gobba) proprio per questa ragione!
In paese c’era già il Cattolica Football Club e molti bambini erano iscritti là. Prima di aver compiuto dieci anni non si poteva comunque giocare in campionati ufficiali, ma i dirigenti del Superga avevano pensato che, seminando per tempo, avrebbero poi raccolto dei frutti se fossero riusciti a fidelizzare qualche “promessa”. Quel giorno io giocavo in casa; il torneo era stato organizzato nel campo in cui mi “esibivo” tutti i giorni (a quei tempi ero davvero bravo e, quando si formavano le squadre, anche con quelli più grandi, venivo sempre scelto tra i primi): ne conoscevo centimetro per centimetro i circa sessanta metri di lunghezza e i trenta di larghezza. Era noto come “il campo dei frati”, tutto in terra battuta, molta polvere e qualche sasso. A soli trenta centimetri da uno dei lati del campo c’era un muretto di cemento alto circa mezzo metro. Tirare un fallo laterale senza mettere i piedi sulla riga, peraltro spesso immaginaria, non era facile. Il muretto era assai pericoloso, cadere, sbatterci la testa e restarci secchi una possibilità concreta: tuttavia non è mai successo e a me quel campetto sembrava meglio del Maracanã.
Il torneo della Befana era, diciamo così, la mia prima uscita ufficiale e mi aggiudicai la coppa per il miglior giocatore e la targa di capocannoniere, portando la mia formazione alla vittoria finale. Mio fratello Maurizio, dodici anni, spettatore a bordo campo, era fiero di me. Eravamo molto uniti e mi portava sempre con sé senza sbuffare come facevano i suoi coetanei con i fratelli minori, trasmettendomi un senso di protezione che ho sempre apprezzato.
Quando quella sera arrivai a casa appoggiai i trofei sul tavolo della cucina e andai a recuperare la calza che la notte prima la Befana mi aveva riempito: una cedrata, una aranciata, qualche mandarino, caramelle, cioccolatini, boeri, torroncini e l’immancabile dose di carbone. Non quello di zucchero, ma carbone vero. Si usava così. Pensavo che la vecchia signora con la scopa non avrebbe di certo potuto lavorare per la Disney vista la poca fantasia di cui era dotata – tutti gli anni mi portava le stesse cose! Ma andava bene lo stesso. Però la vecchietta doveva essere anche un po’ rincoglionita, e ne aveva ben donde data l’età, perché io mettevo da sempre nel camino una calza di mio fratello, molto più grande e capiente della mia, e lei non se ne era mai accorta. Pensai che l’anno successivo le avrei facilitato il compito chiedendole una cosa ben precisa: una bacheca. Considerando i trofei che avevo appena vinto e quelli che nel tempo mi sarei aggiudicato, mi sarebbe proprio servita. Altrimenti l’avrei chiesta a quell’altro, quel vecchietto suo amico, Babbo Natale. Insomma, ragazzi, fuori la bacheca. Perché non avevo dubbi: da grande avrei fatto il calciatore.
La nostra casa a Cattolica era bella, ad appena cento metri dal mare e, particolare più importante, si trovava vicino al campo dei frati. In realtà la casa era dello zio Giuseppe, il fratello di mia nonna, che, rimasto vedovo, ci chiese di dividerla con lui. Due camere, cucina e bagno. Avevo circa quattro anni e dormivo con lo zio. Al piano superiore c’era un appartamentino che d’estate affittavamo, sotto una spaziosa cantina.
La mia famiglia abitava già a Cattolica, ma sopra l’officina dove riparavano i camion, in una casa più piccola. Che era comunque già meglio di quella di San Giovanni in Marignano, dove stavamo ancora prima, e dove il tetto lasciava passare parte della pioggia che il cielo mandava giù. Eravamo ricchi di dignità e gioia di vivere, ma di soldini ne giravano pochi. Il babbo, Gino, faceva il camionista e spesso ci raccontava di viaggi epici. Trasportava il pesce che ogni mattina doveva essere sui banchi del mercato, per cui bisognava arrivare sempre puntuali, anche se, come gli era successo più volte, si rompeva la frizione o succedeva qualche altra cosa. Certo non doveva essere una passeggiata arrivare da Rimini a Chioggia o a San Benedetto del Tronto con le strade di allora, senza poter disporre di molto tempo e di un veicolo in ordine.
Lo zio Giuseppe (Jusfen) era un tassista e possedeva la licenza comunale numero 3. Era un uomo d’altri tempi, nato a fine Ottocento, che non aveva avuto figli e che, quando la moglie Enrica lasciò questa terra, si sentì troppo solo e noi diventammo la sua nuova famiglia. Lui e il mio babbo erano legati da un grande affetto, anche se non sembrava quando parlavano di politica. Le idee dello zio democristiano e del babbo comunista non coincidevano mai e, a volte, i toni della discussione si alzavano nonostante le raccomandazioni della mamma che si preoccupava di cosa potessero pensare i vicini.
Per qualche tempo il babbo lasciò il camion e prese il posto dello zio a bordo della Fiat 1400 nera che fungeva da taxi. Ma il taxi d’inverno in riviera era spesso fermo al parcheggio, così il babbo riprendeva il camion.
Ricordo dei pomeriggi quando trasportavamo del materiale, credo sassi e sabbia, al cantiere dove si stava costruendo l’autostrada denominata poi A14. Il camion aveva il motore in mezzo ai due sedili, ricoperto da pannelli di ferro, e io immaginavo fosse il mio cavallo. Quando il babbo mi permetteva di stare in sella, io ero felicissimo. Altro che cinture di sicurezza! In realtà ero sempre felice. Davanti casa nostra, quei cento metri che la separavano dal mare non erano asfaltati e quando passava qualche veicolo si alzava un gran polverone. Ma appena cominciarono a sorgere bar, alberghi e ristoranti, il catrame per l’asfalto arrivò presto e il problema polvere risolto. D’estate, quando si andava a fare il bagno al mare, spesso si usava come salvagente la camera d’aria dello pneumatico di un camion. Poco elegante ma pratico.
Nell’aria si respiravano profumi gradevolissimi, pizza, pesce, salsicce. A me piaceva specialmente quello di pizza ed era una festa quando potevo gustarmela. Ma all’epoca al ristorante non si andava mai, al massimo una aranciata al bar quando venivano i parenti da lontano. Tanti anni dopo mio padre portò mia madre in una trattoria vicino alla stazione. Un suo conoscente li vide e disse al babbo: «Ciao Gino, bella la vita, sempre al ristorante…». In più di trent’anni di matrimonio era la prima volta che i miei pranzavano fuori. Anche al cinema erano andati una sola volta, ma non si lamentavano mai di niente. La loro era una generazione che pensava solamente a lavorare. In particolare la mamma, che aveva quattro uomini a cui pensare: puliva la casa, cucinava, lavava, stirava, cuciva, aggiustava i vestiti, faceva la spesa e quant’altro. Per esempio, io ricordo di avere raramente posseduto un vestito nuovo da bambino. Portavo molta roba usata da mio fratello più grande e riadattata per me. Sempre da lei, la mamma. Quante volte l’ho vista a tarda notte, al lume di candela, terminare ciò che non era riuscita a finire di giorno. Pensava sempre a noi e mai a lei. Sembrava la protagonista di una pagina del libro Cuore.
Mio fratello Maurizio aveva quattro anni più di me, per cui i suoi vestiti smessi stavano poco nel cassetto prima di essere indossati da me. Eravamo sempre assieme Maurizio e io. Lui era un bambino robusto, ricco di forza. Fisicamente era dotatissimo. Eccelleva allo stesso modo sui cento metri piani, nel salto in alto, nel lancio del peso e tiro alla fune. Un atleta a tutto tondo. Ero contento di stare sempre con lui e mi infondeva un gradevole senso di sicurezza.
Più avanti, tanto per gradire, la mamma pensò anche di regalarci un altro fratellino, Enrico. Era bella, mamma Leonilde, conosciuta da tutti come Leda. Nonostante il nome lei non sapeva niente di cigni. Aveva frequentato solo le scuole elementari. Piccola, mora, un gran bel carattere e una pazienza smisurata. Riusciva a smussare gli angoli più appuntiti col sorriso sulle labbra. Mai sentito i miei genitori litigare. Anche il babbo era un bell’uomo, con i suoi capelli scuri e gli inseparabili baffi nerissimi che servivano anche a coprire una vecchia cicatrice. Lui non aveva terminato neppure la prima elementare, perché doveva “governare” le bestie della fattoria assegnata alla sua famiglia a mezzadria. A casa non c’era mai, era sempre al lavoro e noi lo vedevamo giusto per pranzo e cena.
Qualche volta la mamma ci portava a vedere la tv (Lascia o raddoppia? Domenica è sempre domenica?) al ristorante di una sua parente, poco lontano da casa, e lo zio le raccomandava la massima prudenza visto che dovevamo attraversare la strada nazionale, la vecchia via Emilia, dove viaggiavano molti mezzi pesanti. Lo zio era così in pensiero che, non molto tempo dopo, ci fece trovare una tv nuova di zecca in casa. Così conobbi Lassie, Rin Tin Tin e la tv dei ragazzi. Ma la sera prima di cena, quando si faceva l’ora per lo zio di recitare il rosario, noi bambini con la mamma eravamo tenuti a partecipare. Lo snocciolava in latino e, di certo, non l’aveva imparato a scuola neppure lui. Ovviamente del babbo, stalinista convinto, mai vista neanche l’ombra. Poi andavano in onda Non è mai troppo tardi, col maestro Manzi, il telegiornale e Carosello, che per me significava “Buonanotte”.
Visto che abitavamo in centro dove in estate i turisti giravano numerosi, avevo trovato il modo di raggranellare un po’ di soldi. A ogni richiesta di informazione, in genere indicazioni su dove si trovassero cinema, alberghi, locali da ballo, dicevo di seguirmi. Una volta arrivati sul posto nessuno negava una mancia. Ricordo in special modo che esistevano diverse arene, cinema all’aperto, dove la gente andava a vedere i film che si era persa d’inverno, o a rivedere quelli che erano più piaciuti, accarezzati da un filo di brezza serale. Erano locali assai frequentati ed è un peccato che siano scomparsi quasi tutti, si trattava di un servizio che la gente apprezzava.
Un giorno lo zio e il babbo ci dissero che avremmo cambiato casa. Dovevano aver realizzato un bel gruzzolo dalla vendita di quella vecchia, dato che ne comprarono una molto più grande, ed erano anche rimasti dei soldi in banca. Ci saremmo trasferiti fuori città, in pratica a seicento metri di distanza in linea d’aria, solo che la nuova abitazione era al di là della ferrovia. E di là della ferrovia era considerato lontano, praticamente campagna.
A ben pensare quasi tutti i paesi di mare della Romagna sono tagliati dalla ferrovia: il centro storico sopra, gli alberghi e tutto quello che ruota attorno all’attività turistica sotto. Anche i più grandi, come Rimini, Riccione. A Cattolica invece tutto si trova al di qua della ferrovia, omogeneo, comodo e pratico. Addirittura a sud del Tavollo, il torrente che divide Cattolica da Gabicce, per cui l’Emilia Romagna dalle Marche, per cui l’Italia del nord da quella centrale, la ferrovia corre in moltissimi punti tra la spiaggia e la strada costiera.
Quando cambiammo casa, per andare a giocare al campo dei frati Maurizio e io usavamo proprio la strada ferrata, perché era la via più breve. Camminavamo nel sentiero che accompagnava le rotaie a un metro da dove sfrecciavano i treni e scendevamo dalla massicciata proprio al campo. Non c’erano una rete o un cartello che vietassero tutto questo. Comodissimo. Però un giorno qualcuno propose di spianare il terreno davanti casa nostra e così nacque un nuovo campetto, per noi ancora più comodo. Casa e bottega. Eravamo ragazzini di tutte le età, così oltre al calcio si giocava alla lippa, a numeri, a guerra con le cerbottane, caricate con bussolotti di carta appuntiti, a volte con gli spilli in cima. Tutto il giorno c’era da fare, armati di scarpe rotte e ginocchia tutte sbucciate.
Per san Giuseppe ammucchiavamo tanta di quella legna da fare invidia in altezza all’Himalaya. L’usanza di accendere dei fuochi la sera tra il 18 e il 19 marzo, san Giuseppe appunto, era osservata da tutti i rioni. Il nostro fuoco la sera del 20 marzo era ancora acceso. E mille e mille altre attività, altri giochi. La mamma all’imbrunire si sgolava per sollecitarci a rientrare in casa, ma finché non udivamo il leggero fischio del babbo, che intanto aveva sostituito la Fiat 1400 con una sfavillante Lancia Flavia, facevamo finta di niente. Proprio un bel periodo e un bel gruppo di amici. A volte rimediavamo i soldi per un ghiacciolo da dividerci e se nel bastoncino trovavi scritto PREMIO avevi diritto ad averne un altro che dividevamo di nuovo. Così come con la Pepsi Cola, che poteva avere disegnato un Jolly all’interno del tappo il quale ti dava lo stesso diritto della scritta PREMIO sul ghiacciolo.
Io ero goloso e mangiavo moltissimo di tutto. Tanto per vedere fino a che punto potevo arrivare, un giorno in casa mi misero davanti un bidone di gelato al gusto di cioccolato. Una seconda volta una cassa intera di mandarini. Se pensavano che mi sarei tirato indietro, avevano sbagliato i loro piani; mangiai ogni cosa e dormii pure come un angioletto.
Il Superga era stato fondato nel 1954 nell’oratorio della parrocchia di San Pio, chiesa detta “dei preti”. Nome in onore del Grande Torino e maglia con banda rossa per via del gemellaggio del Toro stesso con gli argentini del River Plate. La società faceva capo al parroco, il bonario don Angelo Romagnoli che chiudeva un occhio quando i ragazzi andavano al campo sportivo anziché a messa. In quell’anno aveva visto la luce, presso l’altra chiesa cittadina, detta invece “dei frati” e dedicata a sant’Antonio, una seconda società calcistica, la Folgore, e si preparavano dei bei derby. Il Superga disputava le sue partite interne a San Giovanni in Marignano e la Folgore a Cattolica presso il campo dei frati, quello in cui, anni dopo, si sarebbe disputato il torneo della Befana. Successe però che i ragazzi seguirono gli amici e non la geografia della città, e così capitava che alcuni che frequentavano una parrocchia giocassero nella squadra dell’altra e viceversa. I preti e i frati pensarono che non fosse una cosa giusta, quindi fusero le due società e nel 1957-58 risorse il Cattolica, che da qualche anno aveva cessato l’attività a causa della mancanza di un terreno di gioco. Come presidente fu scelto Giorgio Calbi, cui è ancora oggi intitolato lo stadio cittadino, perché era una persona appassionata e imparziale, visto che i figli, Aldo e Guido, giocavano uno nella Folgore e uno nel Superga e lui li seguiva entrambi con lo stesso amore. Giorgio fu un pioniere, era stato il primo a portare il calcio a Cattolica, a convincere altri ragazzi a giocare a pallone con lui.
Nel 1963 il Cattolica decise di arruolare giocatori di fuori città, ma tre vecchi dirigenti del Superga – Adelio Ercoles, idraulico, Marcello Morosini, commerciante di pesce e albergatore, e Lorenzo (Tiglio per tutti) Staccoli, pasticcere – non condivisero tale scelta e così decisero di ripresentare la vecchia società affidando la presidenza a Fabio Morsiani che era stato, come loro, uno dei fondatori del primo Superga. Per loro il calcio doveva essere una attività praticata dai paesani, finalizzata all’educazione, alla crescita e al divertimento. Il risultato del campo lo consideravano una cosa secondaria. Infatti nessuno al Superga ha mai preso un soldo, né istruttori, né giocatori, e ancora oggi questi principi sono rispettati. Certo il Cattolica ha disputato campionati in categorie più importanti e prestigiose, ma per i bambini come noi l’unica cosa che contava era giocare e le filosofie di vita le avremmo affrontate più avanti. Mio fratello Maurizio aveva scelto il Superga e io lo avevo seguito. Le prime partite le giocai con il cartellino “falso alla rovescia”; invece di rubare sull’età per giocare contro i più piccoli per vincere facilmente, io mi aggiungevo anni per giocare contro i più grandi perché prima di averne compiuti dieci non si poteva essere...