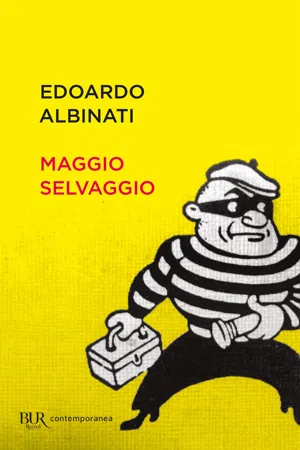Ferragosto e oltre
In una casa versiliese siccome piove leggo libri molto diversi tra cui: una biografia unauthorized di Mick Jagger, una francese di Malcolm Lowry, un catalogo illustrato dei più famosi coupé, tra cui mi pare di riconoscere l’Alfa Romeo rossa come ce l’aveva mio padre, le Pagine postume pubblicate in vita di Musil (ritrovo uno dei miei brani preferiti, quello del cane che ammazza il leprotto), e poi testi induisti, guide turistiche eccetera. Ma il più interessante resta il libro sul cattivissimo maestro Mick Jagger. Noto che dal volume sono state ritagliate via alcune pagine di fotografie, probabilmente con un taglierino da disegnatore o una lametta perché ne sporge solo una sottilissima striscia fuori dalla rilegatura: me ne accorgo per l’incongruenza della numerazione. Il libro su Lowry è zeppo di note scritte a matita da un precedente lettore, con una calligrafia bellissima e indecifrabile. Se si eccettua il viaggio in Estremo Oriente di Ultramarina, compiuto a diciassette anni come semplice mozzo, l’unico lavoro regolarmente retribuito che Lowry abbia mai svolto è scrivere canzoni per orchestra, charleston, fox-trot come: Three Little Dogs – Gone Mice (Tre cagnolini – tramutati in topi…?). Difficile avvicinarsi a Lowry senza prenderne lo stile, l’abbrivio delirante e autodistruttivo. Il suo biografo Tony Cartano ne è totalmente prigioniero. Mick Jagger è invece un vero artista del crimine alluso, promesso, esaltato e praticato in forme prevalentemente simboliche mentre i suoi fan soccombevano facendo sul serio con le droghe, il diavolo, l’omosessualità eccetera. Grande personaggio proprio per questo: Let it bleed. Ne ho avuti diversi, in galera, di studenti con miti trasgressivi. Il più simpatico e ruspante una volta scrisse in un tema che avevo dato in classe per disperazione, visto che nessuno voleva scrivere niente di nessun argomento (titolo: “Raccontate la storia di una vostra grande amicizia”), be’, scrisse questo: “Prima di morire Nando era il mio migliore amico: stavamo insieme dalla mattina alla sera, era fantastico, ci drogavamo tutto il tempo, commettevamo un sacco di reati”. Poi seguiva una commovente descrizione di come l’amico era morto di overdose – anzi di AIDS, a pensarci bene, perché si trattava di qualcosa all’inizio lento ma che poi precipitava, proprio come in tutte le storie di AIDS. Ecco, ricordo solo il ritmo di quella morte, scandita obliqua sulla pagina protocollo. E il voto che gli diedi: sette e mezzo.
Il mio preferito resta però un fascista romantico con miti cavallereschi martellati in testa da mediocri letture. Un bel ragazzo moro e alto, sorridente, rapinava le banche. Grande tifoso della Lazio, inoltre. Dice che si ribellava contro la società borghese. Una volta mi chiese di aiutarlo a tradurre dal francese un poema di Julius Evola, e va be’, ci mettiamo nella cella che fa da sala per i professori, ma era veramente troppo sconclusionato sicché dopo tre o quattro strofe gli dissi: «Fredo, se vuoi andiamo avanti, però non ne vale proprio la pena» e anche lui sembrava piuttosto deluso. «È stregoneria per allocchi» gli dicevo, «il fascista erudito che lascia a bocca aperta i camerati con quattro rune disegnate per aria!» Discutevamo nel corridoio tra le celle per ore intere, le spalle contro il muro, con toni accesi, talvolta urlando, io e questo ultimo figlio del Novecento, dal sorriso arguto e matto, lo prendevo tanto in giro ma so di non avergli insegnato niente né di avergli fatto cambiare idea di un millimetro. La sua non era un’idea. Il suo fascismo era una grossa pietra interiore, inscalfibile, quasi un fatto naturale. Era il fascismo a provocargli dolore, molto, e a dargli gioia, rara. Alla fine dei duelli verbali sentendosi arrivare addosso la sconfitta si irrigidiva e diventava cupissimo, la belva inarcava la schiena, lui si sforzava di controllarsi e ritrovata un po’ di calma giapponese mi perdonava così: «Tu non puoi capire, sei un intellettuale». Come aveva ragione!
Il crimine è una ragione di esistenza non meno forte di altre, anzi direi che può essere addirittura più forte e in alcuni casi invincibile. Nulla, in effetti, vi è comparabile, nothing compares… come dice la canzone. Vivere per distruggere, per morire e far morire ha una sua logica perfetta, dico perfetta solo perché non può essere raggiunta e turbata da nessun ragionamento o dialettica esteriore: non ci sono parole o punizioni o dimostrazioni o exempla che valgono a “criticare” il crimine. Tra le poche cose che credo di aver capito in galera c’è la seguente, che in alcuni individui (non tutti, e nemmeno la maggioranza: forse solo in una testa su dieci) la delinquenza sul serio è impermeabile a qualsiasi altra considerazione logica o morale, non solo, ma può addirittura convivere con valori e costumi apparentemente di segno opposto (la cortesia, il rispetto quasi ossessivo delle forme, persino la mitezza), tanto esso è autonomo e svincolato dal resto. Non può definirsi né un valore né un disvalore proprio perché sfugge all’esercizio critico, cioè alla comparazione con altri atteggiamenti possibili: altrimenti non si spiega come le persone di gran lunga più dolci e disponibili (vorrei dire: “buone” se non suonasse quasi offensivo, grottesco), insomma, dico, le più “brave persone” che io abbia conosciuto lì dentro sono proprio quelle macchiate di sangue. Nello spegnere la vita di un altro si concentra una energia brutale che poi si va a nascondere chissà dove, in un luogo che non viene più raggiunto da nessuna luce del discorso, eppure vive, è l’anima stessa, il soffio vitale di quell’individuo. Come nell’Inferno dantesco, i raggi non penetrano in quel regno. Per quanto ci si sforzi di elaborarlo o vi si sia costretti dal trattamento carcerario (la cosidetta “équipe”, gli psicologi, gli educatori, e mettiamoci pure i rari sfoghi provocati nelle conversazioni con i compagni), be’, poco o nulla si cava da quel buco, il dolore può spurgare solo altro dolore informe, e il cosidetto rimorso non è che una forma mutola della memoria, una lingua tagliata che si agita penosamente ma non riesce a dire veramente nulla. Il male è un puro fatto. Non vi è nulla di più perfetto, di più “finito” del male. Esso è la sostanza che non richiede né offre giustificazione. Simile, in un certo senso, al dono, che, dice il proverbio, non può e non deve essere sottoposto a valutazione. Certo esiste un margine di errore che la mente a posteriori può cogliere con chiarezza, dicendo “È là che ho sbagliato” oppure “Quel che ho fatto è ingiusto”, ma spesso l’evidenza di tale errore resta più debole dell’evidenza di averlo comunque compiuto: rimane il fatto, cioè, che esso oramai è storia e carne dell’individuo. La logica, la legge, la morale soccombono di fronte all’incarnazione, all’evento-avvento, puro e insensato come quello del Cristo. «È andata com’è andata» sento dire spesso in galera, e non si tratta di fatalismo quanto di un obiettivo riconoscimento delle forze in campo. Io reagisco con dosi altrettanto massicce di forze che non mi sogno però di definire positive (quando mai la poesia è positiva?).
Esiste poi un altro atteggiamento interessante ed è quello di un singolare moralismo che per non aver trovato il bene nel mondo si rivolge al male quasi obbedendo a un comandamento di sincerità. Il delinquente, in altre parole, rinuncia a essere buono perché al mondo nessuno è buono e dunque se fosse buono solo lui sarebbe stupido o ipocrita. Saul Bellow descrive bene questo nel suo ritratto di un vecchio truffatore di Chicago, Yellow Kid Weil:
… È in cerca di giustificazioni per i crimini commessi, certo, ma a parte questo è convinto che le persone oneste non esistano. Presenta se stesso come un Diogene, la cui continua ricerca dell’onestà assoluta si è conclusa con una delusione (I conti tornano).
La delusione apre la strada a ogni soluzione e specialmente a quelle che la morale di prima vietava.
Siccome i miei ideali sono falliti, allora via libera, tutto è lecito. Questo tipo di persone talvolta sono simpatiche talvolta insopportabili e viene voglia di dargli uno schiaffo. Una volta ho ascoltato uno spacciatore seriamente impegnato in una tirata contro la gioventù d’oggi che si droga e non ha valori – la famiglia, il lavoro eccetera. Non credevo alle mie orecchie e lo lasciavo parlare per vedere fin dove sarebbe arrivato. Sì, diceva proprio che quei ragazzi drogati e buttati là sulle panchine dei parchi pubblici, che vivevano di piccoli furti per procurarsi la roba, magari rubando in casa al padre e alla madre, «be’, me fanno schifo» diceva lo spacciatore, «giuro che nu’ li capisco. Pure ’ste regazze de famija che battono er marciapiedi pe’ fasse ’na dose…». No, sono io che non capisco te, protestai, sei tu che gli vendi l’eroina e ti lamenti perché te la comprano?
Lui mi guardò come se fossi matto o volessi fare il furbo. Aveva una canagliesca faccia da pugni, da film romanesco, da bullo antichissimo.
«Be’, che c’entra? Quello è lavoro. Si nun la comperavano da me la comperavano da quarcun artro.»
Bene, io credo che in questo sdoppiamento egli fosse, per quanto miope sino alla cecità, sincero. Alla logica verticale del rapporto causa-effetto i tipi come lui sostituiscono quella orizzontale del libero mercato della devianza (e della sopravvivenza).
Siamo tutti devianti, dunque non esiste norma, anzi ne esiste una sola ed è quella che ci si trova proprio sotto il naso e la si rispetta senza bisogno di ragionarci su: l’amore per i figli viene per primo, com’è ovvio, poi la mamma, la moglie, l’amicizia… la famiglia, appunto. Sembra che il supremo valore della famiglia per molti delinquenti sia esclusivo e slegato dal riconoscimento di un valore analogo per gli altri, a cominciare dalle vittime dei loro reati. Così vissuto quello famigliare è un valore intraducibile e conflittuale: chi più ama la propria famiglia più è pronto a mettere in pericolo quella altrui. Mancano del tutto i nessi, lo sfondo dell’azione, la trama complessiva che noi chiamiamo società, come nel discorso dello spacciatore, il quale infatti era affezionatissimo ai suoi “regazzini” e gli venivano i lucciconi a parlarne («devi vede’ che facce sveje… che birbanti… come me somijano…!»), quando questi avevano più o meno la stessa età di quelli avviati alla tossicodipendenza grazie alle sue forniture.
L’insieme delle azioni che formano la propria condotta si riduce così a una poltiglia, a un pulviscolo di comportamenti irrelati e ingiudicabili, con un’unica eccezione, un limpido e saldo criterio: la difesa a tutti costi di un territorio marcato con atti d’amore e violenza. Nella mentalità di parecchi detenuti ho letto una chiara equazione: amare significa odiare. Se amo una cosa debbo odiarne un’altra (similare e dunque nemica). La famiglia, la terra, il paese d’origine sono amori feroci che non ammettono deroghe né estensioni: a tutto il resto si riserva diffidenza oppure odio. Pensavo che i romani fossero, almeno in parte, esenti da questa fedeltà viscerale e armata, ma non è così. Il carcere naturalmente la acuisce facendola diventare leggendaria, per cui la semplice nominazione dei quartieri di Roma basta a suscitare tra i reclusi una mareggiata emotiva. Testaccio, Borgo, Monti, Cecchignola, Val Melaina, Villa Gordiani, il Mandrione, il Quadraro e il Quadraretto, la Magliana, le borgate di Torre Spaccata e Tor Tre Teste… persino il Santo della Cappadocia, nel cui nome si distendono le fumose file di palazzi appena fuori dalle mura di cinta del carcere, rintocca dolce e lontano: San Basilio, paese di favola confinante con Casal de’ Pazzi, con le vaste e inesplorate regioni di Talenti, Rebibbia, viale Kant, Casal Boccone…
In galera tale senso d’appartenenza si travasa spesso nel rapporto stretto coi compagni di detenzione: così si formano coppie, famiglie tradizionali e allargate, condomini, clan, squadre, tribù con capi e stregoni, servi e padroni, mogli e mariti e amanti ma soprattutto fratelli che si aiutano l’un l’altro. Fratellanza, insomma, è il nuovo patto. Se il cemento tra gli individui lo dà il vivere insieme e spartire lacrime, qui la sfera infinitamente più piccola e densa che nel mondo esterno (pochi metri quadri di cella) aumenta di cento volte il rapporto di compressione. L’aria pesa come piombo, e corpi estranei si fanno consanguinei per osmosi. Ho visto degli uomini cominciare a somigliarsi dopo uno o due anni passati insieme nel cubo, persino le loro ossa si piegavano alla convivenza. Ho visto abbracci più viscerali che tra padre e figlio, e la bestiale emozione quando uno se ne va, affondata nelle rughe degli altri che restano.
Un gigantesco orfanotrofio.
Non sciocca l’idea di Ilie Ceauşescu che arruolava gli orfanelli nella Securitate. Non sciocca, mostruosa, perché logica.
Mia madre mentre stende ad asciugare le lenzuola canta l’inno americano. Ma non sa le parole.
Continuo a sognare il carcere e i prigionieri. Ieri sera ero un po’ ubriaco e ho sognato che, davanti alla casa dove sono cresciuto a Roma, in via Tarvisio, una stradina breve del Quartiere Trieste, che si chiama così perché le vie e le piazze sono intitolate alle terre dell’irredentismo (piazza Istria, viale Gorizia, piazza Trento eccetera, fino a piazza Fiume), mentre entravo nel portone di casa mi chiama indietro un tipo alla guida di una decappottabile ferma in mezzo alla strada – mi chiama con un fischio. Lo raggiungo e senza far domande salgo in macchina dal lato del guidatore dato che lui intanto si è spostato sul sedile accanto. Accendo, e partiamo. Lui si stringe a me come se mi volesse baciare o almeno strofinare la sua guancia contro la mia, ma, purtroppo, proprio su questo lato del viso ha una macchia viola in rilievo che gli va dallo zigomo al mento rendendolo disgustoso. Malgrado ciò gli permetto di stringersi a me – e mi viene da vomitare.
Non è mai stato loquace, questo ragazzo, invece adesso parla in modo confidenziale, ironico, come se conoscesse molto bene me e le cose della vita in generale. Quando veniva a scuola in galera stava con gli occhi bassi in un angolo, senza nemmeno osare sedersi al banco, ma ora che è scappato sembra proprio un’altra persona: che bella macchina ha, lunga, aperta, americana. È passato a prendermi come si va a prendere una ragazza, solo che adesso sta facendo lui la ragazza, con la testa poggiata sulla mia spalla destra. Peccato quella lebbra rigonfia, che lo rende ripugnante. Probabilmente pensa che partirò con lui per qualche meta avventurosa, è sedotto e crede che io lo ricambi. «Dimmi cosa vuoi da me» gli chiedo mentre ancora si stringe vicino e mi soffia sul viso un alito corrotto dalla malattia. Forse sta per morire, penso. Forse sono le sue ultime ore. Continua a sorridermi in modo allusivo e a filosofeggiare sull’amore tra uomini e a un certo punto mi pare che parli anche di un attributo molto affascinante, le “mammelle maschili”, anzi...