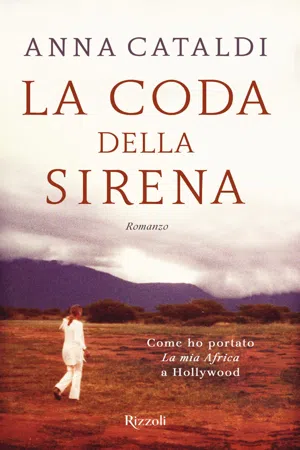New York, 2 dicembre 1977
Kennedy Airport ore 17. Il volo da Milano ha avuto due ore di ritardo e l’attesa ai controlli è stata soffocante. Per fortuna ai taxi non c’è coda, ancora un po’ e sarò a casa. Ecco il Plaza, la 59th Street e quell’angolo così familiare con la 7th Ave. L’uomo dell’ascensore mi segue con i bagagli e appena uscita in corridoio riconosco l’odore della vecchia moquette a disegni bianchi e marrone. Chissà perché negli Stati Uniti hanno la mania delle moquette marroni. Dappertutto, alberghi, atrii, uffici, ingressi ovunque marrone, ricettacolo di polvere e batteri che nessun Hoover condominiale riuscirà a neutralizzare. Giro la chiave nella toppa, entro ma non accendo la luce. La grande finestra nera è là in fondo in attesa del mio saluto, rituale di ogni arrivo. Fuori si stende la scura massa degli alberi nel buio traforato di luci. Ai lati la sfilata di grattacieli con le guglie protese verso lo sfondo del calore che sale dalla città. Non so quanto tempo sia passato ma sono sempre in piedi senza essermi tolta il cappotto. Il serpente di macchine scivola lucido tra i rami senza foglie, più in là Tower in the Green sfavilla di lampadine e a destra la pista del ghiaccio con i minuscoli, misteriosi pattinatori.
A un tratto le luci si sfocano, sbiadiscono e poi si spengono, santo cielo… un black-out? Tutto è diventato grigio come una zuppa di porridge. Apro e richiudo gli occhi, li sfrego e a poco a poco nel grigiore distinguo uno sfarfalleggiare di fiocchi sempre più nitidi, che invece di scendere dall’alto verso il basso, sembrano sparati in orizzontale. Esco sul balcone: una tempesta di neve! Così, senza preavviso. Dieci minuti fa tutto era limpido.
Rientro per afferrare il telefono: «Ma dove sei finita? Sono ore che ti chiamiamo. Sbrigati, siamo già al ristorante».
Uscire, con questa tempesta? E poi sono stanca.
«Vecchia mia scrollati» sempre Marina, «se non esci la prima sera c’est foutu. Non riacchiappi più l’orario giusto.»
Quando imbacuccata a dovere li raggiungo da Nicola’s è facile individuarli al tavolo più rumoroso. Sembrano entusiasti di vedermi.
«La voila enfin!» Ma dopo avermi dato una sedia nessuno si occupa più di me.
Meglio guardarsi attorno, al tavolo vicino c’è, dicono, quello scrittore che vive a Brooklyn.
«…Viene qui tutte le sere a pranzo… e quella è la nuova moglie, così più giovane. Bella, eh!»
Norman Mailer tutte le sere, anche con questo tempo? Più in là, verso il corridoio, e questa la riconosco da sola, la vedova più famosa d’America. Seduta eretta in grigio chiaro, orecchini in lacca nera ascolta il distinto signore di fronte a lei. Mi sento provinciale, nella sala nessun altro sembra emozionarsi per la vicinanza di tanta celebrità. Chissà, dopo qualche giorno a New York anche io non mi stupirò più di nulla. Nel frattempo ho sempre più sonno e con sollievo vedo il nostro gruppetto alzarsi e dirigersi all’uscita. Non è ancora fatta perché davanti al bar Nicola li ferma per chiacchierare. Un po’ di pazienza, il mio giaciglio è a solo pochi minuti di taxi. Ma in quel momento una mano possente mi cala sulla spalla.
«Sei proprio tu!»
Mi giro: lui è davanti a me, abbronzato e bello come un attore del cinema. Gli attori, quelli di una volta. Di lui so che si chiama Peter Beard, e poco altro. Fa il fotografo, bravo mi hanno detto. Ama la vita rude in Africa e anche quella meno primitiva ma altrettanto impegnativa della New York notturna. Dicono che abbia fatto dannare donne bellissime. Nomi famosi. L’ho conosciuto l’anno scorso accompagnando un amico nello studio di un avvocato che si occupava delle sue tasse. Peter era lì, usava l’ufficio come base temporanea. La notte dormiva sul divano. Nulla di strano, il suo nomadico modo di vivere.
Questa sera ha una giacca a vento blu, un’enorme sporta a tracolla e tre ragazze alte e bionde che lo guardano adoranti. Incomincia a parlarmi con entusiasmo, ma riesco ad afferrare ben poco. Pare mi chieda di rimanere. Sto borbottando scuse confuse quando uno dei miei accompagnatori si infila nel discorso affermando che ne sarei felice. Da quando non ho più un marito, gli amici cercano di trovarmi un nuovo compagno, non si sa bene con quali criteri. In questo caso è misterioso sapere perché Peter susciti il loro entusiasmo. Fatto sta che si dileguano complici. Claudia ritorna indietro per bisbigliare: «Ma sei matta a non voler restare? È divino. Lo chiedesse a me!». Eccomi dunque qui in questo frastuono appollaiata su uno sgabello accanto all’uomo divino che ciancia con le tre fanciulle lanciandomi di tanto in tanto un sorriso seguito da brevi veloci frasi a me totalmente oscure. Sorrido con le ultime energie rimaste.
L’occhio mi cade sui suoi piedi in rudimentali sandali di cuoio come quelli dei frati mendicanti (e non ha le calze… ma come farà con questa neve?) quando lui mi trascina a un tavolo e incomincia a estrarre dalla sporta una serie di cartoni neri con incollate sopra fotografie in color seppia.
Sono immagini impressionanti: scheletri di animali e carcasse in putrefazione. Su un cimitero di elefanti c’è l’ombra di un aereo in volo. L’aereo è piccolo come una croce, marchio su ogni fotografia e dappertutto scheletri e quelle ossa.
Un elefantino appena nato emerge dalla placenta materna. Non si capisce se è vivo o morto, ma quella che è certamente morta è la madre, sventrata.
Il piccolo elefante è lucido e scuro, come intagliato in giada nera.
Poi vedo una pianura sconfinata. Un raggio di sole illumina al centro un branco di animali, macchioline indefinite nella lontananza. Giraffe? Elefanti? Peter si è alzato di scatto per raggiungere Jaqueline, che scortata dal cavaliere stava scivolando verso l’uscita, e trascina pure lei al tavolo. I due si immergono in una conversazione mentre lei chinata sulle foto le osserva con attenzione. Non so cosa si dicono. Lei non parla, bisbiglia, sussurra. Poi se ne va, lui incontra un tizio e arrivano altre persone che scatenano l’entusiasmo delle ragazze. Ormai tagliata fuori dalla scena, alla frase «Tutti da Elaine’s!» colgo la palla al balzo per svignarmela.
Fuori non c’è più traccia di neve. È limpido e ventoso e in cielo si vedono le stelle. Il taxi scivola veloce verso casa.
Solo questa mattina ero nel grigiore del mio tran tran milanese e adesso qui, circondata da tutte queste luci! I bagagli li disferò domani, tanto lo so che mi sveglierò alle quattro.
Prima di addormentarmi ho un flash della prateria nella foto color seppia. Sento una fitta di nostalgia, quella che i brasiliani chiamano saudade, ossia il ricordo di qualcosa che improvvisamente ti manca in modo doloroso. E Peter, chissà se lo rivedrò!
Kenya, aveva detto? Ma io in Kenya non sono mai stata!
New York, 7 dicembre 1977
Quando arrivo all’ICP la coda è così lunga da girare quasi attorno all’isolato. ICP, come ho scoperto, significa International Center of Photography.
Ieri pomeriggio Peter ha telefonato. Strano, non ricordavo di avergli dato il numero. Forse. E comunque non mi era sembrato il tipo da annotarselo. Più il genere tanto prima o poi ci si incontra, che sia il bush africano o in Madison Avenue.
«Vieni domani sera» ha detto. «C’è la mia mostra. ICP, sulla 5th Avenue, il numero è millecentotrenta.»
Non ha specificato l’ora.
Ma poi è la volta di Florence: «Sì, certo, l’opening di Peter, alle sette, ma non hai letto sull’invito? Sarà divertente, ci andiamo tutti».
La parola tutti nel suo linguaggio non significa una folla ma un limitato numero di creature gravitanti fra Gstaad, St. Moritz, Parigi, Sardegna, Costa Azzurra, e attualmente in trasferta prenatalizia newyorkese. Comunque questa volta a giudicare dall’assembramento ha visto giusto.
La individuo avvolta in una pelliccia nera di lungo pelo di scimmia, sta chiacchierando con un giovane in vistosa cravatta a righe rosa e viola. Dev’essere inglese, solo loro possono andare in giro con questo freddo senza cappotto.
«Ma il mulino è bruciato completamente? Non è possibile! Quelle horreur.»
Bene, così ho imparato che windmill vuol dire mulino, anzi, mulino a vento. L’altra sera Peter continuava a parlare di questo windmill, ne sembrava ossessionato. Ora ricordo, anche ieri al telefono.
Per proteggermi dal freddo che fa lacrimare gli occhi tiro su fino al naso il collo del cappotto e osservo la folla che ribolle in quella che pare un’aspettativa mondana. I “tutti” a quanto pare si conoscono, si incrociano saluti fra quelli che stanno aspettando e gli altri che già escono.
«Eh, com’è?»
«Bellissima, ne vale la pena.»
«Macché, fa un caldo infernale, troppa gente, non ho visto nulla.»
«È fantastica.»
Forse sarebbe meglio tornare domani per vedere con più tranquillità, ma New York è fatta di attimi che si consumano accadendo. Non c’è posto per la tranquillità.
Rimango ad ascoltare Florence che con la precisione intransigente dei suoi racconti mondani mi ragguaglia sul famoso mulino: Peter l’aveva comprato e restaurato, era in alto sulla scogliera a Montauk…
«Cos’è Montauk?»
«Ma andiamo, Anna, dove vivi? Montauk, là negli Hamptons. Ci siamo andati tutti i weekend questa estate. C’erano Bianca, Andy, Paul, tutti!»
A quanto pare quello era il main camp di Peter, la sua base traboccante di ospiti fissi e di passaggio. Lì teneva ricordi dei viaggi, le macchine fotografiche, gli archivi dei negativi e i preziosi diari. Una notte due mesi prima il mulino aveva preso fuoco e malgrado i vicini fossero accorsi per spegnerlo quasi tutto andò distrutto. Peter, che era a New York, riuscì ad arrivare all’alba, in tempo per gettarsi nel fuoco a salvare qualche pagina dei diari.
E questa mostra è in parte per la presentazione del libro The End of the Game…
«Ah, ma allora è un libro? Non lo sapevo.»
«Come, non hai ricevuto l’invito? C’è scritto.»
… E in parte per far vedere quello che si è salvato dall’incendio.
Bene, adesso meglio informata, quando siamo catapultate dentro decido di tenere gli occhi ben aperti. Nella hall una folla si pigia davanti al guardaroba, meglio tenersi il cappotto sul braccio. Però è vero fa un caldo insopportabile.
A destra una sala illuminatissima, mi ci dirigo. I muri sono coperti da pannelli grigi con fotografie non abbastanza grandi per essere decifrate al di là della cortina di spettatori. Florence non ha fatto altro che salutare e adesso è scomparsa.
Riesco ad avvicinarmi alla fotografia di un foglio scritto fitto fitto, pieno di ritagli di giornali, disegni e collage. Ha un angolo bruciacchiato. Mi alzo in punta di piedi per leggere.
«Ah, sei arrivata! Finalmente.»
Lui si è materializzato, camicia di flanella scozzese, sciarpa rossa e un bicchiere in mano. Non riesco a vedere se per l’occasione si è messo un paio di scarpe o ha sempre i sandali. Incomincio a complimentarmi per il successo della mostra ma già altre persone hanno attratto la sua attenzione e dopo avermi fatto cenno con un dito di seguirli si dilegua circondato da un gruppo ondeggiante.
La stanza è affollata e li perdo di vista.
«Ma dove ti sei cacciata?»
La camicia scozzese è di nuovo di fronte a me accompagnata da un curioso individuo con baffi da mongolo.
«Venite, andiamo di sopra, ma non ti perdere di ...