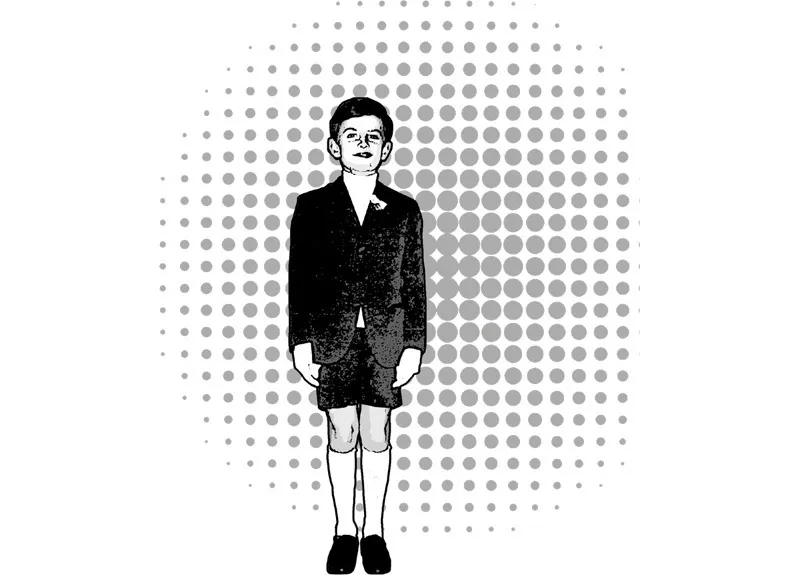Le prime convinzioni che mi sono fatto da piccolo a proposito dei giornali sono due.
Numero uno: sono molto utili.
Numero due: come nei menù dei ristoranti, il dolce sta in fondo.
Convinzione numero uno. I miei genitori gestivano un piccolo negozio di alimentari nel quartiere Ortica, periferia est di Milano. Mio padre imbottigliava il vino in cantina e poi lo consegnava a domicilio con il suo furgone rosso. Il vino, Barbera e Grignolino soprattutto, arrivava dalle vigne del Monferrato che lavoravano i miei zii. Mio padre lo travasava nelle botti di legno e poi da lì nelle bottiglie e nei bottiglioni che vendevamo in negozio o a domicilio.
In negozio ci stava mia madre, che teneva sotto al bancone della cassa fogli di vecchi giornali con cui avvolgeva le bottiglie di vetro per impedire che si spaccassero cozzando tra loro nelle borse delle clienti.
Trovavo pallottole di giornali vecchi anche in fondo alle mie prime, amatissime scarpe da calcio con i tacchetti di gomma. Servivano a tenerle in forma, a impedire cioè che la scarpa si schiacciasse troppo sulla punta mettendo a rischio la perfezione dei miei cross e dei miei tiri a effetto.
A proposito di calcio, un foglio di giornale diventava la palla ideale per le partitissime in salotto con mio fratello Ferruccio, detto Uccio, se avvolta ad arte con numerosi giri di scotch.
Giocavamo quando i miei non erano in casa, naturalmente.
Bisognava fare gol tra le gambe di una sedia e nella porta che introduceva al corridoio. Essendo bersagli di dimensioni molto diverse, cambiavamo campo e strategie dal primo al secondo tempo: catenaccio all’italiana quando dovevamo proteggere la sedia, più difficile da imbucare, assalti alla brasiliana quando dovevamo attaccare la porta del corridoio.
Sfruttandolo con intelligenza, il tavolo circolare al centro della stanza diventava a turno un buon compagno di difesa o un prezioso rifornitore di sponde in fase d’attacco. L’orologio del forno segnava il tempo.
La palla di giornali e di scotch naturalmente non rimbalzava, ma qualche tiro al volo ci scappava sempre, come sanno purtroppo le tante gocce del lampadario di cristallo andate in frantumi.
Un pomeriggio, con un sinistro alla Gigi Riva, mandai tragicamente in pezzi la porta finestra che dava sul terrazzo. Colti dal panico, piccoli, pessimi mentitori, ci inventammo un alibi più fragile del cristallo puntando sul fatto che abitassimo al pian terreno.
Giurammo ai nostri genitori che un sasso piovuto misteriosamente dal cortile aveva infranto la finestra con nostra sorpresa e comprensibile spavento.
A mia madre bastò un’occhiata al sasso che avevamo recuperato dal giardinetto della via e che stava lì sul pavimento, come un reo confesso, per chiederci: “Come mai, se il sasso è entrato dal cortile, i vetri sono tutti all’esterno e non all’interno?”.
Smascherati e condannati a ore di lavoro forzato in cantina: mettere i tappi di sughero alle bottiglie, incollare le etichette, lavare i secchielli di plastica e cose del genere.
ECCOMI A NOVE ANNI, IL GIORNO DELLA MIA PRIMA COMUNIONE. A QUEI TEMPI SOGNAVO IL CALCIO NON IL GIORNALISMO...
I muratori, che d’estate entravano in negozio per comprare birre ghiacciate, portavano in testa fogli di giornale modellati a forma di barchetta per ripararsi dal sole a picco mentre lavoravano sulle impalcature. Anch’io sapevo costruirmi cappelli del genere.
Ogni volta che andavamo a trovare i parenti a Lu Monferrato, la nonna Tommasina ci riempiva di uova fresche che incartava a due a due con le pagine della «Stampa» o «La Vita Casalese». Non è che le galline lasciassero uova dappertutto, avevano i loro luoghi preferiti: un angolo del pollaio, una nicchia impagliata tra i mattoni rossi del portico, un anfratto al primo piano del fienile… Andarle a recuperare con Uccio voleva dire giocare all’isola del tesoro.
Scusatemi se ora scendo di qualche gradino sulla scala dell’eleganza, ma è per chiarire definitivamente il concetto e chiudere il punto uno.
La fattoria della nonna Tommasina non prevedeva il bagno in casa, ma una turca in cortile, cioè un casottino di pietra con un buco sul pavimento. Lì dentro trovavo striscioline di giornale appese a un chiodo. Per renderle morbide, quasi come la carta igienica, bisognava strofinarle bene, come la nonna mi aveva insegnato a fare con le due metà di un fico prima di mangiarle.
Insomma, a sei, sette anni mi era già chiaro quanto fossero utili i giornali: per sapere cosa era successo nel mondo e a che ora davano Zorro in televisione, ma anche per proteggere le bottiglie e le uova, per ripararsi dal sole, per tenere vive le scarpe, per giocare a calcio e per un sacco di altre cose.
Direi che possiamo passare alla convinzione numero due: il dolce sta in fondo.
Da piccolo sfogliavo un giornale come sbucciavo una pesca, saltavo cioè le prime pagine inutili, la buccia, per arrivare al succo: lo sport. Mi interessava solo quello e il calcio in modo particolare. Anzi, non riuscivo a capire perché una cosa così bella e importante come il calcio fosse relegata là in fondo, nelle pagine finali.
Mia madre nella vetrina del negozio esponeva la merce più attraente per convincere la gente a entrare: i panettoni a Natale, i cioccolatini per la Festa della mamma, le bottiglie di whisky con le cravatte in omaggio per la Festa del papà… Mica metteva in mostra i barattoli di fagioli borlotti.
Perché allora i giornali non esponevano lo sport in primo piano?
Ero arrivato alla conclusione che per arrivare alle cose più piacevoli servisse sempre e comunque un periodo di attesa e un esercizio di pazienza: nove mesi di scuola prima delle vacanze, il telegiornale prima di Carosello, la messa prima della partita di calcio all’oratorio… I giornali non facevano eccezione. Parlo di quelli non sportivi, tipo «Il Corriere della Sera».
Il mio preferito era di gran lunga «La Gazzetta dello Sport» del lunedì, dopo una giornata di campionato. Al pomeriggio, sdraiato sul letto, la leggevo tutta, dalla prima all’ultima parola.
Partivo dalle notizie sull’Inter, la mia squadra del cuore, ma con la stessa passione mi avventuravo tra i tabellini della Serie C per controllare se quel vecchio centravanti sul viale del tramonto, che avevo ammirato tempo prima in Serie A, avesse fatto gol, o se l’Alessandria, i mitici grigi per cui tifava da giovane papà insieme al Grande Torino, avesse vinto.
Passavo ore incantevoli navigando nel mare rosa.
Papà comprava la Gazzetta solo al lunedì e «Il Corriere della Sera» alla domenica. Negli altri giorni della settimana divoravo la Rosea nella latteria del Giuseppe che stava in via Pitteri accanto a “Vini, olii e liquori” Garlando.
D’estate, che è stagione di piaceri e libertà, avevo il permesso di comprare la Gazzetta dopo le amichevoli dell’Inter. Nella mia personalissima classifica dei picchi di felicità, quelle camminate verso l’edicola di via Cima occupano ancora oggi un posto altissimo. Per lo meno nel ricordo.
Perché? Perché risalivo via Pitteri con il sorriso sulle labbra, senza la minima preoccupazione del risultato. Il giorno prima l’Inter aveva giocato contro la Rappresentativa della Val Brembana e di sicuro aveva vinto, di sicuro aveva segnato quattordici o quindici gol, di sicuro Roberto Boninsegna, che a dieci anni era il mio centravanti, il mio Sandokan, il mio Tex, il mio tutto, ne aveva buttati in rete almeno cinque o sei.
Provate a pensarci, oggi una camminata del genere verso l’edicola potrebbe capitarvi mai? No, perché un attimo dopo la fine dell’amichevole veniamo bombardati dai siti Internet e dalle informazioni sui social che spifferano risultato e marcatori, mentre i notiziari di Sky, che ruotano ventiquattr’ore su ventiquattro, mostrano subito i gol.
A me invece bastava saltare il notiziario sportivo Rai e andare a dormire presto per risvegliarmi nella beata incoscienza e potermi incamminare verso il giornalaio di via Cima con il sorriso sulle labbra: quanti ne avrà fatti Bonimba?
Aprivo la Gazzetta alla pagina dell’Inter con una frenesia natalizia ed eccola lì, la meravigliosa raffica di gol del mio eroe: Boninsegna al 5’, al 17’, al 31’ del primo tempo, al 9’, al 20’, al 33’, al 40’ del secondo tempo.
Sette gol in un colpo solo!
Sia chiaro, non sto dicendo che dovete invidiarmi. Sono io che invidio voi!
Quando ero bambino, la televisione trasmetteva solo un tempo di una partita di Serie A e, al massimo, una di Coppa al mercoledì. Avessi avuto a disposizione tutto il calcio che passa oggi in TV, sarei stato più felice di Pinocchio nel Paese dei balocchi…
Invece, non potendolo vedere, lo leggevo.
«La Gazzetta dello Sport» era il succo della pesca senza la buccia, era il dolce senza la minestrina, Carosello senza il telegiornale, le vacanze senza la scuola. Solo sport, tutto sport, senza pazienza e senza attesa.
Il mio mare rosa preferito.
Chi l’avrebbe detto che, a forza di navigarci sopra, un giorno ci sarei cascato dentro e che il mio nome si sarebbe trasformato in una firma in fondo a un articolo?
Ora vi racconto come è andata.
Ogni volta che incontro dei giovani lettori in una scuola o in una biblioteca, finisco per arrivare quasi sempre a questa considerazione: “Ragazzi, voi siete molto più bravi di me, perché alla vostra età io leggevo pochissimo, quasi nulla. Io sono un pessimo esempio. Dimenticate subito quello che vi ho appena detto e tirate dritti per la vostra strada, che è quella giusta: leggete, leggete, leggete!”.
Proprio così. Io, in età da scuola elementare e media, non leggevo nulla. Nella scarna libreria della mia cameretta ricordo un vecchissimo Pinocchio, regalo della mia madrina per un compleanno, una raccolta di fiabe con un tappeto volante in copertina, un romanzo di Sandokan e, soprattutto, un manuale di consigli sul calcio firmato da Sandro Mazzola, glorioso capitano dell’Inter.
Perché quello era il mio unico, grande sogno: diventare un giorno il numero 10 della mia Inter, un campione vero da Serie A e da Nazionale.
Molti miei colleghi giornalisti, che fin da piccoli avevano la passione per la lettura e per la scrittura, mi hanno raccontato dei giornalini che dirigevano e compilavano a scuola con l’aiuto delle maestre. Come si dice, avevano già “il sacro fuoco”, cioè l’entusiasmo e la vocazione per la loro futura professione.
Io no. Io il “sacro fuoco” ce l’avevo per il calcio. Coltivavo il mio sogno inseguendo un p...