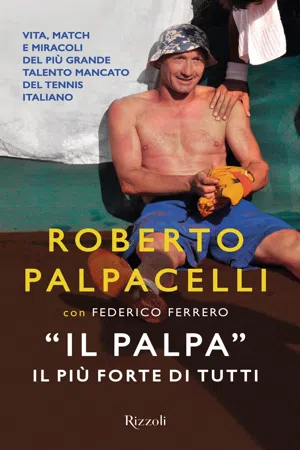Già negli anni Sessanta i calciatori avevano una cattiva nomea, e il padre non voleva che uscisse con lui. Così rimasero fidanzati per tre anni a distanza: per vederlo, doveva marinare la scuola. Il resto del rapporto viaggiava sulla corriera dei portalettere.
Oggi Franca Basti è una signora distinta, dai modi garbati, una donna del ceto medio di provincia che ha prosperato nel Dopoguerra. Custodisce in una cassettina tutta la corrispondenza amorosa con l’uomo che scelse come compagno, Giovanni Palpacelli, un ragazzo anconetano cresciuto a Pescara, di mestiere ala destra. Quando parla del marito, le si inumidiscono ancora gli occhi e racconta di un uomo buono, una persona a posto, cui voleva bene e con cui si è tenuta compagnia per una vita. In quelle lettere, lui raccontava il suo patimento d’amore: quanto gli pesasse starle lontano; quanto poco gli interessasse il pallone, da quando l’aveva conosciuta. Per lei avrebbe cercato un lavoro serio, perché lei sarebbe diventata la madre dei suoi figli e lui avrebbe smesso di vivere per la partita della domenica, pur di essere un buon padre di famiglia.
Quando smuove i ricordi, la signora Palpacelli lo fa con un lieve affanno: come volesse prevenire la domanda – quella domanda – che qualcuno certamente ha azzardato, rinfocolando una fitta alla bocca dello stomaco e la memoria di scene terribili. Perché il loro unico figlio maschio, Roberto, un ragazzo cresciuto nella buona borghesia di provincia, amato e coccolato, sportivo e brillante, ha deciso di entrare a gamba tesa sulla vita, trascinando nel suo vortice disperato tutte le persone che gli stavano accanto?
Giovanni non c’è più, dal dicembre del 2011. Quando era giovane, Cecio – come veniva chiamato dagli appassionati di calcio perché piccolo e compatto – era un atleta esplosivo, in fascia correva veloce e sgusciava via dalle difese avversarie. Al figlio ha donato, in un corpo dalle misure più moderne, le stesse qualità genetiche. Le cronache calcistiche dei tempi, sul Corriere Adriatico, lo raccontano come uno da serie maggiori, che avrebbe meritato una carriera più saporita.
Classe 1932, giocava nel Cosenza e il suo gol più famoso fu quello della vittoria contro i rivali di sempre della Reggina, il 26 aprile del 1959. Una partita che finì male, a botte e tafferugli, con gli scontri fuori dal Comunale di Reggio Calabria tra bande di embrionali ultras, una fitta sassaiola, le camionette della polizia che disperdevano i tifosi inferociti per quella rete decisiva. La stagione del Cosenza terminò peggio, con la promozione in serie B sfumata per pochi punti.
L’anno successivo la malasorte divenne beffa, quando il Foggia – che aveva inseguito la squadra di Palpacelli senior per tutto il campionato – piazzò il sorpasso nelle ultime giornate. Finalmente, nel 1961, l’agognato passaggio di categoria. Nel frattempo, però, Cecio – che più di tutti avrebbe meritato quel riconoscimento – dal Cosenza calcio se ne era andato, perché lui voleva solo Franca. Ma “andato” non rende l’idea: era letteralmente scappato dal ritiro.
Aveva conosciuto l’amore della sua vita qualche anno prima allo stabilimento Miramare di Pescara. Lei era ancora minorenne, una ragazzina di Città Sant’Angelo, figlia di un imprenditore che aveva costruito il proprio benessere con una fornace di laterizi. Cecio, a parte il calcio, poteva presentare a colui che avrebbe desiderato come suocero, e che di lui manco voleva sentir parlare, soltanto il pedigree di famiglia: un padre colonnello in aviazione, un’estrazione borghese, beni al sole.
Quando scappò dal ritiro, Cecio aveva ventott’anni e la sua carriera stava iniziando a sfiorire. L’Italia, invece, era in primavera economica: per trovare un lavoro vero, a tempo indeterminato e con busta paga il ventisette del mese, bastava alzare la mano e proporsi. Godendo della stima e dell’amicizia del signor De Cecco di Fara San Martino, quello della pasta, la vicenda fu ancora più facile: Giovanni lo informò delle sue intenzioni di smettere per “fare di Franca una donna onesta”, il magnate chiamò il suo istituto di credito – il Banco di Roma – e, nel giro di poche settimane, si era aperta una posizione per lui: cassiere nella filiale di Pescara.
Sistemato il curriculum, il signor Basti diede l’assenso per una cerimonia celere. A ottobre, il matrimonio. Dopo dieci mesi, la nascita di Paola. Altri due anni, ed ecco Tiziana. L’ingranaggio funzionava: Cecio guadagnava, si teneva attivo con il tennis che aveva scoperto dopo aver lasciato il pallone e che praticava al circolo di Pescara, inaugurato pochi anni prima a un tiro di schioppo dal mare. Franca, come si usava ai tempi, aveva rinunciato di buon grado alla carriera da insegnante e si occupava del resto, la casa, le figlie, con l’aiuto dei genitori che abitavano sul medesimo pianerottolo. Da maestra mancata, educava la prole, e ciascuno, in famiglia, aveva il suo posto.
Roberto non era previsto, almeno finché un’amica di Franca non ebbe il terzo figlio. Le due donne uscivano spesso insieme, e lei si portava sempre appresso la carrozzina, stuzzicando nei Palpacelli l’idea di un terzogenito. Anche perché, sebbene sottotraccia, Cecio lo desiderava con forza, il maschio; per potergli insegnare il calcio, magari il tennis e, chissà, costruire quella confidenza complice che tra uomini spesso scatta, anche se uno è costretto nel ruolo di padre e l’altro di figlio. Al quarto mese di gravidanza, però, sembrava tutto finito. Franca si buscò una broncopolmonite virale e la medicina dell’epoca non poteva contare sulla mira accurata di quella odierna. I dottori furono chiari: «O si cura la madre o si salva il feto». Cecio non ebbe dubbi, chiese di pensare alla moglie. Contro ogni prognosi, però, il bambino resistette alla buriana antibiotica e, in anticipo sui tempi, Roberto Palpacelli venne al mondo il 5 giugno del 1970. Il padre scoprì solo quel giorno che si trattava proprio di un maschio, e ne fu così felice che andò in giro per tutta la clinica gridando: «È nato Napoleone!».
Il secondo uomo di casa era tutto ciò che la famiglia potesse ancora desiderare dalla vita: ora c’era pure chi avrebbe portato il cognome di papà. A un anno, Roberto già correva dietro le sorelle sul terrazzo di casa, inseguendo le palline da tennis del padre. Mentre Paola e Tiziana ci giocavano, lui provava a calciarle col piede sinistro, o a colpirle con la mano per farle finire sul balcone dei vicini al piano di sotto.
Se non per una propensione piuttosto decisa a ficcarsi nei guai, a toccare tutto, a consumare il pavimento del corridoio fino all’esaurimento delle energie nonostante la corporatura minuta, il piccolo dava soddisfazione e arrivò presto il giorno in cui Cecio iniziò a portare Roberto con sé al circolo del tennis. Quando ci entrò per la prima volta, il bambino aveva tre anni, e proprio in quell’occasione ebbe il suo battesimo del sangue: Cecio si stava allenando per uno dei suoi tornei amatoriali e, aprendo di dritto con gli attrezzi di allora – quattro etti di racchetta di legno –, spaccò l’arcata sopraccigliare del figlio che gli scorrazzava intorno. Un’allegoria cruenta di ciò che sarebbe diventata la sua vita ai margini del campo: una rovina, costruita a mezzo metro dalla gloria.
A cinque anni, Roberto prese la prima lezione con il maestro del circolo di Pescara, Giancarlo Iezzi. Un signore che anche adesso, a settant’anni suonati, continua ad avviare i ragazzini allo sport. Gli esercizi standard di quel periodo, visti oggi, fanno sorridere: in fila per tre, apertura, passettini verso la palla, movimento, accompagnamento. Niente di troppo diverso dai filmati delle colonie estive dell’Istituto Luce. Il tutto, peraltro, veniva rigorosamente eseguito senza palla e impugnando un attrezzo da denuncia per tentate lesioni a minori, una greve Dunlop Maxply manico 5. Allora si faceva così.
I tempi delle bacchettate sulle dita ai mancini erano terminati, il braccio sinistro di Roberto non era più quello armato dal Diavolo e gli ci volle poco per distinguersi nelle esercitazioni collettive: imparava presto, eseguiva meglio di chiunque altro, era il più veloce e reattivo degli allievi. Iezzi e Sergio Mazzone, l’altro maestro in carica al club di Pescara, si accorsero subito che il figlio di Cecio aveva i cromosomi giusti, la stoffa dell’atleta. Sottopeso e bassotto, veniva chiamato Virgola, ma con la racchetta se la cavava meglio di quanto riuscisse a dare confidenza agli amici della scuola.
In lui convivevano spinte opposte. Se lasciato tranquillo, tendeva a stare in disparte, a non socializzare più del necessario. Si mostrava mansueto, non cercava la compagnia o il sostegno altrui e sembrava bastare a se stesso. Non appena veniva punzecchiato, però, si imbizzarriva, talora in maniera sproporzionata: viveva i contrasti con una rabbia e una foga preoccupanti, sembrava essere scosso violentemente da fatti minimi: un dispetto, uno scherzo cattivo, una parola colorita potevano scatenare reazioni incontrollate. Gli psicologi infantili, nei primi anni Settanta, non erano così facili da scovare; ma, nel caso di Roberto, forse avrebbero ravvisato un disturbo oppositivo provocatorio, o qualche altro inciampo che stava rendendo più deboli le ali della sua crescita.
Quando Virgola perdeva la calma, si trasfigurava in Punto Esclamativo. Con il passare degli anni, questo aspetto del carattere di Roberto divenne sempre più evidente, e la sua timidezza si scostava per dare sfogo a scatti impulsivi e ingiustificati. Come quella volta che, rincorrendo al circolo un amico che gli aveva fatto chissà cosa, pur di non arrendersi alla fuga di quello che era diventato il suo avversario venne quasi decapitato dal filo spinato teso intorno al prato, preso in pieno collo in accelerazione. Lo trovarono steso sul cemento, malridotto ma incredibilmente cosciente.
All’ingresso di Roberto alla scuola elementare, nel settembre del 1976, l’Italia del tennis era in estasi sportiva: Adriano Panatta aveva vinto gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros; prima delle feste di Natale la squadra di Coppa Davis, completata da Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, avrebbe conquistato la prima e unica Insalatiera della storia.
Nel mondo, il gioco stava cambiando pelle. Vinti dall’età, i miti australiani della racchetta si stavano pensionando uno dopo l’altro, e con loro il tennis come era stato conosciuto fino quel momento: un languido tango all’ora del tè. Rod Laver, Ken Rosewall, Lew Hoad e i loro “gesti bianchi”, come genialmente definiti dal poeta parigino Roger Allard, stavano per essere soppiantati da una generazione di giocatori che ne avrebbe sconvolto i canoni tecnici ed estetici. Il tennis stava evolvendo in un fenomeno mondiale, i campioni non erano solo giocatori ma stelle globali: le ragazzine si strappavano i capelli per Björn Borg e Guillermo Vilas, e proprio loro due contribuirono a rivedere i capisaldi della disciplina, cambiando le impugnature classiche e introducendo il topspin, un effetto rotatorio micidiale che consentiva di colpire forte, sbagliare poco e impedire agli atleti impostati con il metodo classico di scendere a rete.
Roberto era inconsapevole di questi rivolgimenti, ma vedeva in anticipo la palla: il segno distintivo del talento. E poi amava strapazzarla, sentire lo schiocco dell’accelerazione, creare traiettorie al di là dell’improbabile e, allenamento o partita che fosse, fare lui il punto, provocare il gioco e non subirlo. Senza rendersene conto, stava modernizzando da autodidatta il vecchio manuale del tennis. Quando bisognava variare il gioco o era necessario difendersi, usava una soluzione di ripiego che non esisteva in alcun trattato di teoria, la “biscia”. Era una rasoiata di dritto, giocata da fondocampo, che lì per lì sembrava essere una palla corta, invece partiva secca dall’incordatura con il taglio dall’alto verso il basso e moriva dopo il rimbalzo, facendo impazzire gli avversari. Non gliel’aveva insegnata nessuno. Non c’è giocatore di tennis che non sappia quanto sia difficile tirare un vincente affettando la palla, in qualunque posizione del campo: figurarsi dal fondo. Un colpo talmente difficile che non era mai stato eseguito, se non dalle signore che giocavano negli anni Quaranta a velocità da lumaca.
Il maestro Iezzi non ha mai scordato l’estro di Palpacelli, il dono di dare del tu alla palla. Come tanti ragazzini, pretendeva tutto e subito: solo che, nel suo caso, lo otteneva grazie a una coordinazione unica. Iezzi lo lasciava fare, ci teneva a non imbrigliarlo: se in partita iniziava a comportarsi in modo troppo folle, come fissarsi sulle palle corte giocate a oltranza per il semplice gusto di giocarle sempre più corte, ogni tanto interveniva per richiamarlo all’ordine. Ma erano più le volte in cui lo lasciava a briglia sciolta. In definitiva, pur percorrendo una strada da bastian contrario che sfidava le leggi della fisica, a Roberto riusciva qualunque cosa. Soprattutto, quasi sempre vinceva.
Ma non esisteva soltanto il tennis. Era come se Roberto, già negli anni delle elementari, avesse bisogno di sperimentare, di inseguire le novità, e la sua energia non riuscisse a essere incanalata in un’unica direzione. E fu naturale per lui rivolgersi al calcio, per motivi “famigliari”, ovviamente, ma anche di contiguità geografica: a dividere il circolo dall’antistadio Adriano Flacco, il campo usato per gli allenamenti e le partite delle giovanili del Pescara, c’era una rete di fil di ferro. Opportunamente sabotata, Virgola acchiappava un pallone e sgattaiolava sul prato, per tirare calci di punizione a portieri immaginari.
Un giorno, il custode lo prese per un orecchio e, colpito dalla violenza del suo sinistro, invece di rispedirlo a lezione di tennis gli fece fare un provino. Passato subito. Cetteo Di Mascio, oggi tecnico della primavera dell’Ascoli, già scopritore del campione del mondo Fabio Grosso, su Palpacelli junior si era lasciato andare, senza riserve: aveva detto che se quel fuscello non fosse arrivato in serie A, voleva dire che lui di calcio non ci capiva niente. Provò inutilmente a legargli il piede sinistro per farlo calciare col destro, ma niente: Virgola si fece pulcini, esordienti e giovanissimi del Renato Curi tirando con un piede solo, e tanto bastava per un posto da titolare fisso.
Contro il cliché del padre calciatore col sacro fuoco del prolungamento virtuale della carriera, Cecio non spingeva perché Virgola si desse al pallone abbandonando la racchetta. Anzi, era più contento se giocava a tennis; il circolo di Pescara, a parte i buchi e i fili spinati, era un recinto sicuro in cui far sfogare il figlioletto. Cecio si fidava di Iezzi, e il maestro, dal canto suo, aveva il polso per controllarlo.
A indirizzare la vita di Roberto lontano dal controllore, dal pallone e dalla strada di un ragazzino come gli altri ci pensò, tutto d’un colpo, la banca: lettera di trasferimento per il padre. Per fare carriera in azienda, aumentare le entrate e far vivere con agio cinque persone mantenute da un reddito solo, Cecio doveva andare a rinforzare il personale nella sede del capoluogo, L’Aquila. La scelta era tra il sì e il sì.
Al circolo del tennis di Pescara rimase un’aiuola idealmente intitolata a Roberto Palpacelli. Non per le sue imprese sportive, purtroppo: la sera di Capodanno dei suoi dodici anni, poco prima del mesto trasloco nell’entroterra, pensò bene di lanciare un petardo scegliendo come bersaglio una palma, ben secca. Se il club non venne raso al suolo dal fuoco, fu il caso a deciderlo.
Quella non rimase l’unica impresa degli anni pescaresi. Con Massimo, il suo migliore amico e uno dei pochi con cui il rapporto si era cucito con naturalezza, il divertimento più grande non era tanto giocare con il biliardino professionale montato sul balcone dell’attico al sesto piano, quanto prendere le biglie di legno e buttarle di sotto, ammaccando le automobili nel viale. In un giorno di particolare vena, erano riusciti a portare in casa un carrello della spesa e a scaraventarlo in strada. Per miracolo, nessuno si era fatto male. A scuola, dove Virgola aveva finito la prima media, il preside non fu in grado di trattenere la gioia quando la famiglia lo informò del cambio di residenza. Promise di promuoverlo, a patto che i genitori giurassero di non farglielo mai più vedere.
Da Pescara a L’Aquila ci sono cento chilometri, oppure un mondo. Un’ora di automobile da percorrere con la Renault 5, la stessa che Cecio utilizzava col bagagliaio aperto, in cortile, per insegnare a tirare le punizioni a Virgola con l’effetto “a curva”. Centro chilometri verso l’entroterra, tenendosi il mare alle spalle. I Palpacelli erano nati con vista sulla riviera: dalla mitezza adriatica alla conca appenninica aquilana, il passaggio fu traumatico. In quell’inverno dei primi anni Ottanta, in cui Cecio aveva ricevuto la comunicazione di immediato trasferimento, la stazione meteo registrò un meno venti. Cambio di aria e di scenario: un innesto insidioso se capita a dodici anni, quando hai già messo le prime radici. Per Roberto, lo strappo fu doloroso. Dovette lasciare Massimo. E lui non era solo il suo migliore amico: le loro erano due famiglie in una. Il padre di Massimo gli aveva fatto da padrino al battesimo; i suoi tre figli avevano la stessa età di Paola, Tiziana e Roberto; il tempo libero lo passavano sempre insieme.
Roberto venne iscritto alla seconda media e mandato al Ct L’Aquila, la cui scuola tennis era affidata ad Antonio Bon, per tutti Totò. Figlio di Marino, un ex calciatore di serie B, Totò Bon era noto, dalle sue parti, per essere stato un talento precoce. Nel 1963, aveva battuto Adriano Panatta in semifinale e Roberto Lombardi nella finale della Coppa Lambertenghi, il campionato nazionale di tennis under 12. Nel torneo Avvenire, il campionato nazionale under 16, aveva battuto un’altra volta Panatta e si era guadagnato un posto nella nazionale juniores con lo stesso Adriano e un altro ragazzo che avrebbe fatto la storia del tennis italiano, Paolo Bertolucci. Da coach, Totò Bon era uno che ci vedeva lungo. Allenava un ragazzo promettente, Pietro Angelini, che avrebbe raggiunto il 253˚ posto della classifica mondiale. Più avanti avrebbe seguito Katia Piccolini, tre volte campionessa italiana e numero 37 nel ranking Wta. Roberto diventò immediatamente il suo secondo osservato speciale.
Anche per Bon, l’anamnesi era quella di un fenomeno in potenza, un talento naturale con una gran battuta e un gran dritto. Un giocatore fantasioso, eccentrico, cui non interessava palleggiare tanto per tenere la palla in campo ma giocare il punto a tutto gas e, se possibile, vincerlo con un colpo speciale. Eppure, a dispetto della vulgata dello scavezzacollo ingovernabile che già allora stava iniziando a diffondersi, il Palpacelli tennista non corrispondeva allo stereotipo della testa calda. Il maestro lo trovava educato, gentile. Salutava tutti, conosceva le buone maniere. Il padre assisteva spesso agli allenamenti ma con discrezione, ci teneva che facesse bene senza assillarlo. Semmai, gli agi e qualche vizio concesso in gioventù, i giochi, le uscite, la libertà, potevano aver contribuito a levargli un po’ di motivazione, di “fame”, di voglia di emergere ai massimi livelli. Virgola stava crescendo, si irrobustiva di muscoli e nervi, e sarebbe rimasto troppo poco, in città, per mostrare i primi segni del crollo. Tre anni e mezzo: il tempo di strappare il diplomino di terza media e di finire, ...