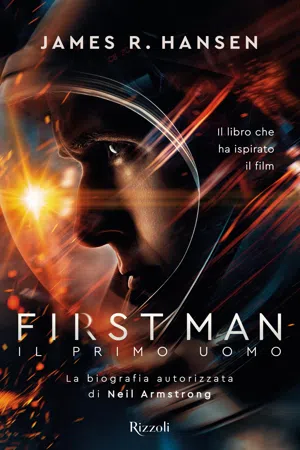Per Armstrong, Collins e Aldrin, il viaggio nello spazio iniziò negli alloggi dell’equipaggio tre ore e mezzo prima del decollo, poco dopo le 06:00 del mattino del 16 luglio 1969, quando i tecnici collegarono i caschi degli astronauti alla tuta fissandoli sugli anelli all’altezza del collo e facendoli scattare in posizione. Da quel momento in poi, i tre uomini del primo sbarco sulla Luna smisero di respirare l’aria esterna. L’unica voce umana che potevano sentire era quella che penetrava elettronicamente attraverso la barriera protettiva delle tute pressurizzate e vedevano il mondo filtrato dalla visiera del casco. Dentro quel bozzolo protettivo, potevano odorare, percepire, toccare e gustare solo quello che la tecnologia moderna aveva creato per loro.
A differenza degli altri, Armstrong aveva già familiarità con l’isolamento, poiché da pilota collaudatore a Edwards si era abituato alla costrizione delle tute di volo pressurizzate. Rispetto alla tuta a pressione parziale e al casco indossati per salire a candela sull’F-104 o per raggiungere il limite dello spazio a bordo dell’X-15, la tuta dell’Apollo risultava più ampia e facile da manovrare.
Quando alle 06:27 gli astronauti di Apollo 11 lasciarono l’edificio operativo del Manned Spacecraft Center indossando le galosce gialle protettive per raggiungere il pulmino climatizzato che li avrebbe condotti alla rampa di lancio 39A, a dodici chilometri di distanza, ogni atomo del loro corpo si accorse di avere abbandonato la consueta dimensione naturale e di essere entrato nell’ambiente totalmente artificiale in cui sarebbe sopravvissuto nello spazio cosmico.
Partendo per la missione, Neil, Mike e Buzz riponevano enorme fiducia nel razzo Saturn, ma le prestazioni di un razzo non erano mai affidabili al cento per cento. «Era di certo una macchina potentissima» affermò Armstrong. «Ma non era perfetta.» Il Saturn V era nato in fretta. La velocità fenomenale con cui era stato realizzato era il risultato di una strategia chiamata “all-up testing”, una nuova filosofia di ricerca e sviluppo adottata dalla NASA di cui si era fatto promotore il dottor George Mueller, amministratore delegato per i voli spaziali con equipaggio umano. Per lo sviluppo del Saturn V, Mueller aveva ingranato la quarta, richiedendo che il razzo fosse testato sin dall’inizio con tutti e tre gli stadi “attivi” e pronti contemporaneamente, evitando quindi di collaudare i singoli stadi uno per volta per poi assemblarli solo dopo averli provati singolarmente.
Non sarebbe stato altrimenti possibile rispettare la scadenza fissata da Kennedy. Ma quella non era la strategia ottimale per garantire la costruzione di un razzo impeccabile, soprattutto considerato che si trattava di un congegno nuovo tanto vasto e complesso, capace di una spinta propulsiva eccezionale di circa 3,5 milioni di chili.
Quando l’equipaggio si installò nella navicella, sopra a quel razzo dalla potenza eccezionale in attesa dell’accensione, eventuali riflessioni sui pericoli del Saturn erano ormai inutili. Inoltre non si poteva escludere la possibilità che all’ultimo momento qualcosa andasse storto in un componente minore delle diverse centinaia di sottosistemi associati al razzo, alla navicella o al complesso di lancio, e che il volo venisse di conseguenza annullato.
Il primo astronauta a entrare nella Columbia il mattino del lancio non fu Armstrong, né Collins, né Aldrin, ma Fred Haise, la riserva di Aldrin nel ruolo di pilota del modulo lunare. “Fredo” precedette di circa 90 minuti l’equipaggio nella navicella per completare i 417 controlli che servivano a verificare l’impostazione corretta di ciascun interruttore. Alle 06:54, Haise e il resto della squadra addetta ai controlli finali pre-lancio diedero l’ok. Salito con l’ascensore sino al piano della navicella in attesa, a 97 metri di altezza, Armstrong si aggrappò al corrimano sovrastante la capsula e si lasciò scivolare attraverso il portellone. Prima di entrare, Neil aveva ricevuto un dono da Guenter Wendt, il responsabile della rampa: era una mezzaluna che Wendt aveva intagliato nel polistirolo e avvolto in un foglio di alluminio. Wendt la chiamò “la chiave della Luna” e Neil sorridente gli rispose di conservarla fino al suo ritorno. In cambio, Neil diede a Wendt un cartoncino che aveva infilato sotto il polsino dell’orologio. Era il buono per una corsa su un “taxi spaziale” su cui c’era scritto «valida tra due pianeti qualsiasi».
All’interno del modulo di comando, Armstrong si sedette nel posto del comandante, quello di sinistra. Nel giro di cinque minuti, dopo che un tecnico ebbe terminato di collegare i tubicini e i cavi di Neil, Collins, il pilota del modulo di comando, si sistemò nel sedile di destra, seguito da Aldrin, il pilota del modulo lunare, che si mise al centro. (Aldrin stava al centro perché si era già allenato su quella postazione per Apollo 8. Collins era rimasto fuori dai giochi per un po’ per via dell’intervento chirurgico che aveva subito, perciò piuttosto che sottoporre Buzz a un nuovo addestramento per l’ascesa, la NASA decise di lasciarlo in mezzo e di preparare piuttosto Mike per la postazione di destra).
Alla sinistra di Neil c’era la manopola di annullamento: ruotandola si sarebbe attivato il razzo a propellente solido della torre di salvataggio annessa alla sommità del modulo di comando, che avrebbe portato Apollo 11 lontano dai guai. Nel programma Gemini, la navicella era invece dotata di sedili eiettabili, ma il razzo Titan, propulsore di Gemini, usava propellenti ipergolici che non esplodevano come il Saturn, alimentato invece con una miscela di cherosene, idrogeno e ossigeno. I sedili eiettabili non avrebbero lanciato gli astronauti sufficientemente lontano dall’esplosione del Saturn. L’ascesa del Saturn V era perfettamente funzionale all’esperienza di Neil con i voli sperimentali, poiché il razzo propulsore si poteva controllare dalla cabina di pilotaggio: «I modelli precedenti del Saturn non si potevano controllare dalla navicella. Se ci fossero stati problemi al sistema inerziale del Saturn su Apollo 9, per esempio, McDivitt, Scott e Schweickart avrebbero dovuto procedere con l’ammaraggio nell’Atlantico o un atterraggio in Africa, rischiando di rimanere gravemente feriti o peggio. Nel nostro volo invece era stato integrato un sistema alternativo di orientamento nel meccanismo del modulo di comando, così in caso di problemi con il Saturn, potevamo passare al sistema secondario e controllare il razzo dalla navicella». Se si fosse disattivato il pilota automatico, il pilota poteva mandare il propulsore in orbita manualmente.
L’ascesa in orbita di Apollo 11 prevedeva una serie di fasi distinte, ciascuna con specifiche variazioni nella procedura di annullamento. Come ha spiegato Armstrong: «Occorreva concentrarsi completamente sul superamento delle singole fasi ed essere pronti a fare la cosa giusta in caso di errori nella fase successiva». Le informazioni più importanti durante quell’impetuosa salita venivano «da una combinazione di azioni simultanee che comprendevano il controllo dell’indicatore di assetto, la verifica delle prestazioni di volo sul computer e l’ascolto delle indicazioni via radio su quale fosse la fase in corso o quella in cui si stava entrando».
Nel tempo necessario a smaltire una piccola parte dell’ingorgo stradale nei dintorni di Cape Kennedy, Apollo 11 aveva già completato un giro e mezzo del mondo e puntava dritto verso la Luna. Nel giardinetto della loro casa in Ohio, i genitori di Neil erano stati intervistati da uno stuolo di giornalisti: «Mr Armstrong, cosa ne pensa del lancio?». E ancora: «Mrs Armstrong, cos’ha provato quando ha visto il razzo sparire nel cielo?». Viola esclamò: «Non ho parole per la gratitudine che provo». Proiettando, come sempre, i propri sentimenti religiosi sul figlio aggiunse: «Neil crede che Dio sia lassù assieme a quei tre ragazzi. Ci credo io e ci crede lui». Steve commentò: «È un momento di grandissima felicità. Staremo incollati alla TV per tutta la durata del volo». La madre di Viola, Caroline Korspeter, di ottantadue anni, disse davanti alle telecamere: «Secondo me è pericoloso. Ho raccomandato a Neil di dare prima una bella occhiata in giro e di non uscire se non è sicuro. Ha detto che obbedirà».
Nella laguna del Banana River, Janet Armstrong e i ragazzi restarono sullo yacht ad ascoltare le trasmissioni dalla navicella attraverso un ricetrasmettitore della NASA finché le folle non si dispersero. Per quanto fossero tutti molto sollevati per il successo del lancio, su richiesta di Janet a bordo non venne aperta nessuna bottiglia di champagne, con l’idea di tenere i festeggiamenti per quando gli uomini sarebbero tornati a casa sani e salvi. Prima di rientrare, Janet si era concessa per un breve incontro con i giornalisti. «All’inizio non riuscivamo a vedere il razzo» disse Rick timidamente «e io ero abbastanza preoccupato. Poi di colpo l’abbiamo visto, è stato meraviglioso.» Janet raccontò alla stampa: «Una scena fantastica, sono estasiata», ma forse era solo sollevata perché tutto era andato liscio, in realtà stava pensando: «Passerà anche questa». La notte precedente non aveva chiuso occhio e una volta arrivata a Houston, nel tardo pomeriggio, aveva trovato i giornalisti in giardino. «Non mi sento un personaggio famoso» aveva detto loro frettolosamente, spingendo i ragazzi dentro casa. La veglia per l’equipaggio era appena cominciata. Ci sarebbero voluti due giorni e mezzo prima che gli astronauti raggiungessero l’orbita lunare, un altro ancora prima che Neil e Buzz sbarcassero, e altri quattro prima che facessero ritorno sulla Terra.
Ancora molte cose potevano andare storte.
Alle 10:58 ora di Houston, due ore e ventisei minuti dopo il decollo, Mission Control diede ad Apollo 11 il “via” per la TLI o “iniezione translunare”, ossia per lasciare l’orbita della Terra e dirigersi nello spazio profondo. Gli astronauti accesero il motore del terzo stadio del Saturn V, l’unico che restava ancora collegato al modulo di comando e servizio. Questa “fiammata”, della durata di ben cinque minuti e mezzo, portò Apollo 11 a una velocità di oltre 24.200 miglia orarie, che gli avrebbe permesso di sottrarsi alla gravità terrestre.
Sebbene Armstrong avesse in seguito dichiarato che il viaggio fu “meraviglioso”, in privato confessò che avrebbe preferito un approccio più delicato: «Nel primo stadio, il rumore del Saturn V era terribile, soprattutto alle basse altitudini; era il rumore della spinta propulsiva da 3500 tonnellate, amplificato dal suono di rimbalzo proveniente dalla crosta terrestre. Durò circa trenta secondi, poi ci allontanammo dall’eco e il volume si abbassò di colpo, ma in quel primo mezzo minuto fu davvero difficile sentire la radio. Sempre nel primo stadio anche il volo fu molto più duro rispetto al Titan. La vibrazione sembrava simultanea su tutti e tre gli assi». Quando il primo stadio finì di bruciare, il volo divenne più fluido e silenzioso, tanto che gli astronauti smisero di percepire le vibrazioni e addirittura di sentire i motori. L’ascesa sul secondo e terzo stadio del Saturn si dimostrò nettamente superiore rispetto a tutti gli stadi del Titan. Mike Collins più tardi descrisse così lo spasmodico primo tratto dell’ascesa di Saturn V: «Era come un neopatentato agitato alla guida di un’auto larga in un vicolo stretto che sterza nervosamente a destra e a manca». Poi, negli stadi successivi, il Saturn V si era trasformato in un “gigante gentile” e l’uscita dall’atmosfera era filata «liscia come l’olio, calma e serena quanto può esserlo un viaggio su un razzo».
Per i primi tre minuti, gli astronauti non potevano vedere niente dai finestrini, finché la navicella non raggiunse circa sessanta miglia di altitudine e, a quel punto, si liberò del razzo di fuga inutilizzato e dello schermo protettivo che fino ...