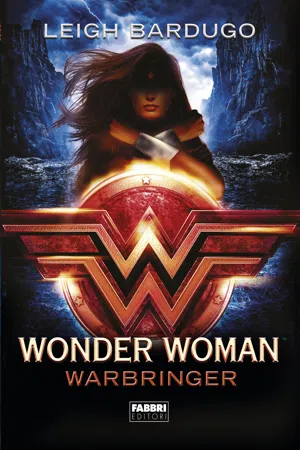![]()
1
Diana
Non si partecipa a una corsa per perdere.
Sulla linea di partenza Diana si molleggiava sulle punte dei piedi, i polpacci tesi come corde di arco, le parole della madre le risuonavano nelle orecchie. Una folla strepitante si era radunata per assistere agli incontri di lotta e alle gare di lancio del giavellotto che decretavano l’inizio delle Nemesie, i giochi dedicati a Nemesi, ma l’evento che tutte aspettavano era la corsa. La notizia che la figlia della regina avrebbe partecipato alla competizione si propagò sugli spalti come un’onda.
Quando Ippolita aveva scorto Diana tra le atlete nell’arena, non aveva mostrato sorpresa. Come da tradizione, la regina era scesa dalla tribuna per augurare alle concorrenti buona fortuna con una battuta o una parola d’incoraggiamento. Aveva rivolto a Diana un semplice cenno del capo per non far pensare a favoritismi, ma a voce bassa, senza farsi sentire dalle altre, le aveva sussurrato: «Non si partecipa a una corsa per perdere».
Le amazzoni assiepate ai lati della pista che conduceva fuori dell’arena battevano i piedi impazienti e intonavano cori per affrettare l’inizio della gara.
A destra, Rani scoccò a Diana un sorriso raggiante. «Buona fortuna» le disse, gentile e cortese come sempre. E come sempre certa della vittoria.
A sinistra, Thyra sogghignò e scosse la testa. «Ne avrà proprio bisogno.»
Diana la ignorò. Erano settimane che aspettava con ansia quella sfida: una corsa attraverso l’isola per recuperare una delle bandierine rosse appese sotto la grande cupola di Bana-Mighdall. In una semplice gara di velocità non avrebbe avuto alcuna possibilità; non aveva ancora raggiunto il culmine della potenza da amazzone. Col tempo ci arriverai, le aveva promesso la madre. D’altro canto, la madre le prometteva sempre un sacco di cose.
Questa corsa, però, era diversa: richiedeva una strategia, e Diana era pronta. Si era allenata in segreto con Maeve e aveva studiato un percorso che, per quanto più accidentato, portava dritto all’estremità occidentale dell’isola. Diana aveva persino... non proprio spiato, piuttosto raccolto informazioni sulle altre amazzoni in gara. Era ancora la più minuta e, ovviamente, la più giovane, ma nell’ultimo anno era cresciuta parecchio e ormai era alta quasi quanto Thyra.
Non mi serve la fortuna, si disse. Io ho un piano. Voltò la testa da una parte e dall’altra, lanciando un’occhiata alle amazzoni schierate sulla linea di partenza come guerriere pronte alla battaglia, e si corresse: Be’, un po’ di fortuna non guasterebbe. Il suo obiettivo era la ghirlanda di alloro, che al contrario di qualsiasi tiara o corona reale ci si doveva guadagnare, e non si poteva ricevere per diritto di nascita.
Poi gettò lo sguardo verso la folla. Scorse la chioma fiammeggiante che incorniciava il volto lentigginoso di Maeve e sogghignò, ostentando sicurezza. Maeve ricambiò il sorriso e rivolse i palmi verso il basso, formulando con le labbra una raccomandazione: Calma.
Diana alzò gli occhi al cielo, poi si concentrò sulla respirazione. Aveva la cattiva abitudine di scattare subito alla partenza, bruciando troppo presto le energie.
Visualizzò mentalmente il percorso, mentre Tekmessa, i folti riccioli adornati di gemme e le braccia abbronzate scintillanti di monili d’argento, passava in rassegna le atlete. Era la consigliera più fidata di Ippolita, seconda soltanto alla regina, e, con la tunica color indaco stretta in vita e il suo incedere fiero, sembrava pronta per la battaglia.
«Rilassati, Pisside» le mormorò Tekmessa passandole davanti. «Non vogliamo certo vederti andare in pezzi.» Diana sentì Thyra sogghignare di nuovo, ma non batté ciglio nel sentirsi chiamare con quel soprannome. Non riderai più quando salirò sul podio della vincitrice, pensò.
Tekmessa alzò le mani per intimare il silenzio e s’inchinò in direzione di Ippolita, seduta tra altri due membri del Consiglio delle Amazzoni nella tribuna reale: un palco rialzato, ombreggiato da drappi di seta nei vibranti colori della regina, rosso e azzurro. Diana sapeva che la madre l’avrebbe voluta accanto a sé, a guardare l’inizio della competizione, invece che in gara. Ma ciò non avrebbe avuto importanza se avesse vinto.
Ippolita rispose con un impercettibile cenno del mento, elegante nella sua corta tunica bianca e i pantaloni da cavallerizza, un semplice cerchietto d’argento posato sulla fronte. Aveva l’aria rilassata e sembrava a proprio agio, come se da un momento all’altro potesse saltare giù nell’arena per unirsi alla competizione, senza perdere la propria regalità.
Tekmessa si rivolse alle atlete. «In onore di chi gareggerete?»
«Per la gloria delle amazzoni» risposero le concorrenti all’unisono. «Per la gloria della nostra regina.» Diana sentì battere forte il cuore. Non aveva mai pronunciato quelle parole prima. Non da concorrente, almeno.
«A chi vanno le nostre lodi ogni giorno?» domandò Tekmessa.
«A Era» ruggì il coro unanime. «E ad Atena, Demetra, Estia, Afrodite, Artemide.» Le dee che avevano creato Themyscira per donarla a Ippolita come rifugio sicuro.
Tekmessa fece una pausa, durante la quale Diana udì le atlete sussurrare altri nomi: Oya, Durga, Freyja, Maria, Yael. Nomi un tempo invocati nella morte, nelle ultime preghiere delle guerriere cadute in battaglia, parole che le avevano portate sull’isola offrendo loro una nuova vita come amazzoni. Al suo fianco, Rani mormorò i nomi delle Devi – le sette Madri – che combattevano i demoni, e si premette sulle labbra l’amuleto rettangolare che portava sempre con sé.
Tekmessa alzò in aria una bandierina color sangue identica a quelle che aspettavano le concorrenti a Bana-Mighdall.
«Che l’isola possa guidarvi a una giusta vittoria!» gridò.
Lasciò cadere la stoffa di seta rossa. La folla ruggì. Le atlete si lanciarono verso l’arco orientale. La gara era iniziata.
Lei e Maeve avevano previsto l’imbottigliamento all’uscita, eppure Diana avvertì ugualmente una fitta di frustrazione quando le atlete si accalcarono nella galleria di pietra nel tentativo di lasciare per prime l’arena, in un caos di tuniche bianche e gambe muscolose, mentre i passi rimbombavano nella strettoia. Alla fine, raggiunta la strada, ciascuna scelse il proprio itinerario per attraversare l’isola.
Non si partecipa a una corsa per perdere.
Diana sincronizzò l’andatura al ritmo di quelle parole; i piedi nudi battevano il sentiero sterrato che tagliava il Bosco di Cibele per raggiungere la costa settentrionale dell’isola.
Di norma, percorrere i lunghi chilometri di foresta avrebbe comportato una lenta marcia, ostacolata da tronchi caduti e grovigli di fitte fronde, aprendosi la strada con una lama che avrebbe inevitabilmente finito per perdere il filo. Tuttavia Diana aveva studiato a fondo il tragitto. Un’ora dopo essere entrata nel bosco, sbucò dal folto della vegetazione sulla deserta strada costiera. Il vento le scompigliò i capelli e spruzzi salmastri le sferzarono il viso. Respirò a pieni polmoni e controllò la posizione del sole. La vittoria era a portata di mano: non un semplice piazzamento sul podio, ma la vittoria!
La settimana prima aveva ideato il percorso con Maeve e per due volte l’avevano seguito in segreto, alle prime luci dell’alba, quando le loro sorelle si stavano ancora alzando dal letto, i fuochi delle cucine aspettavano di essere accesi e gli unici occhi indiscreti di cui preoccuparsi erano quelli di chi era in giro a caccia o a piazzare reti per la pesca. Tuttavia le cacciatrici battevano i boschi e i campi a sud, e nessuna pescava lungo quel tratto di costa: non c’era un solo punto adatto a mettere in acqua le barche, soltanto una scogliera ferrigna a strapiombo sul mare e una piccola grotta inospitale, raggiungibile da un sentiero così stretto che bisognava camminare di traverso, con la schiena premuta contro la roccia.
La costa settentrionale era grigia e brulla; Diana conosceva ogni centimetro di quel luogo segreto: i suoi anfratti, le sue caverne, le pozze create dalla marea tra gli scogli, gremite di patelle e anemoni. Era un bel posto per stare da soli. L’isola cerca di compiacere, le aveva detto la madre. Ecco perché in alcune zone Themyscira ospitava foreste di conifere e in altre alberi della gomma; perché si poteva trascorrere un pomeriggio a vagabondare per i prati in groppa a un pony dal collo curvo e la sera risalire a dorso di cammello le creste delle dune di sabbia illuminate dal chiaro di luna. Erano tutti frammenti delle vite che le amazzoni avevano condotto prima di giungere sull’isola, piccoli paesaggi del cuore.
A volte Diana si domandava se Themyscira avesse creato quel tratto di costa settentrionale apposta per lei, affinché potesse mettersi alla prova arrampicandosi sulle pareti scoscese della scogliera, o per offrirle un rifugio quando l’essere figlia di Ippolita diventava un fardello troppo pesante.
Non si partecipa a una corsa per perdere.
La madre non le aveva fatto una raccomandazione generica. Gli insuccessi di Diana avevano un significato diverso, lo sapevano entrambe, e non soltanto perché lei era una principessa.
Diana aveva quasi l’impressione di vedere lo sguardo penetrante di Tekmessa su di sé, di sentire il tono beffardo della sua voce. Rilassati, Pisside. Era il soprannome che la stessa Tek le aveva affibbiato. Pisside: un piccolo recipiente di argilla per custodire gioielli o conservare la tintura di cocciniglia con cui imbellettare le labbra. Il nomignolo era innocuo, un’amorevole presa in giro, affermava Tekmessa. Eppure ogni volta per lei era una pugnalata: le ricordava che non era come le altre amazzoni, e mai lo sarebbe stata. Le sue sorelle erano guerriere temprate da mille battaglie, forgiate dalle sofferenze e destinate alla grandezza nel passare dalla vita all’immortalità. Tutte loro si erano guadagnate un posto a Themyscira. Tutte tranne Diana, nata dal suolo dell’isola e dal desiderio di Ippolita di avere una figlia, plasmata con l’argilla dalle mani di sua madre... vuota e fragile. Rilassati, Pisside. Non vogliamo certo vederti andare in pezzi.
Diana regolò il ritmo della respirazione e continuò a correre. Non oggi, Tek. Oggi l’alloro sarà mio.
Lanciò un’occhiata fugace all’orizzonte, lasciando che la brezza marina le asciugasse il sudore sulla fronte. Attraverso il velo di nebbia, scorse la sagoma bianca di una barca. Si era avvicinata al confine abbastanza perché Diana ne distinguesse le vele. L’imbarcazione era piccola. Forse una goletta? Aveva sempre problemi a ricordare i termini nautici. Albero di maestra, albero di mezzana, un migliaio di nomi per le vele e i nodi del sartiame. Un conto era prendere lezioni di marineria in barca con Teuta, che aveva navigato con i pirati illirici, un altro era starsene rinchiusa nella biblioteca dell’Efeseo a studiare con occhi stanchi i disegni di un brigantino o di una caravella.
A volte lei e Maeve si sfidavano a chi individuava per prima una nave o un aereo, e un giorno avevano persino avvistato all’orizzonte la sagoma imponente di un transatlantico. Tuttavia la maggior parte dei mortali si teneva alla larga da quella zona dell’Egeo, dove le bussole impazzivano e gli strumenti smettevano di funzionare a dovere.
Quel giorno sembrava che, al di là della nebbia del confine, si stesse preparando una tempesta; Diana si rammaricò di non potersi fermare a osservarla. La pioggia che cadeva su Themyscira era leggera e prevedibile, non aveva niente a che fare con il rombo minaccioso dei tuoni o l’improvviso bagliore dei lampi in lontananza.
«Non ti mancano mai le tempeste?» aveva chiesto a Maeve un pomeriggio, mentre si crogiolavano al sole sulla terrazza del palazzo reale, ascoltando i cupi brontolii di un temporale lontano. Maeve era morta nella battaglia di Crossbarry; le ultime parole sulle sue labbra erano state una preghiera a santa Brigida d’Irlanda. Era nuova dell’isola, almeno per la media delle amazzoni, e veniva da Cork, dove le tempeste erano frequenti.
«No» aveva risposto con il suo tipico accento cadenzato. «Mi mancano una buona tazza di tè, i balli e i ragazzi... di sicuro non la pioggia.»
«Ma anche noi balliamo!» aveva protestato Diana.
Maeve era scoppiata a ridere. «Balli in modo diverso quando sai che non vivrai per sempre.» Poi si era stiracchiata, le lentiggini come una densa nuvola di polline sulla pelle diafana. «Credo di essere stata una gatta in una vita precedente, perché tutto quello che voglio è starmene sdraiata a sonnecchiare al sole.»
Calma. Diana represse l’impulso di accelerare. Era difficile ricordarsi di dover risparmiare le forze con il sole del primo mattino che le riscaldava le spalle e il vento che la sospingeva. Si sentiva forte, ma del resto era facile provare quella sensazione quando era da sola.
Un boato fragoroso si propagò sulle onde, uno schianto metallico come di una porta sbattuta con forza. Diana inciampò. Dall’orizzonte azzurro si levò una gonfia colonna di fumo, la base lambita da fiamme guizzanti. La goletta andava a fuoco, la prua ridotta a un ammasso di schegge, l’albero di maestra spezzato, le vele afflosciate sull’impavesata.
Diana si accorse di aver rallentato e si affrettò a recuperare il giusto ritmo. Non c’era niente che potesse fare per la goletta. Gli aerei cadevano. Le navi naufragavano sugli scogli. Era la natura del mondo mortale: un luogo dove i disastri potevano capitare, e spesso lo facevano. La vita umana era una marea di sofferenza, una marea che non raggiungeva mai le coste dell’isola. Diana concentrò lo sguardo sul sentiero. In lontananza già si scorgeva il bagliore dorato del sole riflesso sulla grande cupola di Bana-Mighdall. Prima la bandierina rossa, poi la corona di alloro. Era questo il piano.
Un grido risuonò sulle ali del vento.
Un gabbiano, si disse. Una ragazza, obiettò un’altra voce dentro di lei. Impossibile. Un grido umano non poteva arrivare così lontano, giusto?
Non aveva importanza. Lei non poteva farci niente.
Eppure il suo sguardo tornò a scrutare l’orizz...