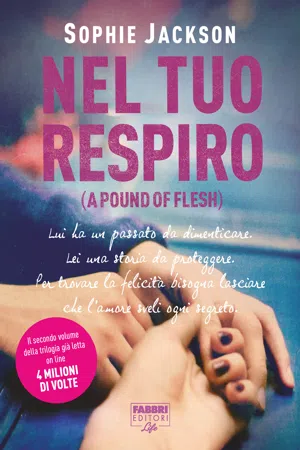![]()
1
La prima volta che Max O’Hare pensò di togliersi la vita fu il giorno del funerale di suo padre. Era una grigia mattina di metà ottobre, di quelle in cui il vento ti colpisce dritto in faccia e la pioggia, più che cadere, scende dal cielo a cascate; di quelle in cui anche gli sciocchi ottimisti si chiedono perché cavolo si credono tanto felici.
Max osservava in silenzio la bara di suo padre che veniva calata sotto terra, accanto a quella della madre Hazel. Sulla splendida lapide – dove a lettere d’oro c’era scritto che lei aveva soltanto ventisei anni quando era rimasta uccisa in un frontale, mentre andava a festeggiare il secondo compleanno del figlio – ora si sarebbe aggiunto un altro nome. Dopo una coraggiosa battaglia di un anno e mezzo contro un tumore al pancreas, alla fine Connor O’Hare si era dovuto arrendere alla malattia, e Max era rimasto orfano.
E ora non faceva altro che domandarsi che diavolo fare della sua vita.
Certo, aveva l’attività di famiglia da portare avanti, un’officina specializzata nella customizzazione delle auto. Aveva imparato il mestiere con entusiasmo e passione, ma da quando suo padre non era più stato in grado di occuparsene, tutto aveva perso importanza: le macchine potenti, il rombo dei motori, niente contava più davanti alle sedute di chemioterapia e alle assurde parcelle dell’ospedale. Non che Connor O’Hare si fosse mai lamentato o preoccupato: nel momento in cui Max aveva cominciato ad agitarsi per tutte quelle visite e le spese, suo padre gli aveva sorriso e gli aveva detto che la vita è troppo breve per perdere la testa dietro a delle sciocchezze. Era fatto così. Forse per questo non si era incazzato neppure una volta quando Max, da adolescente, veniva riportato a casa dalla polizia, o quando lo avevano arrestato per possesso di droga o per aver truccato un motore. Si limitava a scrollare le spalle, deluso, e gli diceva: «Un giorno troverai la tua strada. Sono solo incidenti di percorso».
Max non sapeva nemmeno spiegare perché si mettesse sempre nei casini. Per noia? Forse. Non poteva neanche usare la scusa della famiglia disastrata: Connor O’Hare era un brav’uomo e aveva fatto il possibile per tirare su un figlio da solo. Max era soltanto un ribelle che giocava secondo le proprie regole, il peggior nemico di se stesso. Avrebbe voluto essere forte come il padre, ma falliva sempre.
Fedele al suo carattere, il padre di Max aveva combattuto valorosamente contro la malattia, dimostrando grande coraggio fino alla fine, eppure non si era spento da guerriero. La sua morte non aveva avuto niente di eroico. Non aveva sussurrato parole sagge al figlio per lasciargli una lezione di vita o esprimere alcun rimpianto: ormai il tumore si era esteso ai polmoni e alla gola, e non poteva più parlare. Max era stato spettatore muto di un decadimento che aveva sottratto al padre tutta l’esuberanza che lui conosceva e rispettava: dell’uomo cui aveva voluto bene era rimasto solo il guscio. Era scivolato via nel sonno in un letto di ospedale mentre suo figlio gli teneva la mano.
Il dolore era stato così forte che Max non era nemmeno riuscito a piangere. Gli occhi erano rimasti ostinatamente asciutti, come se la sofferenza avesse chiuso ogni canale dentro di lui, ogni vena e ogni arteria.
Ovviamente, Max aveva degli amici. Amici che erano più di una famiglia, pronti ad aiutarlo. Faremo tutto il possibile. Se hai bisogno di parlare siamo qui. Che cavolo, a malapena riusciva ad alzarsi dal letto e quelli si aspettavano che parlasse. Apprezzava l’interessamento, ma le loro parole erano solo sospiri in una brezza che, con il passare del tempo, stava trascinando Max in una depressione sempre più nera. Aveva toccato il fondo quando si era scolato una bottiglia di vodka e si era fatto almeno una decina di tiri di coca fissando delle pillole che aveva trovato tra le cose di suo padre.
Sarebbe stato così facile… Un attimo e via. E del tutto indolore.
Perché ciò che più desiderava era un’esistenza libera dal dolore.
Alla fine, però, si era fermato. Non era orgoglioso della sua codardia, ma come gli aveva detto Carter, il suo migliore amico, aveva vent’anni e una vita intera davanti. E così aveva deciso di vivere. Beveva, scopava, aveva iniziato a trafficare droga, a spacciare; gli avevano sparato, l’avevano arrestato, era uscito su cauzione… Poi si era ripulito e aveva ricominciato da capo.
La sua vita si era trasformata in un dopo sbronza continuo alternato a momenti di delirio assoluto. Riusciva a tenere a galla l’officina grazie ai soldi dello spaccio, con cui pagava i dipendenti; ma dal tramonto all’alba faceva festa. E con il passare dei mesi, la tristezza che aveva provato il giorno del funerale aveva cominciato a svanire lentamente, lasciandolo immerso in una specie di torpore. Non provava più alcun dolore. Niente. E andava benissimo così. Credeva che non avrebbe mai più sentito nulla, e d’altronde non era nemmeno sicuro di volerlo.
Finché lei non aveva fatto irruzione nella sua vita…
Max alzò gli occhi dal tappeto color crema sotto i suoi piedi e guardò l’uomo che aveva di fronte. Elliot aspettava pazientemente che aggiungesse qualcosa, invano. Max aveva già detto molto più di quanto intendesse. Non parlava di suo padre da tantissimo tempo e, anche se erano passati otto anni dal funerale, riaprire la ferita faceva male esattamente come quel giorno.
Prese il bicchiere da sopra il tavolino di legno accanto alla poltrona e mandò giù un lungo sorso d’acqua. Quel silenzio carico di aspettative era soffocante, e Max cominciò ad agitarsi.
«Intuisco che per oggi è tutto.» Elliot sorrise e scrisse rapidamente qualcosa sul taccuino che teneva sempre sulle ginocchia. Max non replicò e fece un profondo respiro: se l’era cavata. Aveva imparato in fretta che il dottor Elliot Watts era un osso duro. Okay, in quanto terapeuta faceva parte del suo lavoro, ma non mollava mai la presa. Max doveva comunque ammettere che gli piaceva, sebbene lo costringesse a ripercorrere i sentieri più bui del suo passato.
«Hai fatto grandi progressi» aggiunse Elliot annuendo. «So che non è facile per te parlare di tuo padre.»
No, infatti.
Scribacchiò qualcos’altro. «Sei qui da quindici giorni. Come ti trovi con i farmaci?»
Max si strinse nelle spalle. Tutte le mattine doveva prendere una miriade di pillole dall’aspetto bizzarro: antidepressivi, Ritalin, amantadina. Ognuna lo aiutava per un problema specifico: il dolore, le notti insonni, le crisi di astinenza. E perlopiù ci riuscivano. In fin dei conti, pure le medicine sono droghe, anche se la roba che conosceva lui avrebbe preso l’ansia a calci in culo, gliel’avrebbe fatto tornare duro in un secondo e avrebbe azzerato l’appetito mostruoso che lo stava facendo ingrassare. Quella roba che ogni notte, quando chiudeva gli occhi, lo chiamava come il canto delle sirene.
Sentiva il sangue scorrere pigramente nel suo corpo a ogni battito del cuore. Voleva disperatamente provare di nuovo il fuoco che segue una sniffata, l’euforia, la sua vita. Aveva bisogno di una botta. Solo una cazzo di botta.
Elliot si raddrizzò sulla sedia, come se avesse percepito il desiderio di Max. «Come vanno gli incubi notturni?»
La paura gli squassava le ossa. Deglutì e si sfregò le mani; il suo disagio era palpabile. Gli incubi erano terrificanti, così vividi e angoscianti che sudava freddo solo a pensarci. Erano cominciati qualche giorno dopo che aveva smesso di farsi, all’arrivo in clinica, e, nonostante le medicine, non sembravano voler cessare. Gli occhi cerchiati ne erano la prova.
«Possiamo aumentare la dose, se pensi che possa servire» continuò Elliot. «Hai bisogno di riposare.»
Max sospirò e abbassò il mento in modo impercettibile, incapace di contrapporre il proprio orgoglio alla paura che lo aspettava ogni volta che provava a addormentarsi.
«Okay, ti cambio la prescrizione» decise Elliot.
«Grazie» rispose piano Max, ma era impossibile esprimere la sua gratitudine a voce.
«Vuoi parlarmi degli incubi?»
«No.» Max si sfregò le tempie: era lì che, di notte, lo aggredivano quelle immagini mostruose. Elliot restò in silenzio e lui alzò la testa. «Sono troppo brutti.»
Si tirò su il cappuccio della felpa fino a nascondere il viso, nel tentativo di annullarsi completamente. Lo faceva sempre, sia durante gli incontri individuali sia in quelli di gruppo, tanto Elliot non ci dava peso. Max non sapeva perché, però lo aiutava a ridurre la tensione che sentiva al pensiero di dover condividere con degli estranei tutta la merda che gli era successa. Il cappuccio era un bozzolo, un muro dietro cui ripararsi e rendere almeno un po’ più facile il percorso di disintossicazione.
«Potresti riportare gli incubi nel quaderno che ti ho dato la settimana scorsa. So che è ancora intonso.» Elliot rispose con uno sguardo beffardo all’occhiata divertita che gli lanciò Max.
Scrivere su un quadernetto del cazzo? No, grazie.
«Va bene, senti» riprese il dottore spostandosi più avanti sulla sedia. «Se vuoi parlare sai dove trovarmi. Qui vogliamo tutti darti una mano a uscire da questa situazione. Non sei solo, capito?»
Max sbuffò. Come no… Era circondato da persone che «avevano a cuore il suo benessere», che volevano «aiutarlo a ripulirsi», che volevano che «buttasse tutto fuori», assicurarsi che fosse «a suo agio», e non ossessionato dall’idea di uscire da quel posto del cavolo e trovare uno spacciatore.
Sì, stava bene ed era circondato da brava gente.
Ma non si era mai sentito così solo.
![]()
2
Sette anni prima…
Come al solito, la festa era degenerata. Era quasi mezzanotte, Riley Moore e tre suoi amici buttavano giù shottini di vodka, sollevando i bicchieri con i denti dal corpo nudo di due ragazze, sdraiate sul tavolo, mai viste prima. Max sorrideva, mentre gli altri gridavano ed esultavano, si davano il cinque e si battevano il petto ogni volta che l’alcol traboccava sul seno delle ragazze e Riley leccava via le gocce.
Max aveva conosciuto Riley un paio di anni prima attraverso amici comuni, e pur non sapendo molto del suo passato aveva imparato abbastanza in fretta che era uno a cui piaceva fare baldoria e che beveva come un matto, ma a quanto pareva senza ubriacarsi mai. Era completamente fuori di testa, però zero droga, non si faceva nemmeno le canne, diceva che non era roba per lui. Max aveva sempre ammirato il suo autocontrollo.
Gli unici vizi di Riley erano le auto e le donne. Decine di donne.
Max sentì un forte colpo sul gomito. Si girò e vide il suo migliore amico, Carter, sballato e sbronzo, che stringeva una brunetta piuttosto carina e decisamente poco vestita.
«E fammi un sorriso!» esclamò. «Dài, è una festa.»
Max annuì, sollevò la bottiglia di birra e gli fece un cenno. «Sto benissimo» replicò, finendo la birra in un sorso. L’effetto della coca che aveva sniffato un’ora prima stava svanendo. «Non hai niente per tirarsi su?»
Carter annuì, frugò nelle tasche dei jeans e tirò fuori una bustina. «Fatti un tiro, ubriacati, scopa… Qualunque cosa, basta che ti fai venire un cazzo di sorriso!»
Inciampò su un divano e ci crollò sopra con la sua nuova amica, e Max scoppiò a ridere. Cominciarono a darci dentro davanti a tutti. Quel bastardo aveva ragione, però: Max aveva quasi ventidue anni, aveva bisogno di lasciarsi andare, di divertirsi, di liberarsi di quel dolore che, ancora dopo un anno e mezzo dalla morte di suo padre, lo azzannava al collo. Ma senza un paio di tiri di coca e una birra era impossibile.
«Ci sei anche tu!» La voce squillante di una delle ragazze mezze nude costrinse Max ad alzare la testa. Una tipa magra dai capelli rossi scese dal tavolo, si infilò la maglietta – con grande delusione degli uomini presenti – e corse verso la porta d’ingresso spalancata.
Max la guardò con un sorrisino, che svanì appena vide chi c’era sulla soglia. Wow. Alta, bionda. Molto bionda. E bionda naturale. Indossava una maglietta rossa a maniche corte e un paio di jeans neri che le aderivano al corpo come una seconda pelle. Era… bellissima.
«Vieni a vedere cosa stiamo facendo con Riley!» La rossa trascinò in cucina l’intrigante nuova arrivata.
Dall’espressione che aveva mentre si guardava intorno in quel delirio, Max capì che non era il tipo da spogliarsi davanti a tutti e permettere a degli sconosciuti di bere shottini dalle sue tette. Bizzarro, ma a quel pensiero provò un certo conforto. Era elegante e slanciata, e lui piegò il collo per seguirla in mezzo alla folla della festa. Si era dimenticato degli altri, non gliene importava nulla di loro.
«Riley, lei è Lizzie, la mia migliore amica. Lizzie, ti presento Riley.» La rossa si aggrappò al braccio di Riley e Lizzie sorrise.
E che sorriso. Denti bianchissimi, scintille e arcobaleni.
«Ciao, Liz» disse Riley. «Vuoi qualcosa da bere?»
«Mi chiamo Lizzie. E no, non bevo, devo guidare» rispose lei.
A Max sfuggì una risata per la sua sfacciataggine e lo sguardo sorpreso di Riley.
«Be’, cavolo, Lizzie, almeno ti prendo una Sprite» ribatté Riley divertito.
Prima che lei potesse rispondere, le aveva già riempito il bicchiere e glielo porse facendole l’occhiolino. Lizzie reagì con un mezzo sorriso: la cosa più sexy che Max avesse mai visto in vita sua. Si avvicinò al gruppetto e infilò la bustina di coca nella tasca posteriore dei pantaloni. Ormai la sua attenzione era rivolta altrove.
Lizzie rimase alla festa per una quarantina di minuti, e per tutto il tempo lui non riuscì a staccarle gli occhi di dosso. Era simpatica e affascinante; un paio di volte notò persino che guardava nella sua direzione. Lui le sorrise e le fece un cenno, e sulle guance di Lizzie comparve una deliziosa sfumatura rosata.
Di norma Max si sarebbe avvicinato e avrebbe iniziato a riempirla di complimenti; in base alla sua esperienza, sapeva che le ragazze ci andavano pazze.
Qualcosa però lo trattenne. Qualcosa di strano e allarmante. Qualcosa gli disse che Lizzie gli avrebbe dato un calcio nelle palle se lui non fosse stato semplicemente se stesso.
Così si limitò a osservarla. E quando lei se ne andò, capì che doveva rivederla a tutti i costi.
Il centro di disintossicazione si trovava in Pennsylvania, nel mezzo di un enorme terreno di sei ettari. Prima che la neve si facesse troppo alta, Max passeggiava spesso nei dintorni; si fermava per una sigaretta, poi riprendeva a camminare. Tutto quel silenzio gli feriva le orecchie e gli dava i brividi. Abituato com’era alla confusione di New York, i campi e l’aria pulita lo mettevano a disagio.
Quando non era impegnato in uno dei quindici incontri settimanali con Elliot o con il suo consulente, o quando non vagava senza meta, se ne stava nella sua stanza ad ascoltare musica e a leggere. All’inizio, nel periodo in cui era ancora alle prese con l’astinenza da cocaina, era lento come una lumaca; ma dopo due settimane aveva cominciato a sentire il fuoco sotto i piedi. Elliot gli aveva promesso che, una volta stabilizzatosi con le medicine, avrebbe potuto allenarsi con un personal trainer. Max moriva dalla voglia di andare in palestra a buttare fuori un po’ dello stress e della tensione che gli pesavano sulle spalle. Però doveva aspettare. In alternativa gli era stato proposto di frequentare un corso di yoga: una cosa tranquilla, insomma. Aveva riso in faccia a Elliot e gli aveva...