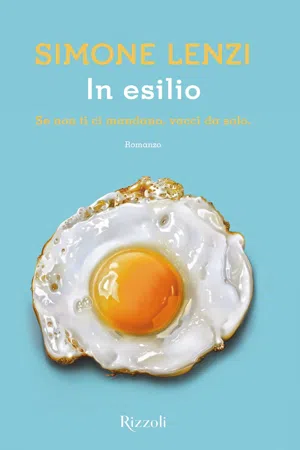![]()
1
In esilio
Questa non è una storia. È un invito a guardare di nuovo il cielo di notte, in estate, come si faceva da ragazzi, quando cercavamo di riconoscere il disegno delle costellazioni. Non è una storia, perché le storie le abbiamo viste già tutte in televisione, per tutte le sere di questa nostra prematura vecchiaia in cui abbiamo smesso di uscire a guardare il cielo d’estate e siamo rimasti seduti sul divano ad ascoltare, a osservare milioni di storie che ci scorrevano davanti.
La storia della bambina che nacque con le gambe attaccate, come una sirena. La storia dell’uomo che aveva un tumore da cento chili. La storia dei ciccioni che non riescono più ad alzarsi dalla sedia. La storia dei nani che si amano. La storia delle malattie che non conosce nessuno, come quella di Jane che adesso non può fare a meno di chiedersi come mai nessun medico in vent’anni abbia capito cosa diavolo avesse finché un dottore dell’università di Chicago, l’unico esperto al mondo della sindrome, non le dice che la sindrome che conosce solo lui colpisce un americano su dieci milioni. Ma si metta l’animo in pace, perché non c’è cura. La storia degli omicidi della porta accanto. Delle reginette di bellezza assassinate nella provincia americana più profonda. La storia dei cuochi vagabondi che assaggiano una brodaglia in culo al mondo e cercano di spiegarti quanto è buona. E allora mugolano qualche secondo, agitano la mano davanti alla telecamera e poi finalmente te lo dicono: «Mmm… ohhh… wow, ma quanto è buona!». La storia di quelli che si trasferiscono in Italia dall’Arkansas e scoprono che in Italia non usiamo l’asciugatrice per i panni, ma non importa, adoriamo questo Paese! La storia del ragazzo e di suo padre che ha cambiato sesso ed è ancora suo padre ma ora si chiama Polly. E la storia naturale delle corna, in ogni triangolazione possibile. Di Anna che si era sentita di nuovo una ragazzina e di Marco, il suo istruttore in palestra, che una sera si era fermato a parlare con lei e l’aveva guardata come non la guardava più nessuno da anni e, sì, lei aveva perso la testa. La storia di quelli che comprano box all’asta e ci trovano dobloni, la storia di quelli che devono comprarsi la casa al mare, ne vedono tre e poi ne scelgono una. La storia dei plutocrati umiliati, la storia del boss che si finge addetto alle pulizie in uno dei suoi diecimila supermercati e poi stacca un assegno da diecimila dollari per far studiare il figlio di Jemima, la cassiera che ha sempre un sorriso per tutti i clienti, anche se ha avuto una vita difficile ma Gesù è sempre stato al suo fianco. La storia delle tette rifatte male e di tutta la chirurgia che c’è voluta a ritirarle su. La storia dei parassiti che ti entrano in un occhio mentre fai il bagno nel lago e di quelli che ti entrano in un piede se pesti una merda e di quelli che ti prendi se mangi un certo granchio giapponese crudo. La storia delle ragazzine che partoriscono distrattamente. La storia dei pornostar. La storia di gente che scopa su un’isola deserta. La storia delle case da ristrutturare. La storia dei matrimoni napoletani nella reggia di zucchero e panna, dell’ugola d’oro che canta al ricevimento, della limousine a noleggio e dei grandi ammennicoli sbrilluccicanti che pendono alle orecchie, ai polsi, al collo degli invitati. La storia dell’aspirante chef umiliato dagli chef più stellati, che dentro quel piatto aveva messo tutto se stesso, le sue emozioni, la sua storia, eppure quel piatto fa schifo. La storia dei pasticcieri che si incasinano con la Victoria’s Cake e vedono il loro sogno distrutto. La storia dell’abito da sposa perfetto per il più bel giorno della mia vita e la storia della checca inorridita dalla nostra atroce mancanza di stile; la storia dei buongustai che vanno a mangiarsi una cipolla specialissima in un posto che prima conoscevano solo loro ma che adesso conosciamo tutti. La storia delle grandi invenzioni umane e la storia dell’universo, dei buchi neri, delle galassie. La storia dei file segreti della CIA, dei grandi complotti, della vita su Marte, delle civiltà aliene, la storia del mondo fra cent’anni, dopo l’Armageddon di cui si ha sempre più desiderio e sempre meno paura. La storia del jihadista della porta accanto, che salutava tutti ed era tanto gentile. La storia del fatto che ci sono molte teorie sul mistero dei cerchi nel grano, ma ce ne fosse una di cui mi frega qualcosa. Insomma, i milioni di storie che mi sono fatto raccontare, seduto sul divano, in questa prematura vecchiaia, di cui però questa storia non fa parte perché, qualunque cosa sia, questa storia non è una storia. Ne è solo la fine, indovinata prima che accada, in un cielo vuoto. Il presagio di una fine.
Si tratta allora di unire i punti e vedere se ne venga fuori un’immagine che abbia senso, per quanto i punti non siano così ben numerati da non lasciare adito all’errore, per quanto l’immagine sia piuttosto evanescente e confusa, come una macchia di Rorschach o quella nuvola in cui indovinammo il muso di una lepre. Ma poi, come una lepre, la nuvola fuggiva. Si sfilacciava nel vento. E alla fine non restava altro che la fine stessa in un cielo immensamente vuoto. Ecco, questo è un invito a indovinare la fine in un cielo immensamente vuoto di una notte d’estate.
Io non so ancora che fine faccio, e neanche so dire esattamente quando ho cominciato a fare la fine che faccio. Ma sono certo che sto facendo una fine. D’altronde, è quasi più facile capire che fine fanno gli altri, quando gli altri cominciano a farne una, che non capirlo per se stessi, e questo perché, se non fosse così difficile, molti finirebbero col fare una fine diversa da quella che fanno. Non so quando ho cominciato a fare questa fine che faccio, dicevo, ma penso di aver cominciato qualche anno fa. Mi vengono in mente episodi apparentemente insignificanti, che forse non c’entrano nulla l’uno con l’altro, ma che mi si presentano insieme alla memoria.
Lavoravo come programmatore in un’azienda informatica, avevo poco più di trent’anni. Non so perché facevo quel lavoro di cui non mi importava niente, che era lontano milioni di anni luce da ogni mio interesse, eppure lo facevo. Stavo seduto alla scrivania, in un ufficio con vista sull’inceneritore. Aprivo e chiudevo la guardia del “se” (se X è uguale a questo fai così, altrimenti fai questo, fine del “se”), mandavo in circolo i valori di una variabile (per ogni X che va da zero a qualcosa), mettevo in relazione uno a molti le tabelle di un database. Soprattutto mi rompevo i coglioni. Leggevo il blog di quel comico che fondò il Movimento.
Una volta, ricordo, sul blog c’era una discussione sui resti. Su quelli che sbagliano a farti il resto. Tutti che raccontavano la loro esperienza personale: il tabaccaio, il giornalaio, il farmacista, il barista che sbaglia a farti il resto. Tutti erano stati vittime di un resto sbagliato, e guarda un po’, ci fosse mai stato uno di questi signori che aveva sbagliato a farti il resto dandoti più di quel che ti spettava. Sì, stai fresco. Macché. Sbagliavano tutti per difetto: a uno avevano cercato di fregare due euro, a uno addirittura dieci. Sbagliavano tutti apposta, tabaccai, farmacisti, baristi, tassisti, per fregarti i soldi. Ma era arrivato il momento di dire basta. Loro non ci stavano più a farsi fregare sui resti. Non erano più soli, non erano più atomi spersi nell’universo: erano diventati una legione. «Come ti chiami?» chiese Gesù. «Mi chiamo Legione, perché siamo tanti.»
Chissà quante volte avranno sbagliato a farmi il resto pure a me, riflettevo. Mi avranno fregato milioni e io non me ne sono neanche accorto. Ma no, pensavo. Forse a me non mi hanno mai fregato, oppure mi hanno fregato ma non l’hanno fatto apposta, oppure qualche volta mi avranno dato di più e io me li sarò intascati in perfetta buona fede. Oppure va bene, c’è un complotto dei commercianti per dissanguarti, ma se anche fosse così, io stavo meglio quando non lo sapevo. Stavo meglio fregato e inconsapevole, pensavo.
Facevo il programmatore, ma avevo studiato filosofia da giovane. E avevo smesso proprio per quello: lo smascheramento. Non ne potevo più dello smascheramento. Tutti i filosofi dello smascheramento: hegel, schopenhauer, marx, kierkegaard, nietzsche che smascheravano questo e quello. Non ne volevo più sapere. Che ci fosse altro dietro le apparenze, un velo da squarciare, un re da denudare, un sistema da decostruire, un mondo da criticare, non volevo saperne più nulla. E se non mi interessava smontare la metafisica, o il sistema capitalista, o il mondo come volontà e rappresentazione, o l’ipocrisia del cristianesimo, cosa poteva fregarmene di scoprire che il tabaccaio mi aveva fregato venti centesimi? E se anche fosse successo, che il tabaccaio mi aveva fregato venti centesimi, cosa potevo cavarne? Ma poi dài! Io il mio tabaccaio lo conosco, mi dicevo, ma è una bravissima persona, via! Però era cominciato da lì, credo, almeno per come me lo ricordo io. Avevo sentito un saporaccio in bocca. Perché la storia dei resti non diceva niente sui tabaccai o sui farmacisti o sui pizzicagnoli, come categorie, ma diceva abbastanza sull’aria che si cominciava a respirare. Il bisogno di sentirsi dalla parte dei giusti, dalla parte degli onesti, e un darsene la patente da soli: un saporaccio amaro in bocca. Ché lì sul blog, certo, si parlava di temi ben più importanti, l’inquinamento, le tasse, i politici corrotti, uscire dall’euro, come lavarsi le mutande con una pallina di gomma, ma era in quel dettaglio, in quella discussione marginale sul problema dei resti sbagliati, che finalmente Legione aveva gridato il suo nome. O almeno, così era parso a me. Comunque, intanto avevo smesso di fare il programmatore e mi guardavo intorno in cerca di un altro lavoro.
Però avevo anche cominciato a provare un fastidio fisico per le grandi catene del fai da te che pullulano nelle periferie commerciali della città. Perché lì Legione mi si mostrava a viso aperto, in carne e ossa. Aveva felpe comode in tessuti tecnici, color merda o vomito. Comodi borsetti girovita. E scarpe comode. Si aggirava per questi grandi centri commerciali del fai-da-te, vestito di merda, per fare tutto da sé. Basta farsi fregare da questo o quello, meglio ritingere casa da sé, montarsi da sé i pannelli solari, ripararsi la stufa, cambiarsi il rubinetto. E si capiva che, per il tempo perso, per il costo esoso delle prove e degli errori, non era questione di risparmio, ma di una profonda sfiducia in tutti gli altri, in quel prossimo che Legione ora guardava in tralice, ma con un ghigno di soddisfazione: «Non mi freghi più, ora mi faccio tutto da solo, vedrai». E rideva, perché sapeva di non essere più solo: mi chiamo Legione perché siamo tanti, tutti vestiti di merda, in tessuto tecnico, con le scarpe comode e il borsetto girovita: prova a fregarci i soldi da questo borsetto girovita, provaci, stronzo! Non puoi. Non mi faccio più fregare, perché siamo tanti.
E passava il tempo, perché il tempo non sa fare altro. Lavoravo i lavori più assurdi. Ma mi ero messo anche a scrivere. Romanzi, racconti, articoli di giornale: uno non dovrebbe mai, mi ero detto, ma così fan tutti, posso farlo anch’io.
Intanto però il fastidio mi era preso anche mentre camminavo la sera sul lungomare o lungo i canali. I ragazzi e le ragazze di quarant’anni col birrino in mano, mi davano fastidio. La postura da birrino, le gambe leggermente divaricate, il baricentro spostato un po’ in avanti, l’avambraccio destro leggermente proteso, mi dava fastidio. Il modo di tenerlo, fra due dita, quasi come un sigaro, o il bastone da passeggio di un dandy, mi dava fastidio. La parola birrino mi dava fastidio. Quando si sedevano sulle spallette dei canali, o lungo il muro del moletto, col birrino in mano, mi davano fastidio. Perché non era mai solo uno: «Mi chiamo Legione» dicevano col birrino in mano, «perché siamo tanti». Così avevo smesso di uscire la sera.
Poi mi era preso anche quando camminavo il giorno, e mi era parso che tutti intorno volessero dirmi che non ci stavano più a essere quello che erano, per cui, in definitiva, non avevo la minima idea di chi fossero né di cosa dovessi aspettarmi. L’idea che, in ciascuno di loro, ci fosse altro oltre quello che si vedeva e che quello che non si vedeva fosse in realtà la cosa più importante, mi sfiancava: il giardiniere del comune con quei demoni tatuati sull’avambraccio non era più solo il giardiniere del comune e se ne incrociavi lo sguardo era come se quegli occhi ti dicessero che lui era lì a fare quel lavoro, è vero, ma c’era ben altro. Così avevo smesso di uscire anche il giorno.
Era dunque chiaro come il nemico fosse Legione, tanto più subdolo e pericoloso perché non era solo il mio, ma, in generale, era il nemico di tutto e tutti, degli altri e di se stesso: non avevo mai pensato che la mia persona rivestisse tanta importanza da essere oggetto di attenzioni particolari. Semmai, alla fine, mi chiamavo Legione anch’io perché oramai eravamo in tanti, anche se nessuno di noi si era mai sentito davvero a casa.
Intanto però era arrivato il momento delle elezioni amministrative in città e il candidato sindaco del Partito mi aveva chiesto se avevo voglia di fare l’assessore alla Cultura in caso di vittoria. E non è che fosse proprio l’aspirazione della mia vita fare l’assessore alla Cultura, però avevo pensato che uno si lamenta, si lamenta, poi quando tocca a lui fare qualcosa si tira indietro, e non va per niente bene. Quindi sì, avevo detto, siamo d’accordo, se vinci tu faccio l’assessore. Sicuramente lo farò male, avevo pensato, ma pazienza, devo almeno provarci, ché poi a dimettermi sono sempre a tempo. E comunque, avevo pensato, la gente è stanca del Partito al governo in questa città, quindi è pure probabile che il Partito non vinca le elezioni, per cui il problema non si pone nemmeno.
E così avevo cercato di spiegare che, in realtà, dietro quella stanchezza della gente per il Partito, si nascondeva una più profonda e inconfessabile stanchezza della gente per se stessa, e che, del resto, nessuno meglio di me poteva comprenderla: anch’io ero così stanco di me stesso, ma questo mi ero guardato bene dal dirlo, che mi sarei votato contro al ballottaggio, chiunque fosse lo sfidante. La gente, cercavo di spiegare, era stanca del Partito al governo della città perché il Partito al governo della città era esattamente il sintomo della stanchezza della città per se stessa. Ora dunque si poteva certo rimuovere il sintomo, ma la stanchezza della gente per se stessa, spiegavo, sarebbe rimasta tale e quale, e avrebbe trovato sfogo in un sintomo nuovo, probabilmente più grave del primo. Perché il Partito inutile al governo inutile della città era sintomo della malattia, appunto, e non la malattia stessa, che consisteva invece in questa inguaribile, sfiancante stanchezza della gente, le cui cause profonde si dovevano meglio indagare invece di affidarsi al palliativo di una finta rivoluzione da operetta. Ma no. Per fortuna la gente non lo aveva capito e aveva finalmente spodestato il Partito inutile dall’inutile governo della città, lasciandola, senza più giustificazioni, in preda alla sua oramai decennale stanchezza, ma liberando me, almeno, dall’angoscia di dover fare una cosa che, dopo essersi rivelata inutile per me stesso e per la città, mi avrebbe allontanato definitivamente da quella contemplazione inattiva delle cose nella quale ho sprecato con curiosa passione tutta l’esistenza, consegnandomi in cambio la prova definitiva della mia inadeguatezza.
Intanto avevo smesso anche di tenere la rubrica settimanale sul giornale locale, che era per me fonte di crescente malinconia, dovendo ogni settimana scrivere pezzi fra il serio e il faceto, con un tono un po’ critico e un po’ affettuoso nei riguardi di qualcosa, la città, su cui ormai, per come la vedevo io, l’unico articolo sensato da scrivere sarebbe stato un fondo di quattro colonne e mezzo completamente bianche, un fondo di quattro colonne e mezzo di bianco silenzio in prima pagina al posto di tremilacinquecento battute in terza pagina, fra il serio e il faceto, su qualcosa di cui non sapevo più niente.
Ma per quanto me ne stessi zitto sempre e in ogni modo, zitto al mattino, zitto al pomeriggio e alla sera, chiuso in casa, c’era sempre qualcuno a cui veniva in mente di chiedermi questo e quello sulla città, come se io potessi dire qualcosa di diverso, sulla città, da quello che ormai pensavo con sempre maggiore convinzione, ovvero che la città era stanca almeno quanto me: io di me stesso e lei di se stessa, e io di lei e lei di me. E tuttavia c’era sempre qualcuno che tornava a chiedere cosa ne pensassi dell’identità culturale della città, o del Sindaco, o della giunta, o dei problemi del porto, della nettezza urbana, e io mi mettevo lì a rispondere, per cortesia, su tutto, al telefono o in bella posa davanti alla telecamera ogni volta balbettando un po’ di più, finché a un certo punto non mi avevano chiesto se volevo scrivere un pezzettino, fra il serio e il faceto, sul piatto tipico della città, conosciuto in tutto il mondo, degustato in tutto il mondo, invidiato da tutto il mondo, e io, finalmente, avevo rotto gli argini e avevo detto NO.
NO, il pezzettino sul cacciucco non lo scrivo.
Mi dispiace, grazie di aver pensato proprio a me, ma NO. Per tutta una serie di motivi ma per uno sopra tutti gli altri, ovvero che a me il cacciucco non mi piace. Il pomodoro ammazza il sapore del pesce e, comunque, a me fa venire l’acidità di stomaco. E questa cosa che pensavo da almeno quarant’anni, dalla prima volta cioè che me lo avevano fatto assaggiare da bambino, ovvero che a me il cacciucco mi resta indigesto, mi era rimasta sullo stomaco per almeno quarant’anni ma finalmente era venuto il momento di infilarsi due dita in gola e sputare la coda di rospo: NO, il pezzetto tra il serio e il faceto sul cacciucco io non lo posso scrivere. Bisogna aver rispetto dei lettori, pensavo, non si possono raccontare sempre balle, per due spiccioli poi, tra il serio e il faceto, con un tono un po’ critico un po’ affettuoso: grazie di aver pensato a me, ma NO.
E da quel momento, almeno, dire di no mi era diventato più facile: mi vuoi dire qualcosa sulla situazione del porto? No. Mi vuoi dire qualcosa sull’amministrazione comunale? No. Che ne pensi della raccolta differenziata? No. Ma che risposta è no, ti ho chiesto cosa ne pensi. Ho capito, ma io non ne penso, quindi, per brevità, no.
E pur standomene zitto sempre e in ogni modo, zitto al mattino, zitto al pomeriggio e alla sera, chiuso in casa, alla fine io e mia moglie cominciammo a prendere in considerazione l’esilio.
Se lo ricordava, lei, quel passo della Genesi in cui Lot, con moglie e figlie, lascia Sodoma, su ordine del Signore, perché il Signore ha deciso di distruggere Sodoma ma gli dispiace per Lot, perché è un brav’uomo, e allora manda due angeli per costringerlo a lasciare la città? Ecco, questa era tutta un’altra storia. Intanto, io non avevo figlie e non ero il giusto che doveva abbandonare una città iniqua su ordine del Signore. A me il Signore non mi aveva ordinato proprio nulla, e certo non ero più giusto di chiunque altro. «Però una cosa in comune con la storia di Lot c’è» dissi a mia moglie, «ed è che io devo andarmene sul serio da qui. Quindi bada bene che se ti volterai indietro a rimpiangere la città, verrai trasformata in una statua di sale e io ti lascerò lì, piantata come una statua di sale in mezzo alla piana. Per cui pensiamoci bene: devo andare in esilio, ma se tu non vuoi, possiamo anche non farne di niente. Mica hai fatto nulla tu per meritarti l’esilio. E tanto ormai esco di casa cinque minuti al giorno. Posso continuare tranquillamente a scontare i miei arresti domiciliari… ché poi a pensarci, ci risparmieremmo pure la fatica del trasloco.» «Ma no» disse lei, «andiamo pure in esilio, però in campagna.»
Così dunque prendemmo la decisione di vendere la casa, e con essa anche tutto il silenzio che racchiudeva, per ennemila euro, senza neanche cercare di comprendere come fosse possibile che qualcuno si mostrasse disposto a comprarsi ennemila euro di silenzio rinchiusi in cento metri quadri con un giardino minuscolo perché, del tutto inaspettatamente, vennero a vederla a decine e fioccarono le offerte. In silenzio arrivò dunque l’estate, che di tutte è in assoluto la stagione più silenziosa.
Agosto, dunque, ma non sapevamo che fare. Eravamo compromessi da tutti i punti di vista. Per la città, e per la casa in cui vivevamo, ormai quasi come ospiti: a settembre non sarebbe stata più nostra, ce ne saremmo andati.
Ci eravamo soprattutto compromessi davanti a un notaio e dunque, in quel limbo, che potevamo fare? La programmazione televisiva d’agosto era tutto un rimestio di repliche di storie che conoscevamo già. E faceva caldo, si doveva pur uscire. Mia moglie mi disse che c’era il mercatino sul mare. Che mercatino, chiesi. Mah, il mercatino equo e solidale. Che in fondo ci andavamo tutti gli anni, e va bene, ci saremmo andati anche quella volta al Mercatino Equo e Solidale. Cosa ci andavamo a fare, rimane un mistero, per me e forse anche per lei. Forse perché ancora ci incontravamo gente che conoscevamo. Diciamo dunque dei conoscenti, gente che comunque faceva piacere vedere una volta ogni tanto. Ci si fermava a chiacchierare un po’, si scambiavano due parole. Ci illudevamo di avere ancora delle relazioni sociali. E così anche quell’anno eravamo andati al mercatino equo e solidale e giravamo fra le bancarelle. C’era quella di Natura Amica, per esempio, e allora mi fermai a parlare con il giovane conoscente dietro al bancone, e volevo chiedergli come gli era saltata in mente quell’idea che la natura fosse amica. Amica di chi? Non sapevo avesse amici, la natura. Ma mica glielo potevo dire. Volevo ...