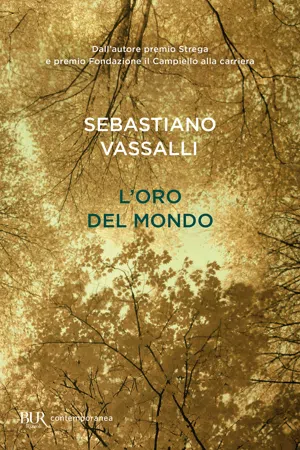![]()
L’ORO DEL MONDO
Su, amico, su, fai più in fretta! Mettiti
la pelle sulla maschera! Infilati la faccia!
Devi entrare in scena!
![]()
Il telegramma da Milano diceva: «Comunicasi at familiari avvenuto decesso Alvaro S. Sentite condoglianze» eccetera. Ci sono andato col treno e c’era lo sciopero dei mezzi pubblici: tram, metropolitana, tassì. Una baraonda, un caos. Strade rigurgitanti di automobili intrappolate nel traffico, che strombettavano, di motorini come sopra, che scoppiettavano, di automobilisti appiedati che anche così sgomitavano per sorpassarsi, di vigili congestionati che cercavano di mettere un po’ d’ordine e di sbrogliare l’orribile matassa. Invano. Sui muri, manifesti affissi a spese del Comune reclamizzavano i «poeti organizzati». Filastrocche dicevano: dove vai, il mondo è vuoto ed altre amenità. Quando poi sono arrivato all’ospedale dove zio Alvaro era morto non si trovava il cadavere, chi diceva di averlo messo da una parte e chi dall’altra; un dottore, incazzatissimo, accusava un altro dottore, gridava che gli rubavano i morti per portarli in non so che reparto e avere non so che sovvenzioni, della Regione e dello Stato. «È un’indecenza!» sbraitava. Alla fine, però, il cadavere è stato ritrovato. Era rimasto in barella su un ascensore fermo tra due piani e questa – mi ha detto un infermiere – è una situazione normalissima, qui da noi: la gente in ascensore butta di tutto, pacchetti vuoti di sigarette, assorbenti igienici, scatole di biscotti, ciabatte e tutta quella roba poi va a infilarsi dove non dovrebbe, bloccando la cabina. «Abbiamo messo cartelli su cartelli, ma non servono a niente.» Sono arrivati i tecnici, hanno cominciato ad andare su e giù per le scale tra le urla delle partorienti al primo piano e i rantoli degli agonizzanti del terzo. L’ascensore è ripartito di schianto verso l’alto, è ripiombato, s’è aperto. La barella è schizzata fuori. L’infermiere ha alzato un lembo di lenzuolo e lo zio Alvaro era lì, con un occhio chiuso e l’altro semichiuso che mi guardava; ammiccava. Sembrava proprio che mi facesse l’occhietto. Pensai che quella era la seconda volta che moriva, essendo stato fucilato dai tedeschi il 22 settembre del 1943 e abbandonato per morto sul terreno, semisepolto dai cadaveri dei suoi compagni. Lui ci scherzava, ogni tanto. Diceva: «Sono già morto una volta, posso anche morire un’altra volta». Ora era morto. Ammiccava: «Non muoio più, Sebastiano!».
Due giorni dopo l’abbiamo seppellito nel piccolo cimitero di B., all’ombra del campanile della chiesetta romanica, in fondo al viale dei platani. La Mercedes delle pompe funebri veniva avanti piano piano nel sole tiepido d’autunno e dietro eravamo in cinque: il prete, i due chierichetti che si tiravano calci negli stinchi perché tanto il prete non poteva vederli, la signora Roberta ed io. La signora Roberta era la donna di zio Alvaro: era la fidanzata diciottenne che lui aveva lasciato al paese quando era partito per la guerra e che poi, quand’era ritornato, aveva ritrovato già sposata con un uomo più anziano, quasi vecchio; era la vedova quarantenne che lo zio Alvaro ancora avrebbe voluto sposare se i parenti e i figli di lei non si fossero opposti in ogni modo («Quello è un fallito, Roberta!», «Cerca soltanto i nostri soldi» eccetera). Era l’anziana signora che lo andava a trovare in ospedale, con la veletta sul viso per non farsi riconoscere. (Da chi?) Io la vedevo per la prima volta: una donnina minuta, apparentemente fragile, dagli occhi tristi. Pensavo che era stata coraggiosa a sfidare i pregiudizi di un intero paese, tornando a B. per il funerale di zio Alvaro; ed ero anche imbarazzato perché non sapevo come comportarmi: dovevo salutarla, andare a stringerle la mano? Invece poi è stata lei che mi si è avvicinata al termine della sepoltura, mi ha preso una mano tra le sue, ha detto: «Così, tu sei Sebastiano!».
«Sì» le ho risposto. «Sono Sebastiano.»
«Chissà come mi giudichi» ha detto ancora la signora Roberta. «Chissà cosa pensate di me, voi familiari di Alvaro!»
Siamo usciti insieme dal cimitero. Le foglie gialle dei platani tremolavano nel sole pallido d’ottobre e le mietitrebbie, tra i campi, s’avviavano alla raccolta del riso. Io non avevo niente da dire e stavo zitto; del resto, non mi era mai passato per il capo di giudicare la signora Roberta. «Erano altri tempi» ha detto lei. «C’erano la guerra, la fame, la disperazione. Tante cose si facevano per disperazione e non si sarebbe potuto fare altrimenti: mi devi credere, Sebastiano. Ora tutto è diverso perché la gente non è né disperata né contenta, vive così, nel benessere. Nella sazietà. Ma non si può giudicare la disperazione di allora con il benessere di adesso.»
Che dovevo rispondere? Purtroppo, nessuno al mondo più di me è incompetente in fatto di benessere... (Non l’ho mai visto da vicino, questo famoso benessere!) Ma la signora Roberta mi guardava, s’aspettava che le dessi ragione e io gliel’ho data, le ho detto: «Non si può giudicare! È proprio vero!».
Ho alzato il braccio, ho sbirciato l’orologio: mancava ancora un quarto a mezzogiorno. Forse – ho pensato – la signora Roberta vorrà invitarmi a pranzo a casa sua e ho esclamato: «Che bella passeggiata! Che bell’aria!». L’ho preavvisata: «M’è venuta fame!».
Ho sussurrato: «A lei, no?».
Lei ha alzato gli occhi, ha scosso il capo. Non ha detto niente.
Siamo arrivati alla strada provinciale. Sul bivio del cimitero, da dove noi venivamo, s’era fermata un’automobile e ne era uscito un giovanaccio di vent’anni, d’una ottantina di chili: uno di questi giovanacci del giorno d’oggi che sanno tutto, hanno capito tutto e non valgono la carne che pesano. Teneva le mani sprofondate nelle tasche dei calzoni, la sigaretta tra le labbra e ha detto alla signora Roberta: «Andiamo a casa».
Storceva il viso con ostentazione per evitare di guardarmi. L’automobile, un’Alfa Romeo di grossa cilindrata, aveva le portiere spalancate e la radio a tutto volume inondava la pianura d’una di quelle musichette ballabili che per due o tre mesi si sentono dappertutto e poi non si sentono mai più. Roberta ha detto: «È mio nipote». E poi: «Ti ringrazio di avermi accompagnata, Sebastiano».
![]()
Zio Alvaro era alto di statura, con i capelli tutti bianchi e gli occhi azzurri. Di notte, spesso, gridava, chiamava ancora per nome i suoi compagni morti in guerra, tanti anni prima. Singhiozzava nel sonno, si graffiava. (In viso e sulla fronte.) Domandava: com’è successo? Perché? Era un riassunto della guerra, ma non di quella piccola e gloriosa dei trentamila partigiani che diventarono trecentomila il giorno della liberazione d’Italia. Dell’altra guerra. Di quella grossa e insensata che coinvolse quarantacinque milioni di italiani e che, non appena finì, fu immediatamente dimenticata da tutti: in blocco, con la sconfitta chiamata “armistizio” e con l’occupazione militare chiamata “alleanza”. Nell’arte del dimenticare il genio italico non conosce rivali; è insuperabile, eccelso. Nessuno mai fu veramente fascista, nessuno ebbe responsabilità della guerra, nessuno, o quasi, combatté. I prigionieri, i caduti erano soltanto degli stravaganti che se ne andavano per il mondo dove poi gli succedevano disgrazie. Vagabondi, instabili: tutti d’accordo a compiangerli: ma, in fondo, se l’erano voluta. Fossero stati a casa loro, pensavano gli altri, i “normali” (e che mai ci voleva a stare a casa? Una modesta sommetta da mettere in una “bustarella” oppure anche una piccola “raccomandazione”, facile da ottenere e da usare), avrebbero visto una bella Resistenza al nord, e una gradevole Alleanza al sud...
Allo zio Alvaro andò storta. Fu fucilato a Cefalonia, insieme a qualche migliaio di scervellati come lui che da tre anni, per l’appunto, se la spassavano in quell’isola. Scampò per caso: scappò in Grecia, ma fu ripreso e deportato in un campo di concentramento tedesco. Riapparve al suo paese, a B., nell’inverno del ’45; quando ormai più nessuno lo aspettava. Allora, tutti eravamo al paese. C’era perfino mio padre, già rintronato dai bombardamenti e rabbioso per via d’una valigia piena zeppa di quattrini – lui diceva – che aveva perso in Germania: centinaia di migliaia di marchi! Milioni di lire! Ansimava, sputava. Tirava calci all’indietro, come i cani quando s’imbattono nei contrassegni d’un rivale. Pronunciava tremende profezie, diceva: tutto nuovamente tornerà a rovesciarsi, ciò che ora è sopra andrà sotto e ciò che è sotto andrà sopra, chi adesso ride piangerà (e mica lacrime normali: «lacrime di sangue»!). Eccetera. Stavamo tutti in casa dei nonni cioè dei genitori di zio Alvaro e di mia madre: tre stanze, cinque persone. Ci stavamo stretti. Zio Alvaro era ridotto a pelle e ossa e anche lo stomaco non gli funzionava, non poteva mangiare cibi solidi. Beveva latte. Ogni tanto gli scappava detto qualcosa di quello che gli era capitato nei lunghi anni di naja: un episodio, un incontro, un pericolo a cui era fortunosamente scampato. Tutti insorgevano. La nonna e il nonno, i fratelli, i cognati, i parenti, il mondo. «Te e la tua guerra» gridavano. «Se n’ha abbastanza, noialtri, di queste storie di guerra!» «Non interessa a nessuno, la tua guerra!» Anche mio padre sputacchiava ogni volta che incontrava lo zio Alvaro, dava in escandescenze, sibilava: «Giuda!». Se la prendeva con mia madre, le muoveva ogni sorta di rimproveri: d’averlo costretto a vivere in campagna (lui diceva: «Qui in mezzo ai letamai»), d’essere figlia di bifolchi e sorella d’un «porco traditore», d’un «badogliano» (sputava, tirava calci all’indietro come i cani), d’avere un figlio delinquente (me), di essere delinquente lei stessa, di appartenere a una razza tarata e marcia, da secoli. Gridava così forte che lo sentivano fino dall’altro capo del paese. Pronosticava, di me: «Diventerà un assassino! Un criminale, capisci? La razza è razza, non si scappa! Il sangue è quello di Caino, uno per tutti: per te! Per tuo fratello! Per tuo figlio!». L’accusava di essere una strega e una puttana, d’averlo accalappiato e legato a sé con sortilegi puttaneschi. Mia madre allora gli tirava tutto quello che le veniva tra le mani. «Torna in città» gli diceva. (Lui, però, era già completamente sordo, non sentiva niente.) «Così ti mettono al muro! I partigiani e quegli altri che andavi a vendere in Germania!» Gli urlava in viso: «Vigliacco! Cacasotto! Stronzo!».
Un giorno che i miei genitori s’erano battuti con tanta foga che i nonni, da soli, non ce l’avevano fatta a dividerli, erano dovuti intervenire i vicini: lo zio Alvaro mi mise a cavalcioni della sua bicicletta e mi portò fuori dalle straducole di B., a passeggio tra i campi e le marcite. Mi insegnò i nomi degli alberi: i gelsi, i pioppi, le robinie. Mi raccontò la sua storia. Io avevo allora cinque anni e lui parlava con sé stesso, più che con me; ma un bambino, a cinque anni, capisce già molte cose e tutto quello che non capisce lo ricorda. Zio Alvaro mi raccontò di Roberta che – mi spiegò – era stata la sua fidanzata prima che lui partisse per la guerra, e si dovevano sposare; ma i genitori di lei l’avevano obbligata a sposare un altro. («Che ci vuoi fare... Son poveri!») Parlando era molto triste e poi mi raccontò di un’isola lontana dove tutti i suoi compagni erano morti e anche lui era scampato per miracolo ad una fucilazione in massa: disse l’angoscia e lo spavento che aveva provato quando i tedeschi li avevano scortati sul luogo dell’esecuzione («un uliveto con due pozzi»); disse il frastuono delle mitragliatrici, il colpo alla nuca che lo aveva scaraventato per terra, il sangue, la ferita che non dava dolore, i due morti che erano morti su di lui: la sua sorpresa d’esser vivo. Raccontò i gemiti dell’immenso carnaio e la voce del tedesco che gridava: «Italiani, chi è vivo venga fuori, non ha più niente da temere, oramai». Lui non si mosse. Trascorsero pochi minuti (pochi attimi?) e le mitragliatrici ripresero a sparare, anche i superstiti caddero...
Avevamo lasciato la bicicletta appoggiata al tronco di un gelso e camminavamo tra i campi appena arati. Faceva freddo; era inverno. Lo zio Alvaro mi teneva per mano e veniva avanti raccontando di sé, per la prima volta da quando era tornato: di quella sporca “sua” guerra di cui in casa non lo lasciavano parlare. Alcuni greci – mi disse – lo avevano trovato che vagava per i campi e lo avevano nascosto, medicato, consegnato ad altri greci della “resistenza” che poi l’avevano trasferito sul continente, di notte, con una barca di pescatori (“caicco”). Raccontò il viaggio. Parlando, sembrava che avesse ancora davanti agli occhi la massa oscura dell’isola tutta punteggiata di fuochi e la indicò, mi spiegò: «Bruciano i morti, Sebastiano! Con la benzina. Li ammucchiano, li cospargono di benzina e poi li bruciano. A Procopata, a Troianata, nel vallone di Santa Barbara, sul Risicuzolo, a Farsa... Dovunque abbiamo combattuto, ci sono fuochi!». Restò attonito di fronte alla pianura, ai campi arati, alla nebbia. Mormorò: «Centinaia, migliaia di cadaveri! Così, non restano tracce...».
![]()
Ne ho parlato con l’editore. L’ho incontrato per caso, ad uno di quei convegni che ormai si fanno dappertutto, in Italia, per dare modo ai “poeti organizzati” di esibirsi in pubbliche letture e ai professori “rampanti” di spifferare i loro fiati sugli argomenti più inutili, da Mito e realtà industriale a Dove va la poesia? Era distratto, frastornato. (Per quel poco che io so dell’editore, so che non ama i convegni; ma, per qualche ragione che io non so, evidentemente non aveva potuto sottrarsi a questo dove ci eravamo incontrati per discettare sul tema: Letteratura e trasgressione.) Gli ho detto: «Voglio scrivere un romanzo su una vicenda complessa e in parte ancora oscura, nonostante tutti gli anni che sono trascorsi dal ’45 ad oggi. L’Italia che esce dal fascismo. Tu che ne pensi?». Ho spiegato: «È la storia di quelli come me, che alla fine della guerra erano bambini e adesso sono degli uomini di mezza età, grigi o calvi, rinsecchiti o gonfi, rintronati o sfatti. È il romanzo della mia generazione. Da una parte ci siamo noi, bambini e adolescenti, e dall’altra tutti gli italiani – in gran parte defunti, se Dio vuole! – che sono stati fascisti per vent’anni e poi a un tratto si ritrovano così, fuori delle farneticazioni e dei sogni: faccia a faccia con il loro stupido destino. Quaranta milioni di spennacchiati senza futuro né patria né dignità: un volgo querulo e osceno, un immenso starnazzante pollaio. Sparpagliato per il mondo» eccetera. A me, parlando, capita di infervorarmi e l’editore invece mi guardava tra infastidito e distratto, faceva «sì» con la testa ma si vedeva benissimo che aveva in mente altre cose: forse le pubbliche sovvenzioni per la sua casa editrice sull’orlo della bancarotta o la bionda che entrando l’aveva salutato con la manina, «ciao ciao», e che vedendolo impegnato con me non s’era avvicinata. Chissà. Avrei dovuto lasciar perdere, lo capivo benissimo; invece io quando comincio a parlare dei miei romanzi sono inarrestabile e ho continuato a spifferare: «La Resistenza non c’entra. L’Italia piccola e nobile dei trentamila o trecentomila che combatterono nelle retrovie contro i fascisti e i tedeschi ha già una sua letteratura, del tutto ragguardevole, direi, ed è la foglia di fico che l’altra Italia, quella ignobile dei quaranta milioni di ex fascisti, ha poi usato per ricoprirsi le vergogne. In un’ennesima operazione trasformistica...».
Mentre parlavo mi sentivo ridicolo e certamente lo ero. Stavo ritto con un bicchiere tra le mani, in quel salone sfarzoso d’un palazzo che nei secoli passati aveva visto chissà quali gozzoviglie di granduchi e di principi e vaneggiavo di guerra, di fascismo... Di trasformismo: figuriamoci! Intorno a me e all’editore c’era ressa di osceni convegnisti che mi urtavano, mi spintonavano, mi tiravano calci negli stinchi e insomma cercavano a viva forza di scalzarmi da quel posto privilegiato dove io mi trovavo per occuparlo loro stessi con le loro sconce persone e poter così raccontare all’editore dei poemi che avevano nel petto, dei romanzi che avevano nel cassetto; per dirgli guardami, sono qua! Il migliore dei “poeti organizzati”, il primo autentico “romanziere del nulla”, il capofila dei “rampanti”! Tutti i letterati e i professori d’Italia amano alla follia questi convegni e in generale le occasioni dove si mangia a sbafo per tre giorni, si risparmia sul riscaldamento (variante estiva: si va al mare) e si possono curare le proprie pubbliche relazioni entro una cornice confortevolmente mondana. «Sì, certo» ha risposto l’editore: ma si vedeva che era triste anche per causa dell’ambiente, delle mani che stringeva una dopo l’altra, come in una catena di montaggio («Caro Bianchetti!», «Ciao Rossi!», «Come va, Verdolini» e così via); dei sorrisi e dei saluti che elargiva, oltre e attraverso la mia testa («Tò chi si vede: De Profundis!», «Chi l’avrebbe mai detto: Toccaferri!»). Approfittando d’un momento ch’era arrivato un ministro e tutti i Rossi e i Verdolini d’Italia erano corsi a vederlo da vicino, lui ha ripetuto: «Sì, certo. Il romanzo di una generazione. Detto così, suona bene. Ma poi in concreto i romanzi non si fanno con le generazioni, si fanno con i personaggi, Sebastiano, e tu ce li hai, i personaggi? Voglio dire, all’altezza del progetto!».
«Naturalmente» ho risposto. E ho cominciato a elencarli, dai più famosi agli anonimi; ma subito ho dovuto desistere perché il ministro aveva visto l’editore e lo chiamava («Carissimo!»). L’editore ha avuto un moto di sconforto, impercettibile e rapido come il clic di una macchina fotografica; ha alzato entrambe le mani, ha cinguettato: «Chi si vede!». Mi ha sussurrato: «Riparliamone. Vieni a trovarmi uno di questi giorni» e poi è andato incontro al suo ministro con un bellissimo sorriso stampato in volto. L’abbraccio è stato memorabile, per durata delle effusioni e intensità delle stesse («Caro Giovanni!», «Caro Giulio!»).
Io sono corso al tavolo dei tramezzini e approfittando del trambusto ne ho messi in tasca sei o sette. M’illudevo, all’epoca, di poter fare il mio romanzo con personaggi d’invenzione ma soprattutto con personaggi storici: ad esempio Vittorio Emanuele III di Savoia, re d’Italia per grazia di Dio eccetera, mi appariva un bellissimo personaggio, da romanzare in superficie ma da lasciare poi intatto nella sostanza: era lui l’inventore del fascismo, e non quell’altro, il pagliaccio che parlava all’Italia dal balcone. Vittorio Emanuele III era stato bistrattato dagli storici, accantonato dai sudditi, ricordato soltanto per gli aneddoti sulla modesta statura, per cui doveva farsi accorciare le sciabole e abbassare le panche dei giardini reali; ma io gli avrei restituito quel ruolo di protagonista che, d’altronde, fino al momento dell’abdicazione gli era appartenuto di diritto. L’avrei collocato al centro del romanzo. Un uomo saggio. Un gran re, che amò l’Italia quanto basta per sognare di liberarla dai mostriciattoli che la infestano, i cosiddetti italiani. (Già avevo letto i biografi: il Bolla, il Puntoni, lo Scaroni, il Bartoli, il D’Aroma, il Cesarini, il Mayda, il Consiglio eccetera. Avevo già acquisito, sul mio re, una documentazione imponente e completa). Sono scivolato di fianco dietro il deposito delle bibite. Mi sono messo nel cappotto una bottiglia di vermut in omaggio al tema del convegno (Letteratura e trasgressione) e poi ho allungato la mano verso una seconda bottiglia, credo di spumante; ma ho dovuto desistere perché uno degli organizzatori dall’altra parte della sala mi aveva visto, gridava: «Ehi tu. Cosa fai?». Sgomitando a tutta forza per raggiungermi tra la calca di “poeti organizzati” e di professori “rampanti”. «Dove credi di scappare? Vieni qua.» Insultandomi: «Ladro. Mascalzone». Sono sgusciato lungo il muro verso l’uscita della sala, ho imboccato lo scalone e via. Il mio convegno è finito così.
![]()
Brindisi, settembre 1943
Nella modesta e polverosa biblioteca dell’Ammiragliato di Brindisi il Re era andato a cercare qualcosa che gli servisse per alleviare la noia delle notti insonni e aveva scelto i tre libri che ora gli stavano davanti, due sul tavolo ed uno tra le mani. Una memoria di Francesco Pignatelli scritta per Carlo Filangieri e stampata in Napoli nel 1833, Sulla quistione se convenga stabilire razze regie di cavalli per uso dell’Esercito; un saggio del commendator Carlo Afan de Rivera Della restituzione del nostro sistema di misure, pesi e monete alla sua antica perfezione; e un volumetto senza frontespizio dell’Ecclesiaste («Ecclesiastes, qui ab Hebraeis Coheleth appellatur»), così, per darci un’occhiata. Ne era rimasto colpito come mai avrebbe creduto di poter essere colpito dalla lettura di un libro; e ancora lo sfogliava mentre aspettava la visita dei rappresentanti inglesi e americani, ne rileggeva una pagina:
Io, Cohelet...