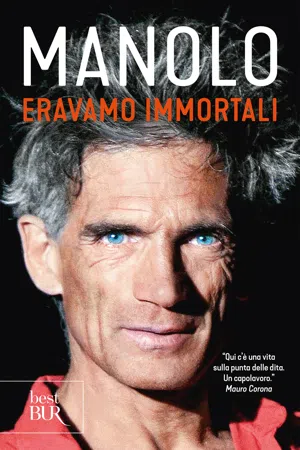![]()
1.
Novecento chilometri e venticinque metri
La prima volta che salii in quest’angolo selvatico, incuriosito da dove si andava ad assopire il sole, sfiorai i piedi di una parete troppo liscia e ancora troppo piccola per vederla. Ero stordito dal mondo fantastico che mi avvolgeva, avevo montagne immense negli occhi e ancora parecchi sogni nello zaino; non mi accorsi neanche che esisteva. Da lassù, guardando l’orizzonte, riuscivo a intravedere perfino il mare, che luccicava piatto come uno stagno; intorno, le montagne, le guglie e le nuvole si perdevano oltre l’immaginazione.
Per tornare a quel muro, notarlo e provare ad affrontarlo, ho dovuto prima misurarmi con quasi tutto ciò che vedevo davanti a me. Ma al primo tentativo di scalarlo, il tratto finale sembrò impossibile e mi fermai.
Solo vent’anni dopo scorsi una traccia in mezzo a quel terribile liscio, come se qualcuno avesse affondato le dita nella roccia lasciando un’impronta quasi umana, ma vecchia di milioni di anni. Il percorso per raggiungerla fu tortuoso e difficile, e una volta giunto in cima – tra momenti frustranti ed esaltanti – chiamai quella via Eternit.1
Sembrava il nome giusto per non dimenticare le insidie che possono nascondersi in ciò che è invisibile agli occhi. Quell’inclinazione, invitante ma subdola, celava qualcosa di molto pericoloso. Ti si attaccava alle dita, minava le convinzioni, ti portava via il fiato assieme alle certezze, come la polvere invisibile che usciva da tegole e rivestimenti, simile al veleno nelle parole di alcuni che non riuscivano a ripeterla.
Ciao, scusa se non ti ho fatto sapere prima quando vengo a provare di nuovo, ero superoccupato in questo periodo, ma venerdì sono libero. Sei a casa? C’è troppa neve per Eternit? Camminare non è un problema. Posso dormire da voi?
Adam
Nella flebile luce di un giorno appena nato, due tracce rigano il bianco del terreno come binari dritti e scuri; grossi cristalli di brina luccicano nel fascio dei fanali, frantumandosi in un caleidoscopio di colori. Alla fine, le ruote affondano soffici nel parcheggio deserto.
I cani travolgono la prima fredda neve d’inverno e noi prendiamo gli zaini per infilarci nel bosco, su una traccia appena battuta; solo in alto, dopo il torrente gelato, la abbandoniamo verso la radura in direzione del valico. Quassù la neve è pulita e più profonda di quanto mi aspettassi, il vento si è divertito a spazzarla dalle creste fin sul nostro percorso. I cani si mettono in fila e le parole si condensano nel respiro di una quiete assoluta, cercata.
Adam2 sembra un bambino, ma a soli vent’anni è già il più forte arrampicatore del mondo. Il suo viaggio è iniziato ieri mattina: dopo un esame all’Università di Brno è salito in macchina e ha guidato per quasi novecento chilometri. E ormai sono più di due ore che camminiamo in mezzo alla neve. Quando glielo faccio notare, lui mi sorprende esclamando con il suo italiano perfetto: «Per un tiro così, potrei farne anche cinquemila». Sorride, e quel sorriso lo puoi avere solo a vent’anni: brilla dell’energia della sua età e della passione folle e coraggiosa che lo sta portando a raggiungere i traguardi più lontani.
Sulla cresta siamo investiti dalla luce del sole e da una leggera brezza che sale accelerando per morire il più in alto possibile, in un cielo completamente azzurro. Sotto di noi vibrano gli aghi dei piccoli abeti aggrappati al ripidissimo versante, scossi da un’aria tiepida e asciutta. Siamo quasi a duemila metri. A sud, la traccia è ricoperta da un’erba lunga e piegata, ormai secca, di un delicato colore ramato. Sembra assurdo, ma fra tutte queste montagne stiamo cercando solo venticinque metri di pietra liscia e verticale, che non si fanno ancora vedere.
D’altra parte, entrambi siamo consapevoli che le scorciatoie finiscono quasi sempre per banalizzare il percorso. Siamo viaggiatori che inseguono i propri sogni, per quanto lontani o diversi fra loro; strade, partite da punti opposti, che convergono qui e ora per poi tornare a dividersi.
Io ho ripreso a scalare, ma un paio d’infortuni e diversi mesi di convalescenza sono bastati per non riacciuffare più la condizione che avevo raggiunto a fatica. Non riesco ad allenarmi. In ogni caso, doveva succedere prima o poi; ormai i miei tendini sono troppo logori e stanchi. Una parte di me tenta di convincerli a continuare, anche se loro gridano: «Basta!». E mentre un’altra parte ha voglia di ascoltarli, una terza ride in disparte. Ho letto che ritirarsi dal tumulto della vita non significa ritirarsi dal suo profumo, e credo sia la stessa cosa per l’arrampicata. Incomincio a capire: stavo guardando troppo avanti, rubandomi il presente.
Appartati dal rumore e dall’omologazione, questi luoghi modesti e immobili sono riusciti a portarmi lontano, tanto da annullare qualsiasi distanza, perfino il tempo. È stato un viaggio velocissimo, intenso e fantastico, a volte doloroso e fin troppo spesso spericolato, ma necessario. Intuisco solo ora quanto mi abbia arricchito.
Finalmente ci siamo: Adam, dopo aver provato i movimenti, sale preciso, essenziale, e in quel complicato rebus di appigli e appoggi non ha nessun tentennamento, nessuna indecisione. È solo al suo secondo tentativo e arriva quasi passeggiando agli ultimi metri di questa linea, che mi ha richiesto anni solo per concepirla. Riparte e si allunga come un albatros in quel suo modo impossibile. Gli manca un centimetro per arrivare all’impronta vecchia milioni di anni, da dove non cadrebbe più, ma il piede un attimo prima gli scivola ancora. Troppo tardi per riprovare: è freddo, la luce se ne sta andando, dobbiamo scendere.
Mentre camminiamo il mio sguardo corre in basso. Solo a fatica scorgo il filo argenteo e lontanissimo del torrente; si perde fra gli alberi, in fondo alla valle dove giocavo da bambino. Cerco d’intravedere almeno i prati dove sono nato e dove tutto è iniziato, quando un ragazzo, di fronte alla colonna sonora di una fabbrica, nella vita ha scelto quella libera del vento, chiedendosi però se era davvero ciò che voleva. Provo a capire qual è stato il momento in cui ho deciso di andarmene da dove mi sentivo fuori luogo; quando, mosso da una curiosità infinita, ho rincorso me stesso verso l’alto, oltre i boschi. Finché c’erano solo pietre appoggiate ad altre pietre, e in cima all’ultima il cielo. Lontano, le colline conosciute si appiattivano a confondersi con la pianura, e strade e campi diventavano solo geometrie disegnate a separare colori.
Mi capita, ogni tanto, di trovarmi a frugare fra cose ormai andate per sempre, tanto lontane da non riconoscerle più, magari trasformate dal mutare di sentimenti ed emozioni. Come le mete che ho raggiunto, assieme a quelle che avrei voluto raggiungere e non sono riuscito nemmeno a sfiorare, sogni che svaniscono all’alba solo in apparenza senza dolore. Bivi che hanno portato a prendere delle decisioni. Strade intraprese e pareti scalate; vie di cui non saprei dire qual è stata la più bella o la più importante. Tutto collegato da un unico filo, in un unico viaggio, assieme ai colori e alla luce che ho scorto nella profondità degli occhi di chi mi ha accompagnato, anche solo per un breve tratto.
Ho sempre odiato allenarmi… ma amavo migliorarmi. Così ho incominciato a scalare persino quando non ne avevo voglia e mi veniva da vomitare. Questo mi ha portato anche a sentirmi ridicolo, ma era necessario per continuare a contrastare la forza di gravità. È stato addirittura divertente impegnarmi là dove la genetica non mi aveva aiutato, tanto da credere che con talento, tenacia, lavoro e fortuna forse avrei raggiunto i miei obiettivi, imparando a trovare soluzioni e strade nuove. Ma appena sfiorate, quelle mete parevano perdere significato, al punto di augurarmi che continuassero a sfuggire.
Mi piace ancora arrampicare, specie in questi luoghi: mi fa star bene, e non so nemmeno io perché. Forse riesce davvero a fermare il tempo, a farmi sognare e a portarmi dove mi piace. Però non basta, ho bisogno di tante altre cose: di quotidianità, di condivisione, di partecipazione. Ho bisogno di continuare a cercare l’equilibrio che ho rincorso ambiziosamente per tanti anni, senza mai trovarne il fulcro. E ancora una volta mi sembra che l’importante sia poter mantenere una possibilità di scelta.
Al buio, entrambi persi nei propri pensieri, io e Adam inseguiamo a ritroso la traccia dei nostri passi, fino al piazzale. E mi ritrovo a frugare il più lontano possibile nella memoria.
![]()
2.
La farfalla di Natale
Non sono mai riuscito ad andare oltre: il frammento di ricordo più lontano è sotto il lavabo di quel bar. A lei è sempre sembrato impossibile, perché non avevo nemmeno due anni, ma i colori e i rumori che percepivo dietro la piccola tenda scura, dove mi rifugiavo mentre lavorava, sono impressi con precisione nella mia memoria, fin nei più piccoli dettagli.
Lei era la penultima di una famiglia numerosa, nati in diciassette e sopravvissuti in sedici. Difficile comprendere quel mondo, difficilissimo rammentarli tutti. Adalgisa, Albino, Ermenegildo, Romildo, Tarcisio, Imelda, Mafalda… Quanto a lei, non mi sono mai permesso di chiamarla con il suo vero nome, ma «mamma» devo averlo detto un milione di volte.
Non riesco a evocare nella memoria il suo viso di allora, così bello; è come se non l’avessi mai visto, e mi dispiace. In compenso, avrei riconosciuto ovunque la sua sagoma. La ricordo preparare, a merenda, fette di pane appena velate di marmellata, che divoravo con gusto. Un giorno, pensando di farmi un regalo, mi comprò un krapfen, ma non andò altrettanto bene. Non c’erano molti dolci per casa, e il pane con la zucca sembrava una leccornia.
Si spostava a piedi o in bicicletta, eppure non mi pare di averla mai vista pedalare. Portava sempre una collana di perle bianche, come se senza si sentisse spoglia, e indossava colorate gonne a pieghe. Aveva una gestualità leziosa, anche quando mi aspettava con un bastone. Le piacevano i fiori, e qualche volta un mazzo di ciclamini mi evitava il peggio.
Ricordo quando mi chiuse per la prima volta fuori casa, o quando – ormai deciso ad andarmene – tentò inutilmente di tenermi lì dentro. Non doveva essere facile avere a che fare con me. A poco più di un anno ero già ingestibile: mio padre provò a trattenermi con una rete molto alta, ma evasi quasi subito.
Ero insofferente, volevo sempre scappar via. Come quando, in castigo sul terrazzo di casa con un amico, sfilai la fune per la biancheria e con qualche bracciata mi ritrovai libero. Lui provò a seguirmi, ma capì troppo tardi di non riuscire a tenersi e mi rovinò addosso. Ho ancora davanti agli occhi i solchi bianchi scavati nelle sue mani. Guardandolo, mi sorprese il ritardo del sangue; non altrettanto le sue urla, che precedettero l’inevitabile e durissima punizione.
Poi ci trasferimmo in una casa popolare, che finalmente lei poteva definire «nostra», non senza un certo orgoglio. Nemmeno in quei giorni ho ricordo del suo volto.
Quel posto mi rattristava, avvertivo freddo perfino il pavimento di legno del soggiorno. Le abitazioni erano scatole tutte uguali, con pareti sottili e attaccate una all’altra. Non mi piacevano. Né mi piaceva il quartiere: mi sembrava isolato, ai margini, e credo sia rimasto così. Un mondo fatto di «Chissà cosa ne pensa la gente», che si ravvivò solo il giorno in cui alcuni camion riversarono del terriccio scuro sugli spazi riservati agli orti, e tutti vi seminarono un po’ di vita per cambiare quella che scorreva triste tra le mura domestiche, quasi senza sorrisi.
Una terra povera per i poveri, che provava ad abbellirsi a primavera con l’amore per i gerani alle finestre. Storie adulte e senza scampo, fatte di canottiere bianche, litigi, ubriachezza e sguardi silenziosi fra rampe di scale che separavano come frontiere. Non vedevo l’ora di andarmene. E da lì se ne sono andati quasi tutti, compresi i colori, che hanno avuto la vita effimera di farfalle; ora non rimane che qualche misero albero e un po’ di erba, come se ormai la vita crescesse solo nei supermercati. Eppure, nonostante il mio disagio, è stato il momento che l’ho avvertita più felice.
È sempre stata molto religiosa, ma non è riuscita a contagiarmi nemmeno in quello. Si arrabbiò molto quando mi rifiutai di proseguire le lezioni di catechismo, ma non le ho mai parlato del viscido tentativo del frate, quel primo giorno. Non riuscì nemmeno a farmi fotografare sul terrazzo con la tunica bianca della prima comunione. Mi dispiace, perché ricordo ancora la luce accesa di notte, mentre la tagliava e ricuciva. Era brava in queste cose, e credo provasse anche a guadagnarci qualche soldo. Mi chiedeva spesso di infilarle il filo nell’ago, poi qualcuno le regalò un piccolo aggeggio di plastica che mi sostituì.
Si vergognava del nostro vivere povero, e si arrabbiò molto quando lo dissi durante una conferenza. Credo avesse ragione: forse tutti quei sacrifici meritavano il rispetto del silenzio. Da ragazza era stata costretta a emigrare, e che io sappia non è mai andata in vacanza, né al mare né in montagna. Nemmeno con mio padre andarono mai da qualche parte, almeno finché lui non raggiunse la pensione, per poi morire quasi subito.
In casa nostra i quotidiani entravano solo per accendere il fuoco, o in caso di notizie «vicine» come una morte o una qualche stupidaggine distorta. Però ricordo «Famiglia Cristiana» sul tavolo; cambiavano le figure, ma quella rivista colorata sembrava sempre la stessa. I libri erano ben pochi; il primo che mi regalò fu I figli del capitano Grant. Un giorno si tentò l’avventura dell’enciclopedia a rate, della quale però non ho mai visto la fine: ero già andato via.
In compenso giocavo all’aperto, e scavando in giardino scoprivo casse di munizioni o altri residuati della guerra. Ogni tanto per le strade passava ancora qualche convoglio di soldati americani, come fosse una processione, e noi bambini si correva tutti in strada a salutarli nella speranza che ci lanciassero delle caramelle. Era la prima volta che mi trovavo di fronte a delle persone di colore.
Gli unici sportivi che avessero un nome tra le pareti di casa erano Coppi, Bartali e Cassius Clay. Non ricordo la radio, e almeno all’inizio la televisione non c’era. Arrivò, in bianco e nero, solo per la morte di Kennedy, e quando fiorirono le primule ci portò anche la Milano-Sanremo, con Motta, Gimondi e Merckx. Alla fine rimase solo Merckx, Ma mia madre continuò a tifare per Motta.
Ricordo che d’inverno, per scaldarsi, si metteva in fondo al letto una strana impalcatura di legno: sollevava le coperte e ospitava una pentola piena di brace. Quando compariva, sapevo che era ora di andare in camera mia.
La pioggia rimbalza rabbiosa sul parabrezza dell’auto, e sembra rendere inutile il movimento frenetico dei tergicristalli. Mi fermo nel piazzale e aspetto finché non smette. Quando apro la porta le ultime gocce scivolano quiete a raggiungere le altre già sull’asfalto; se ne andranno insieme, come una cosa sola.
Sempre più spesso, i primi passi per scendere dall’auto sono dolorosi; così dolorosi che a volte non riesco a proseguire. Rallento a controllare le fitte, per dignità o per quel pudore intrinseco nell’educazione che lei mi ha trasmesso. Quasi che dolore e malattia debbano sempre essere nascosti. Non posso più correre, ma in compenso sono diventato un asso a raccogliere gli oggetti con i piedi. A volte non riesco nemmeno a spalare la neve, eppure mi piace prepararmi la legna o pulire il prato: lavori che mi gratificano, ma diventati pesantissimi e a volte impossibili. Ogni tanto mi chiedo come possa ancora scalare; le spalle sono entrambe lesionate, consumate come i gomiti, per non parlare delle mani, delle dita… Questa mattina ho anche provato ad allenarmi: mi sono sentito ridicolo. Non riesco ad alzarmi nemmeno dove qualche anno fa mi riscaldavo.
Passo davanti alla portineria con il solito attimo di esitazione; mi sento osservato, controllato. Chi mi viene incontro sembra avere addosso solo la voglia di andarsene. Non prendo l’ascensore, preferisco le scale, forse per reagire o solo per abitudine. Sulle rampe non incontro quasi mai nessuno, i gradini paiono limit...