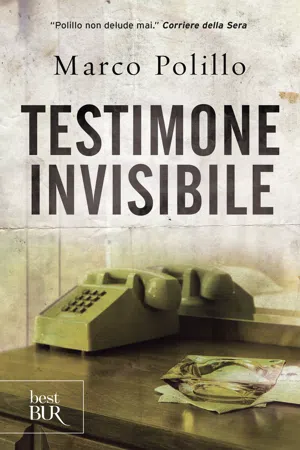![]()
Mercoledì, 14 febbraio
Era cominciata male quella giornata. Già il tempo, freddo e piovoso, non prometteva niente di buono. Poi la moglie, chissà perché, si era svegliata in preda a una delle sue solite crisi. Capitava, ogni tanto: qualcosa non andava, magari qualcosa di assolutamente stupido e lei entrava in una specie di sciopero cerebrale. Non parlava, faceva solo il minimo indispensabile (e la colazione del marito non rientrava nel concetto di minimo indispensabile) e si comportava come se al mondo ci fosse solamente lei. Tutti gli altri, il marito, i figli, i vicini, la madre, chiunque capitasse in casa, non esistevano.
Le prime volte, proprio all’inizio del loro matrimonio, queste improvvise e imprevedibili crisi avevano lasciato i giovani coniugi Zottìa in uno stato di grande apprensione; preoccupati, avevano cercato di trovare una spiegazione a quello strano comportamento, avevano consultato anche un paio di specialisti, ma tutto era risultato inutile. Passata la crisi, che durava di solito due o tre giorni, la signora Zottìa tornava a essere perfettamente normale. Alle domande su cosa avesse avuto, su cosa fosse successo, sul perché si fosse comportata in quel modo, non rispondeva mai. Faceva un enigmatico sorrisino e cambiava discorso.
Col passar degli anni la situazione non era cambiata. Forse le crisi erano leggermente diminuite, ma in compenso era peggiorata quell’incredibile ansia che sempre più spesso attanagliava la moglie e la induceva a riversare sul marito fiumi e fiumi di parole, valanghe di preoccupazioni per dei problemi che, a ben vedere, non potevano certo essere considerati vitali. Più volte il vicecommissario si era domandato, se avesse potuto scegliere, con quale dei due mali avrebbe preferito convivere. Ci aveva pensato molto, ma alla fine non era riuscito a darsi una risposta.
Quel giorno dunque, mercoledì 14 febbraio, la signora Zottìa era entrata in catalessi – come avrebbe detto il maresciallo Sanfilippo – ed Enea Zottìa, vista la mala parata, si era lavato e vestito in gran fretta, aveva rovesciato qualcosa da mangiare nella ciotola del gatto ed era uscito di casa appena pronto, poco dopo le sette e mezza. Digiuno, infagottato nel suo cappotto, sferzato dal vento gelido («Polare», aveva detto la sera prima alla televisione quello delle previsioni del tempo), si era incamminato a passo rapido verso via Fatebenefratelli.
Che disastro quell’ultima settimana, pensò mentre grosse gocce di pioggia incominciavano a cadere picchiettando la stoffa tesa del suo ombrello. E che disastro la sua vita! Un tuono brontolò, cupo, nel cielo e la pioggia, come obbedendo a un comando, aumentò d’intensità. Zottìa rallentò, indeciso, all’altezza di un bar che si affacciava sul marciapiede dall’altra parte della strada. Rabbrividì. Aveva freddo e fame: un bel cappuccino bollente e una brioche appena sfornata sarebbero stati proprio quello che ci voleva. Attraversò la strada e scomparve all’interno del bar.
L’Alfa della polizia lo aveva incrociato mentre, al volante della sua auto, stava percorrendo corso Lodi diretto verso la periferia. Era notte fonda e solo qualche macchina sfrecciava veloce lungo le strade deserte della città.
Con la coda dell’occhio seguì le manovre dell’Alfa. La vide proseguire per qualche secondo nella direzione originaria poi fare di colpo un’inversione a “U” e mettersi nel suo stesso senso di marcia. Continuando a controllarne i movimenti nello specchietto retrovisore, accelerò leggermente. Dietro di lui la macchina della polizia aumentò anch’essa l’andatura. Incominciò a sudare, un sudore freddo, gelato, che gl’inumidiva la fronte, la schiena, le mani. Mi hanno preso, pensò, e automaticamente iniziò a valutare tutte le possibili vie di fuga. Alle sue spalle chi lo seguiva mise in funzione la luce blu di segnalazione sul tetto e iniziò la manovra di sorpasso. Schiacciò di colpo fino in fondo l’acceleratore: l’auto scattò improvvisa in avanti e dopo pochi metri, con un grande stridio di gomme, s’infilò in una stretta viuzza sulla destra. Dritto per cento metri, poi a sinistra in un budello scuro, poi ancora a sinistra, sfiorando una lunga fila di auto posteggiate accanto al marciapiede. Dietro, intanto, la luce bluastra col suo continuo girare disegnava strani giochi d’ombre sui muri.
Cento, centodieci, centoventi. L’ago del tachimetro si spostava sempre più avanti, ma il distacco da quella luce blu non aumentava. Un semaforo, in fondo alla strada, da verde divenne giallo e poi rosso. Non c’era tempo per fermarsi: le mani aggrappate al volante, il clacson premuto con forza, l’uomo alla guida dell’auto attraversò sfrecciando l’incrocio. Una trentina di metri più indietro l’Alfa sembrò avere una leggera esitazione. Fu una cosa breve, solo un attimo, ma fu sufficiente per far guadagnare al fuggitivo un’altra ventina di metri preziosi.
Quel dannato faro bluastro non era più così vicino, adesso. Bisognava approfittare dell’occasione per staccarlo definitivamente. A sinistra, subito, sfiorando un cancello, poi ancora a destra, e a destra ancora. Adesso dritto, e poi giù a sinistra senza mai staccare il piede dal pedale dell’acceleratore. Ancora dritto lungo quel vialone, l’occhio incollato allo specchietto retrovisore, la speranza chiusa in gola. Cento metri di strada, centocinquanta, forse duecento e alle spalle nessuna luce blu. Ecco una piazza, là avanti, e dietro ancora nessuno. Rilassati ora, rallenta, forse ce l’hai fatta. Prendi un’andatura normale, ma esci dalla città, vattene il più lontano possibile. Respira piano, asciugati il sudore, cerca di stare tranquillo, fra pochi minuti potrai anche accenderti una sigaretta.
Ottanta, settanta, sessanta all’ora, la lancetta del tachimetro scendeva. Ecco, così va bene, accodati a quelle due auto davanti, cerca di passare inosservato, non fare manovre brusche. Attento, davanti stanno frenando, frena anche tu. Cos’è quel rumore? Quel fischio lontano? Quella sirena? Quei fari?… La polizia! Arrivano! Di nuovo! Schiaccia quel pedale, corri, scappa da quella maledetta luce blu. A destra, poi a sinistra, adesso dritto e poi ancora a destra… Stringi, stringi lontano da quel muro! Di più! Di più!! Il muro!!!
Sentì il motore salire di giri e la macchina farsi leggera. Vide il muro fermo, immobile, che lo aspettava attirandolo piano, dolcemente, contro di sé. Vide la portiera di sinistra rientrare a poco a poco nell’abitacolo e il cristallo del finestrino tramutarsi in un’enorme ragnatela. Sentì il sedile mancargli di sotto e una forza, terribile e invisibile, spingerlo in avanti.
Poi si svegliò.
Si trovò al buio, fradicio di sudore, il cuore che gli martellava nel petto. Cercò a tentoni l’interruttore della luce del comodino. Guardò l’ora, le sette meno dieci. Ci mise qualche minuto per riprendersi dal terrore nel quale quell’incubo lo aveva sprofondato. Poi si alzò.
Una notte senza incubi, ma altrettanto agitata, l’aveva passata nel suo letto anche il commissario Francisci. Dopo l’incredibile discorso fattogli la sera precedente da Giuffredi era stato colto da un momento di profondo sconforto. Poi si era accorto che Giuffredi lo stava guardando in modo strano. Tirando lunghe boccate di fumo dalla sua sigaretta, lo stava valutando senza dire una parola. Glielo si leggeva negli occhi il dubbio. Il dubbio che, dopo tutto, quel mentecatto sprofondato in un letto d’ospedale avesse detto la verità e cioè che lui, Antonio Francisci, fosse veramente la persona che aveva cercato di ucciderlo. E poiché il commissario tutto poteva sopportare, ma non il sospetto negli occhi dei colleghi, aveva reagito.
«Okay» aveva sospirato. «Domani ci sciropperemo anche questa bella novità», e si era accordato con il collega per il confronto con il suo accusatore.
Sembrava calmo quando era tornato a casa, quella sera. Sembrava calmo, ma a Caterina, la moglie, era bastata un’occhiata per capire che quella notte lei, che aveva il sonno leggero, si sarebbe dovuta svegliare più volte, disturbata dai continui movimenti del marito nel letto.
E si era girato, infatti, si era girato e rigirato. Si era addormentato e risvegliato in continuazione. Aveva tolto una coperta di lana perché aveva caldo, poi se l’era rimessa perché aveva freddo. Aveva bevuto un succo di frutta verso le due e, verso le quattro, un bicchiere di latte gelato che gli era rimasto sullo stomaco.
Finalmente era arrivato il mattino, e con il mattino era arrivata anche un po’ di pace. Mentre si radeva elaborò un programma per la giornata. Aveva dormito sì o no quattro ore in tutto, eppure non si sentiva affatto stanco. Guardò fuori dalla finestra mentre, in cucina, sorseggiava lentamente una robusta tazza di caffè nero. Deve fare un gran freddo, pensò.
All’Hotel Duomo, l’avvocato Günther Oberhöllenz aveva invece passato una magnifica notte. Era arrivato a Milano la sera precedente con il volo Swissair SR 628 che, partito da Zurigo alle 19,10, era atterrato all’aeroporto di Linate qualche minuto prima delle otto, in leggero anticipo sull’orario previsto. Con una rapida corsa in taxi aveva raggiunto l’albergo dove aveva occupato la camera che già da qualche giorno era prenotata a suo nome. Aveva telefonato alla moglie, poi era sceso al bar dell’hotel dove, dopo una sbrigativa cena a base di tramezzini, si era fermato a bere un whisky, a leggere un giornale e a osservare la gente che andava e veniva.
Un paio d’ore più tardi, intorno alle undici e mezza, si era ritirato a malincuore nella sua camera, disponendosi a prendere sonno. Per la verità quando mancavano pochi minuti alle undici aveva timidamente messo il naso fuori dalla porta, ma il freddo pungente lo aveva rapidamente dissuaso dai quattro passi che aveva pensato di fare. Era a letto da pochi minuti e già si era profondamente addormentato; da quel corroborante sonno sarebbe riemerso solo alle sette e mezza del mattino seguente, svegliato dall’arrivo di un impettito cameriere che portava la colazione.
A piedi nudi Oberhöllenz si diresse verso il tavolino dove era stato appoggiato il vassoio. L’appuntamento nello studio dell’avvocato Castelli era fissato per le nove e mezza: fece un rapido calcolo e considerò con soddisfazione che aveva tutto il tempo per rifocillarsi a dovere. Si sedette sulla poltrona di fronte al tavolino, osservò con aria critica la marca dei vasetti della marmellata e l’etichetta del tè che spuntava dalla teiera poi, sbadigliando senza alcun ritegno, iniziò a versare il liquido nella tazza.
Quando era entrato nell’ufficio di Zottìa, questi aveva alzato la testa dal giornale e gli aveva bofonchiato un buongiorno tipico delle giornate iniziate per il verso sbagliato. Ma ci voleva ben altro per scoraggiare Francisci. Senza minimamente impressionarsi del fatto che l’altro aveva ripreso a leggere, aveva girato la sedia di fronte alla scrivania, si era seduto a cavalcioni e aveva appoggiato una mano sul giornale costringendo Zottìa ad alzare lo sguardo. «Stammi a sentire, Baffo», gli aveva detto, e gli aveva raccontato da cima a fondo la conversazione della sera prima con Giuffredi. Terminato il racconto aveva continuato a parlare spiegando al suo vice che cosa aveva intenzione di fare e come pensava di muoversi quella mattina.
«Obiezioni?» aveva domandato alla fine.
«Nessuna», gli aveva risposto Zottìa dopo una breve riflessione.
«E allora forza, cominciamo.»
C’era aria di efficienza, di tranquilla sicurezza, quasi di ottimismo nel palazzo di via Fatebenefratelli, quella mattina. E quell’aria sembrava aver contagiato anche gli uomini di Francisci. Chissà mai che dopo giorni e giorni di dure sconfitte, quel gelido mercoledì non portasse una volta tanto dei risultati.
Un primo successo era stato ottenuto quasi subito: il dottor Voretti, chiamato telefonicamente a casa, era rientrato dal suo viaggio. Sì, l’infermiera gli aveva detto che lo avevano cercato; qual era il problema? Certo che ricordava il colloquio di quella sera. Sicuro che lo confermava e rammentava perfettamente anche chi lo aveva fatto, un certo dottor Guidi, Angelo Guidi, un collega che lavorava all’ospedale San Giuseppe. Il numero di telefono di casa quello no, non l’aveva, ma il commissario poteva provare a chiamarlo in ospedale. A quell’ora non doveva essere difficile riuscire a rintracciarlo.
In realtà trovare Angelo Guidi non fu così facile come Voretti aveva pensato. Solo dopo un’ora e un quarto, e presentandosi di persona all’ospedale, Francisci e Zottìa riuscirono a bloccare l’oggetto delle loro attenzioni. Ma se speravano di sbrigarsela con poche parole rimasero delusi. Il dottor Guidi non aveva alcuna intenzione di raccontare ai primi venuti dei fatti che riguardavano soltanto lui e i suoi familiari. Che i primi venuti fossero in realtà un commissario e un vicecommissario di polizia era sicuramente un argomento che non poteva non essere preso in considerazione, ma quanto meno sarebbe stato corretto che il commissario (o il suo vice, era lo stesso) informassero un onesto cittadino del perché di tutto quell’interesse intorno alla sua persona.
«Non le pare, commissario?» aveva chiesto.
«Mi pare, mi pare», aveva risposto Francisci a denti stretti. Poi l’irritazione aveva preso il sopravvento e lanciando un’occhiataccia al medico aveva aggiunto un minaccioso: «Guardi, però, che se continua a non collaborare la faccio portate in Questura, e poi vediamo come va a finire».
E così, di spiegazione in spiegazione, ne erano trascorsi di minuti e solo dopo che le undici erano passate da un pezzo, dal telefono installato sull’automobile che li stava riportando in Questura, Francisci e Zottìa avevano saputo, finalmente, il nome. Il nome di chi possedeva un duplex collegato con la linea di Giancarlo Guidi, il fratello di Angelo. Di chi, se la ricostruzione di Zottìa era corretta, nella notte del 6 febbraio aveva parlato con l’avvocato Stari pochi istanti prima che questi venisse ucciso. Della persona che, da giorni, la polizia stava vanamente cercando di rintracciare: il telefonista misterioso. Quello stesso nome che, dopo un’affannosa indagine presso la TELECOM, un centralinista di via Fatebenefratelli aveva appena finito di sillabare in un gracchiante microfono: Amilcare De Norri.
Il palazzo era decisamente signorile. Anche lo studio non era affatto male. Günther Oberhöllenz si guardò intorno compiaciuto, apprezzando in modo particolare le stampe acquerellate che ornavano le pareti tinteggiate di un caldo color nocciola, e si sistemò più comodamente nella poltrona di velluto della sala d’aspetto. Era molto piacevole avere rapporti d’affari con persone che godevano di una certa agiatezza; l’esperienza passata glielo aveva insegnato e ricordava ancora con raccapriccio quella volta che, per colpa di un’inopinata omonimia, si era affidato a un corrispondente ben diverso da quello che aveva pensato. Scosse la testa come per scacciare quell’infausto pensiero dalla mente e diede un’occhiata all’orologio. Ormai potrebbe anche ricevermi, si disse, e proprio in quel momento la porta si aprì e un uomo sorridente e dall’aria simpatica avanzò nella sua direzione tendendogli la mano.
Oberhöllenz e Castelli non faticarono molto a intendersi. Entrambi convennero che era più opportuno dedicare la mattina alla messa a punto degli atti e dei dettagli tecnici, lasciando al pomeriggio lo scambio delle firme tra il vecchio e il nuovo proprietario.
«Un caffè?» propose Enrico dopo che si furono seduti intorno al tavolo da riunione.
«Volentieri», acconsentì Günther soddisfatto.
Uno sguardo d’intesa con la segretaria fu sufficiente, dopo di che la porta della stanza si chiuse senza far rumore mentre i due uomini, chini sul primo di numerosi fogli, stavano già discutendo uno dei tanti delicati aspetti della questione.
Seduto dietro la scrivania dell’ufficio che divideva con l’appuntato Stefanoni, il maresciallo Sanfilippo stava fissando con aperta curiosità la ragazza che gli stava compostamente seduta di fronte. Luisa Sandri, aveva detto di chiamarsi, ed era, lo ricordava perfettamente, la segretaria dell’avvocato Stari.
«Non male, un bel paio di tette», aveva commentato qualche giorno prima Bortolozzi. «Peccato che non capisca niente.»
Un giudizio così lapida...