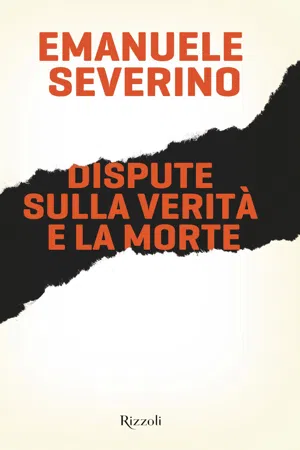![]()
Parte ottava*
* Il primo scritto del primo capitolo di questa Parte ottava è apparso su «la Lettura» del «Corriere della Sera» il 27 aprile 2014; il secondo è stato pubblicato sul numero de «Il Pensiero»; il terzo è apparso sul numero 1 di «Humanitas» (2017). I restanti scritti di questa Parte sono stati pubblicati su «La filosofia futura», a eccezione di quello dedicato a Vincenzo Vitiello, pubblicato su «Archivio di Filosofia».
![]()
1
L’Uno e il «labirinto»
1
Ancora oggi, come sempre, le religioni stanno al centro della storia. Sia pure in modi tra loro conflittuali, aiutano i popoli a risolvere le forme più profonde delle loro inquietudini. Parlano un linguaggio che si fa capire. Dicono quel che l’uomo vuol sentirsi dire. Inevitabile quindi che venga il tempo in cui egli voglia sapere anche perché le cose debbano stare come egli vuole che stiano. Il tempo della filosofia. Vi si rimane anche quando si dice che la filosofia è morta e che le cose stanno come è stabilito dalla scienza moderna. Le cose! Conosciamo il significato della parola «cosa»? È proprio così ovvio? O non dovrebbe essere il primo a venir messo in luce? Iniziando il proprio cammino, proprio questo si domanda la filosofia. Essa chiama «essente» (ón, «ente») la cosa. L’intero sviluppo storico della filosofia riguarda il modo in cui essa pensa l’essente. Ma ovunque si guardi – in terra o in cielo, nella veglia o nei sogni, nella vita quotidiana e in ogni attività pratica, nella scienza, nell’arte, nella normalità psichica o nella pazzia – ci si imbatte in cose, essenti, in «qualcosa che è». Il modo in cui la filosofia ha inteso la «cosa» e l’«essente» è il terreno in cui cresce la storia dell’Occidente. L’Europa non è più il centro del mondo, ma il mondo è ormai dominato dal modo in cui l’Europa – cioè la filosofia – ha pensato l’essente.
Credo che questo discorso possa venir condiviso anche da Massimo Cacciari, che pubblica un altro splendido libro: sul modo, appunto, in cui lungo la propria storia la filosofia ha inteso l’essente. Si intitola Labirinto filosofico (Adelphi 2014). Pagine che hanno alle spalle l’intera opera di Cacciari. Impossibile, qui, indicare sia pur da lontano la loro altezza e ricchezza. Mi limiterò a ciò che in esse riguarda più da vicino i miei scritti – chiedendo scusa al lettore se, data l’intensità della scrittura di Cacciari, dovrò un po’ addentrarmi nella specificità del discorso filosofico. Un peccato fare altrimenti.
Pensare l’essente, esse dicono, è trovarsi in un «labirinto». Ma in maniera del tutto singolare. Non ha nulla a che vedere con il luogo in cui ci si perde senza poter trovare l’uscita. Nel labirinto filosofico, «lungi dal chiudersi in sé, ogni passo è mosso dall’istanza di venire “superato”, proprio perché è cosciente di essere congettura, in dialogo non solo con quelle precedenti e prossime, ma con quelle stesse avvenire».
Questo «superamento», mi sembra, non vuol essere la negazione di tutto ciò che nei «passi» del labirinto si pensa. Comunque, Cacciari non intende certo affermare che l’esistenza del labirinto sia una «congettura». Egli si basa cioè sulla non-congettura. Siamo di fronte al tema di tutti i temi: il tema decisivo della non-congettura, cioè della verità incontrovertibile.
Dopo aver esposto il senso complessivo di un’ampia arcata dei miei scritti, Cacciari dice di essi: «Questa linea – da Oltre il linguaggio (Adelphi 1992) a Oltrepassare (Adelphi 2007) non mi pare in contrasto con il cammino che qui si svolge» (p. 48), cioè con il suo cammino. Infatti, aggiunge, in essi si afferma che «il Cielo della verità degli essenti non si manifesta mai nella finitezza dell’apparire: vi si ri-vela soltanto» (p. 47). Il «velare» è cioè indissolubilmente unito al «rivelare». Una sequenza, questa del ri-velare, che è presente nei miei scritti da quasi cinquant’anni. Ma in essi la «finitezza dell’apparire» è la struttura originaria della verità, l’incontrovertibile, la non-congettura originaria. Nemmeno ora Cacciari la mette in questione. Scrive anzi che «qui il discorso severiniano perviene alla sua massima energia» (p. 50). Ora, soltanto la struttura originaria della verità può fondare quella sequenza del ri-velare. E può fondarla (qui debbo rinviare alle mie pagine) perché tale struttura implica con necessità che ogni essente (ogni cosa) è eterno. Ogni essente, non soltanto un Dio. Nessun essente oscilla tra il nulla da dove verrebbe e il nulla in cui andrebbe. (Queste affermazioni non vanno contro le abitudini concettuali incommensurabilmente di più di quanto vi andasse nel XVI secolo l’affermazione che è la Terra a girare attorno al Sole? Sì. Ma se stiamo alla semplice tesi dell’eternità di ogni essente – e alla semplice tesi se ne sta chi se ne scandalizza –, allora la teoria della relatività non è poi così lontana da questa tesi – lontanissima peraltro, tale teoria, per quanto riguarda il modo in cui la tesi è fondata.)
Dunque (ritornando a quella che prima abbiamo chiamato «sequenza del ri-velare): poiché è necessario che ogni essente sia eterno, il significato dell’eternità di ogni essente, e quindi il significato di ogni essente, si ri-vela lungo un cammino che non ha mai compimento. Di qui il nostro esser destinati a «vedere sempre di più», e sempre più nella Gioia, dopo la morte. Il significato di ogni essente è inesauribile. Nel Cielo della verità resta cioè uno spazio infinito che non potrà mai essere detto, veduto, sperimentato da parte del finito (ma che è il fondamento della nostra destinazione alla Gioia). Questa, la sequenza del ri-velare con cui Cacciari non si trova in contrasto.
Ma c’è anche quest’altra conseguenza: che tutto ciò che va mostrandosi lungo il cammino mai compiuto e tutto ciò che resta per sempre nascosto in quello spazio infinito è un essente eterno – appunto perché la struttura originaria della verità mostra la necessità che ogni essente sia eterno; e tale struttura (si mostra nei miei scritti) è il fondamento in base al quale si può affermare l’esistenza di quel cammino mai compiuto e di quello spazio infinito. Se si voltano le spalle a questo quadro (e soprattutto a quella fondazione che qui resta semplicemente enunciata), l’esistenza di tale cammino e di tale spazio rimane una «congettura» smentibile (cioè dogma, postulato, aspirazione, fede), un presupposto arbitrario. È per esempio il presupposto di Husserl, per il quale non c’è bisogno di fondare l’affermazione che le cose «evidenti» posseggono un significato implicito che va mostrandosi lungo un processo senza termine. È il presupposto di Heidegger, che facendo leva sul concetto greco di verità come alétheia – che alla lettera significa «non (a) nascondimento (léthe) – ritiene a sua volta di poter affermare una dimensione nascosta che infinitamente si allontana nel processo stesso in cui a essa ci si avvicina.
E per Cacciari? Per lui il cammino mai compiuto è la produzione degli enti, ma l’indicibile spazio infinito verso cui il cammino si dirige è il «Possibile», inteso come «potenza» che «fa essere ciò che è», ossia cose ed enti, loro «fondamento», che però non è cosa o ente (pp. 301-304). La derivazione dal neoplatonismo e da Schelling sembra chiara, anche se Cacciari preferisce elaborare e condividere una derivazione kantiana. Non sembra tuttavia che per lui il «Possibile», che è «fondamento» e «potenza», sia un nulla assolutamente nullo. Ma allora – chiedo – perché negare che sia essente? Perché ridurre il significato di «essente» a ciò che si mostra, per poi poter dire che al di là dell’essente c’è la Possibilità che lo fa essere? Anni fa, parlando con Gadamer, gli facevo la stessa domanda, questa volta a proposito della decisione di Heidegger di restringere (arbitrariamente) la dimensione dell’ente per poter poi affermare che al di là di essa si apre quella dell’«Essere» (che certo non è per Heidegger un nulla assolutamente nullo).
D’altra parte Cacciari aveva scritto che gli enti che appaiono nel manifestarsi del «Possibile» «non vengono affatto lasciati “oscillare” tra nulla e nulla», non sono «mera contingenza» (Della cosa ultima, Adelphi 2004, p. 86). Ciò significa che, per lui, il «Possibile», di cui gli enti sono la manifestazione, è la condizione della loro eternità, l’«Inizio» che la custodisce – e Cacciari intende salvaguardarla. Ma come può il «Possibile» custodire l’eternità di ciò che è (degli enti), se esso è la «potenza» che «fa essere ciò che è»? L’eterno è eterno proprio perché non è fatto essere. Tuttavia, dicevamo, l’eternità di ogni essente è necessariamente implicata da ciò che non può essere negato, la struttura originaria; ed è impossibile che sul fondamento di essa si pervenga alla negazione di ciò che essa implica e quindi alla negazione di essa. È cioè impossibile che si pervenga a qualcosa – il «Possibile» – che non è un nulla e che tuttavia ha la pretesa di non essere un ente e di stare al di sopra della totalità degli enti. E, si è visto, Cacciari non sembra negare né la struttura originaria, né l’eternità di ogni ente. (Tale struttura non è cioè un insieme di postulati dai quali sia possibile dedurre, come nei sistemi ipotetico-deduttivi, un teorema che li contraddica – come Gödel ha appunto mostrato per la matematica.)
Ancora. Tutto è eterno. Quindi anche gli erranti e l’errore, inteso come il loro errare. Ciò che la Follia pensa – cioè che gli essenti vengono dal loro nulla e vi ritornano – è nulla, ma la Follia non è un nulla, è un essente; e quanto ampio è il suo regno! Da quando appare sulla terra, l’uomo è dominato e abbagliato dalla Follia. Più profonda di ogni «peccato originale», è la radice di ogni dolore e di ogni angoscia. Nella sua essenza più profonda l’uomo è il contrasto tra l’eterno in cui consiste la verità e l’eterno in cui consiste la Follia. Ma, e ancora sul fondamento della struttura originaria della verità, è necessario affermare che la Follia è destinata al tramonto. Cacciari scrive: «Se l’errore stesso è un eterno, come dice appunto Severino, che valore è possibile dare a espressioni che ne indicano il tramonto e il compimento?» (Labirinto filosofico, cit., p. 49). Accenno alla risposta.
L’infinito cammino del ri-velarsi degli essenti passa attraverso il tramonto e il compimento della Follia. Questo non significa che la Follia vada nel nulla, ma che tutti gli eterni che la compongono si sono ormai manifestati, e quindi essa è compiuta, è un perfectum. Dopo la morte la sua ampiezza abbagliante rimane un punto rispetto all’infinità mai compiuta del cammino in cui la manifestazione del finito si fa sempre più concreta. Per questo a tale cammino si addice esser chiamato Gloria. In qualche modo, nella nebbia, il cristianesimo lo intuisce. Cristo siede, nella «Gloria», alla destra del Padre. Ma non può aver dimenticato la propria sofferenza, dovuta ai peccati, cioè alla follia, dell’uomo. La ricorda forse da lontano, così come noi ricordiamo il passato? Nemmeno: sarebbe un modo di averla dimenticata. Allora l’ha completamente vicina a sé: nella somma felicità della «Gloria» continua a sperimentarla; ed è proprio quella sofferenza, in tutti i suoi aspetti. Non una briciola di essa va perduta, diventando un nulla. È eterna. Ma essa è una briciola in confronto all’infinita felicità della «Gloria». Al di là del racconto cristiano, si tratta di pensare tutto questo.
2*
a) In relazione al clima concettuale oggi esistente può essere opportuno osservare innanzitutto che il discorso filosofico di Massimo Cacciari non propone tematiche che siano o magari intendano essere contenuti contraddittori. Per esempio esclude i modi che concepiscono impropriamente l’Uno neoplatonico – al quale, peraltro, tale discorso si sente essenzialmente vicino – perché «precipitano in un’evidente contraddizione» (Labirinto filosofico, cit., p. 272); oppure esclude ogni affermazione riconducibile allo «scetticismo assoluto» perché essa è a sua volta un’«affermazione in sé autocontraddittoria» (ivi, pp. 331-332). Ma poi, tale discorso propone ogni suo enunciato come un asserto che esclude la propria negazione: non intende essere una contraddizione.
D’altra parte, perché il pensiero e il linguaggio «devono» evitare la contraddizione? Anche a questa domanda si possono e si debbono rivolgere molte domande; però, intanto, come si risponde a questa? Giacché, in quanto semplicemente asserito, il «principio di non contraddizione» è un dogma arbitrario. Come risponde a quella domanda la filosofia di Cacciari? La quale peraltro, come esclude la contraddizione, così esclude che si possa negare l’esistenza di ciò che appare – l’esistenza del «fenomeno». E allora, anche qui, perché «si deve» negare la negazione dell’esistenza di ciò che appare? E come si risponde? Giacché, anche qui, il «principio di tutti i principi» della fenomenologia, in quanto semplicemente asserito, è a sua volta un dogma arbitrario.
Nonostante la grandezza delle tematiche aristoteliche relative all’élenchos della negazione del principium firmissimum, lungo la storia dell’Occidente sia il «principio di non contraddizione» sia il principio della fenomenologia, che si esprime nel sózein tà phainómena, non sono che volontà di salvare, appunto, qualcosa, cioè qualcosa di preliminarmente voluto. Con il modo in cui nei miei scritti si presenta l’élenchos – che è, insieme, élenchos della negazione dell’esser sé dell’essente in quanto essente (dell’esser sé che è il suo non esser l’altro da sé) ed élenchos della negazione dell’esistenza degli essenti che appaiono – Cacciari mi sembra d’accordo («qui il discorso severiniano perviene alla sua massima energia»; ivi, p. 50). L’élenchos autentico appartiene all’essenza di ciò che chiamo «struttura originaria della verità». Tale struttura è «originaria» perché il suo essere l’apparire dell’esser sé dell’essente in quanto essente (ossia di ogni essente e «innanzitutto» degli essenti che appaiono e del loro stesso apparire) è l’apparire di ciò la cui negazione è autonegazione. Tale negazione nega ciò che essa sostiene. L’élenchos è l’apparire di questa autonegazione. La struttura originaria è cioè l’assolutamente incontrovertibile. Essa, pertanto, non è la risposta alle due domande sollevate nel capoverso precedente, giacché, in quanto precedono la struttura originaria, tali domande, come ogni sapere che sia così precedente, non solo sono controvertibili, ma sono negazioni dell’innegabile.
La struttura originaria non risponde ad alcuna domanda: è essa il fondamento di ogni domanda. Proprio perché, come si è rilevato, la riflessione di Cacciari sull’Uno – cioè sulla «cosa ultima», la quale è la «Possibilità» stessa del fenomeno, la «dýnamis, la potenza che [lo] fa ek-sistere» (ivi, p. 333) – non intende «precipitare nella contraddizione», e non intende nemmeno escluderla in modo dogmatico, mi sembra che, almeno su questo versante, Cacciari sostenga di fatto (in actu exercito) che la struttura originaria è il fondamento del discorso sull’Uno, ossia è ciò per cui tale discorso non è contraddittorio. Cacciari usa la parola «fondamento» soprattutto per indicare l’Uno in quanto potenza che fa esistere il fenomeno, e in questo caso «fondamento» è ratio essendi, mentre (continuando con questa terminologia) la struttura originaria è ratio cognoscendi dell’Uno: per lo meno nel senso che, appunto, non si intende pensare contraddittoriamente l’Uno. Cacciari intende tener fermo che l’Uno non è il fenomeno – o anche: che il noumeno non è il fenomeno –, ma perché questa alterità stia ferma senza oscillare, cioè stia veramente ferma, è necessario pensare in modo autentico il non esser l’altro da sé da parte dell’essente in quanto essente; e questa autenticità è appunto la struttura originaria della verità. Tuttavia emerge anche, sembra, il versante «neoplatonico», lungo il quale Cacciari, di fatto, non intende porre la struttura originaria, come fondamento del discorso sull’Uno. Per lui, l’Uno non è un ente (ogni ente essendo un determinato) e pertanto non sottostà alle leggi che regolano l’ente in quanto ente. Ci si può chiedere perché, allora, il discorso sull’Uno non debba essere contraddittorio, ossia perché debba rispettare (come Cacciari richiede) la suprema legge dell’ente in quanto ente. A questo secondo versante è connesso anche il concetto di «inesprimibilità» dell’Uno (in contrapposizione all’esprimibilità dell’ente). Cacciari sa molto bene che il suo è un ampio e complesso discorso sull’inesprimibile e che nonostante ogni precauzione e precisazione, esso è pur sempre un esprimere l’inesprimibile (ma precauzioni e precisazioni aumentano il volume di questo esprimere). Certo, Cacciari afferma che l’Uno-noumeno è «pensato» mentre l’ente è «conosciuto» (Kant); tuttavia l’Uno è pensato – ripetiamo – secondo quella legge suprema dell’ente che è la negazione della contraddittorietà dell’ente, e quindi secondo tutte le determinazioni che sono necessariamente implicate da tale negazione (e cioè sono tali che se fossero negate resterebbe negata la struttura originaria della verità).
Si evita la contraddizione – osservo – evitando di ridurre arbitrariamente l’ambito dell’essente e quello dell’esprimibile. In relazione all’ambito dell’essente, la contraddizione è evitata rilevando che, se e poiché l’Uno non è un nihil absolutum, già questo suo non essere il nulla assoluto è il suo essere un essente – per quanto esso possa differire da ogni altro essente. Sì che la dimensione dell’essente includerà (qualora si sia in grado di affermare l’Uno) sia quegli essenti che non sono l’Uno sia quell’essente che è l’Uno. Indubbiamente, Cacciari fa ogni sforzo per evitare questo tipo di rapporto tra l’Uno e i molti – come Heidegger fa...