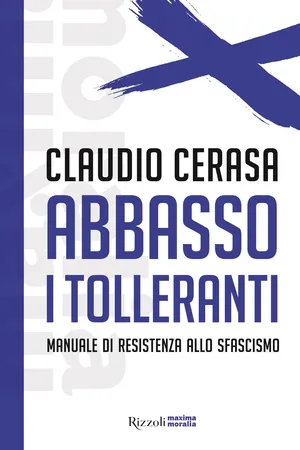![]() Tecnologia e social network: abbasso i nostalgici
Tecnologia e social network: abbasso i nostalgici![]()
Non demonizziamo i telefonini
Una ricerca sorprendente, svolta in Florida e ripresa dall’«Economist», rimette in discussione molte delle teorie diffuse negli ultimi anni sul rapporto tra noi, i nostri figli e il nostro telefonino. Il senso dell’articolo suggestivo e controintuitivo dell’«Economist» è più o meno questo: preoccupatevi pure del vostro telefonino, d’accordo, ma smettete di demonizzarlo.
Ciascuno di noi è convinto che la stabilità dei nostri figli, e forse anche quella dei nostri amici, sia inversamente proporzionale al numero di ore passate a osservare e a compulsare lo schermo del telefonino (più lo si compulsa e più si sta male). In realtà, le cose non stanno esattamente così.
Grazie a uno studio dell’Accademia dei pediatri della Florida condotto su un gruppo di seimila adolescenti, si è scoperto che il tempo passato di fronte a uno schermo inizia a essere preoccupante e a produrre effetti distorsivi solo se si superano le sei ore al giorno: se si passa cioè un quarto della giornata con gli occhi piantati sul telefono. Sotto le sei ore, i comportamenti a rischio per gli adolescenti rimangono gli stessi a prescindere dal numero di minuti passato al cellulare.
Accanto a questo dato l’«Economist» offre un altro spunto di riflessione partendo da una serie di ricerche americane che attestano come solo l’1 per cento delle variabili che hanno un impatto sulla psiche degli adolescenti derivi dall’uso del telefono (per capirci, circa tre volte in meno di quanto ne abbia una buona o una cattiva colazione sulle nostre vite). Per di più, se proprio vogliamo essere pignoli, l’«Economist» nota anche che tra i ragazzi americani, da quando è aumentato l’uso dei social e dei telefonini, è diminuito in modo consistente l’uso di alcol.
Tutto questo per concentrarci su un punto importante: aver trasformato i social network e i telefonini nel grande male della nostra società ci ha portato a far diventare la tecnologia il grande alibi dietro il quale nascondere la nostra scarsa comprensione degli atteggiamenti dei nostri figli. È come credere che la politica sia spiegabile con le fake news. È come dimenticarsi che la tecnologia può apportare alla vita dei nostri figli benefici infinitamente superiori rispetto ai problemi che può creare. Pensateci bene, prima di lavarvi la coscienza dicendo domani ai vostri figli: basta con quel telefono.
![]()
L’età giusta
Musical.ly è un social network di video sharing che conta circa 200 milioni di iscritti e se non lo avete mai sentito nominare significa che non conoscete un importante pezzo di mondo. I numeri sono ancora lontani da quelli ottenuti da piattaforme come YouTube e Facebook – che hanno tra il miliardo e mezzo e i due miliardi di utenti attivi su base mensile – ma la particolarità di questo social è che la stragrande maggioranza degli iscritti non ha neppure diciotto anni. E dunque, di fronte alla crescita esponenziale di Musical.ly, c’è una domanda che non possiamo non farci: i telefonini non vanno demonizzati, certo, ma qual è l’età giusta per i nostri figli per possederne uno e giocare con le app?
Non esiste una risposta univoca, ma intanto si devono considerare alcuni dati. Il primo arriva da una ricerca recente della London School of Economics, secondo la quale nelle scuole in cui l’uso del cellulare è vietato gli studenti ottengono il 6,4 per cento di voti più alti.
Il secondo proviene da un’importante ricerca svolta dalla Società italiana di pediatria preventiva, per la quale sotto i dieci anni i bambini non dovrebbero utilizzare i cellulari perché il campo elettromagnetico tende a creare delle forme di dipendenza psicologica che mettono a rischio la concentrazione. Questi dati sono utili ma non sufficienti per rispondere alla nostra domanda. E allora ricordiamo quello che faceva Bill Gates, che di tecnologia ne sa, con i suoi figli. La formula è questa: «Spesso fissiamo un orario oltre il quale telefoni, tv e pc devono essere spenti: nel loro caso questo li aiuta ad andare a dormire a un’ora ragionevole. Non portiamo mai i cellulari a tavola quando mangiano e non abbiamo permesso loro di utilizzarli prima dei quattordici anni, nonostante si siano sempre lamentati di non essere “al passo” con gli altri compagni».
Il ragionamento di Bill Gates non deve farci riflettere solo sull’età giusta per utilizzare i telefonini ma anche su un altro tema che riguarda il rapporto tra genitori e figli. Nell’epoca in cui le gerarchie vengono sempre più distrutte, siamo in grado di dire ancora dei no ai nostri figli?
![]()
Su carta e su schermo
Cosa succede nel nostro cervello quando leggiamo qualcosa non su un pezzo di carta ma su uno schermo? La prima risposta che ciascuno di noi potrebbe dare è che in realtà varia poco o nulla: al massimo cambia lo sforzo che chiediamo alla nostra vista. Ma per avere una risposta più accurata bisogna leggere una ricerca illuminante pubblicata dal World Economic Forum, che ha messo a fuoco, sulla base di una serie di indagini, la vera differenza che esiste tra una lettura su carta e una non su carta. Badate bene: non si parla solo di tecnologia, si parla prima di tutto di democrazia.
Le ricerche sono state realizzate su un campione formato da centinaia di studenti divisi in due squadre. A entrambe le squadre è stato offerto lo stesso testo su due supporti diversi. Alla prima squadra, su carta. Alla seconda, su tablet. Alla fine della ricerca, i risultati sono stati quattro. Chi ha letto il testo sul supporto digitale lo ha letto più in fretta; gli studenti che hanno letto il testo sul digitale hanno affermato di aver compreso il testo con più convinzione rispetto a chi lo ha letto su carta; la comprensione generale del testo è stata simile sia per chi ha letto su carta sia per chi ha letto su tablet, ma il livello di approfondimento, con singole domande sui dettagli del testo, è risultato differente. Chi ha letto su carta ha capito meglio.
La riflessione offerta dal World Economic Forum è che la velocità, durante la lettura, ha un prezzo: chi legge su supporti non cartacei tende a capire meno ed è soggetto a molte distrazioni. A lungo andare, una lettura mediata da uno schermo crea un effetto distruttivo e rallenta la nostra capacità di comprensione e – attenzione – di riflessione. C’entra qualcosa con l’epoca dell’irrazionalità in cui viviamo il fatto che le nostre letture sono sempre più mediate da uno schermo? Il World Economic Forum, sotto sotto, sembra dirci di sì.
![]()
Mettersi al riparo dalle grandinate di notizie
Farhad Manjoo, giornalista del «New York Times» esperto di tecnologia, per due mesi ha abbandonato le news online e ha letto le notizie solo su tre giornali cartacei. Dopodiché ha scritto una sintesi della sua esperienza e ha scoperto che in quel periodo non solo ha capito meglio quanto stava succedendo nel mondo ma ha anche scoperto una cosa di cui si era dimenticato: il tempo libero.
Manjoo racconta di essere entrato a contatto con un metodo meno compulsivo di guardare le notizie. Racconta di aver seguito con calma gli eventi reali della giornata. E dice che due mesi dopo si è sentito più informato e soprattutto meno soggetto alle fake news. Sintesi del giornalista: «Spegnere la ronzante macchina per le notizie che portavo in tasca è stato come liberarmi di un mostro sempre pronto a irrompere nella mia giornata con bollettini decotti. Ora non sono soltanto meno ansioso e meno dipendente da una notizia, ma sono anche più informato. E soprattutto sono imbarazzato per quanto tempo libero ho: in due mesi sono riuscito a leggere una mezza dozzina di libri, ho iniziato a lavorare la ceramica e sono diventato persino un marito e un padre più attento».
Il racconto del giornalista americano è interessante perché arriva non da un luddista ma da uno specialista di high tech che ha scelto di fermarsi e di riflettere su come la combinazione tra tecnologia e informazione stia contribuendo a distorcere la nostra percezione della realtà. Farhad Manjoo ha capito insomma che la cura giusta per mettersi al riparo dall’overdose informativa è capire che c’è una grande differenza tra un sistema che prova solo a informarti e uno che tenta anche di formarti.
In un’epoca in cui le informazioni ci colpiscono come grandine, non ci si può occupare solo di essere immediati, a volte bisogna pensare anche a come andare in profondità, e a come fermarsi. Non significa considerare inaffidabile la tecnologia. Significa dire una cosa diversa: alla fine, forse, il modo migliore per essere meno soggetti alla fake news è togliere ogni giorno una notifica dal nostro telefonino e avere il tempo per pensare a ciò che stiamo leggendo.
![]()
La grande distrazione di massa
L’acuto commentatore americano Franklin Foer ha pubblicato negli Stati Uniti un libro favoloso intitolato World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech (Un mondo senza mente: la minaccia esistenziale dei big della tecnologia). Parliamo di questo libro per provare a rispondere a una domanda che molti di voi si saranno fatti almeno una volta: la tecnologia ha cambiato in peggio il nostro modo di vivere, e in che modo?
Franklin Foer sostiene che l’ingorgo tecnologico di fronte al quale si trova ciascuno di noi ha avuto un impatto culturale devastante e ha alimentato una società dell’algoritmo all’interno della quale è stata a poco a poco distrutta ogni forma di contemplazione. L’idea dello scrittore americano è che l’ecosistema dato dall’insieme di alert, di notifiche, di clic e di messaggi ha prodotto un utente non solo multitasking ma prima di tutto distratto, con una soglia di attenzione molto bassa.
Foer la chiama l’epoca della grande distrazione di massa, in cui non solo si stanno abbassando le nostre difese cognitive di fronte a tutti i suggerimenti che ogni giorno ci arrivano dai giganti della tecnologia, ma si alimenta anche una bolla che mette a rischio la nostra individualità.
Gli effetti di questa bolla sono diversi. Uno è stato descritto con parole magistrali da Barack Obama nel suo ultimo discorso da presidente degli Stati Uniti. Sono poche frasi, vale la pena impararle a memoria: «Per troppi di noi è diventato più sicuro ritirarsi nelle proprie bolle, circondati da persone che ci assomigliano e che condividono la nostra medesima visione politica e non sfidano mai le nostre posizioni. Ciascuno di noi diventa progressivamente tanto sicuro nelle sue bolle, che finiamo con l’accettare solo quelle informazioni, vere o false che siano, che si adattano alle nostre opinioni, invece di basare le nostre opinioni sulle prove che ci sono là fuori».
Insomma, tutti sappiamo come la tecnologia ha migliorato la nostra vita. Il libro di Franklin Foer ci aiuta a capire in cosa l’ha peggiorata. Anche voi siete entrati nell’epoca della distrazione di massa?
![]()
Il mito dell’infallibilità della rete
A fine settembre 2017, durante un importante discorso alla Sorbona, il presidente francese Emmanuel Macron ha affrontato molti temi, ha spiegato perché i protezionismi si sconfiggono dando ai cittadini una maggiore protezione in Europa, e ha sfiorato una questione cruciale non solo per chi vive nel mondo dell’informazione e delle comunicazioni: il futuro del diritto d’autore.
Macron ha detto che «in questa Europa del digitale dobbiamo difendere il nostro diritto d’autore, e difenderlo ovunque esista un valore creato da un nostro cittadino». E poi ha aggiunto che lo scandalo dei nostri giorni è che vi sia un continente dove il valore prodotto non è di chi lo ha creato ma di colui che lo trasporta fino al suo consumatore finale. Macron, in buona sostanza, chiede regole per le grandi aziende legate a internet che usano contenuti di altri senza pagarli. Ma più che il dato tecnico ciò che ha un suo interesse riguarda un dato culturale: il presidente dice esplicitamente che in una democrazia sana è necessario tutelare le élite per non regalare il mondo all’anarchismo digitale. E nel dire questo invita a combattere un vero e proprio tabù. Ovverosia: è giusto o sbagliato considerare una risorsa della democrazia tutto quello che arriva dalla rete? E ancora: è giusto o no considerare ogni norma proposta per regolare internet come un bavaglio per la democrazia?
Macron ha abbattuto un muro e ha detto che la difesa del diritto d’autore, e la lotta contro il mito dell’infallibilità della rete, è una grande battaglia di civiltà. Può sembrare solo un dettaglio, una discussione per specialisti, ma in realtà in questo dibattito c’è l’essenza della democrazia: lo scontro tra chi sogna di tutelare un’élite e chi invece sogna di spazzare via dal mondo ogni genere di élite.
![]()
Il mito della gratuità della rete
Spotify è uno dei più popolari servizi legali di streaming musicale, conta oltre 75 milioni di iscritti e permette di ascoltare sui propri dispositivi tecnologici qualsiasi tipo di musica. La formula su cui si basa è stata esportata anche in altri settori. C’è una versione gratuita che costringe l’iscritto ad ascoltare ogni tanto della pubblicità ed esiste invece un abbonamento a pagamento che permette di ascoltare musica con una qualità tecnica superiore e senza pubblicità. Come capita a molti servizi offerti online, però, qualcuno si è inventato un modo per craccare, taroccare, piratare l’applicazione: esistono applicazioni che consentono illecitamente di ascoltare musica senza pubblicità e senza dover pagare.
Quando però Spotify ha deciso di quotarsi in Borsa, ha iniziato a chiudere gli account illegali e disabilitare le app pirata. A quel punto il popolo della rete, quello che si è sentito in diritto di usare un sistema illegale, si è indignato e su Facebook, su Twitter, nelle recensioni online di Spotify, migliaia e migliaia di utilizzatori della app fraudolenta hanno gridato allo scandalo e alla truffa. Il popolo della pirateria si è sentito truffato perché non riusciva più a truffare.
Intorno a questa piccola polemica c’è l’essenza di una grande contraddizione di cui la rete è portatrice. L’idea cioè che se qualcosa è online non vale la pena pagarla e che la pirateria è una forma lecita di diffusione della cultura. Il principio è più o meno questo: la rete è un diritto e tutto quello che si trova in rete deve essere sbloccato perché le informazioni offerte dalla rete sono come l’acqua, non sono di nessuno, sono di tutti, non possono avere padroni. Prima di indignarci con i pirati che si ribellano, converrà accertarsi che sotto sotto non siamo anche noi dei pirati.
![]()
La responsabilità dei contenuti digitali
A metà ottobre 2017 si sono incontrati a Ischia i ministri degli Interni dei sette paesi più importanti del mondo e insieme a loro si sono seduti i vertici di alcuni dei giganti della tecnologia. Da Google a Microsoft. Da Facebook a Twitter. La ragione per cui questo appuntamento è stato importante è che per la prima volta la politica ha chiesto ai campioni della New Economy di trovare un modo per uscire da una post-verità che suona più o meno così: chi si occupa di veicolare i contenuti non ha alcuna responsabilità su quei contenuti in quanto gli strumenti della rete e della tecnologia non possono che essere considerati sempre e costantemente neutrali. Ora però i più importanti governi del mondo chiedono a Facebook, Twitter e compagnia di diventare responsabili dei contenuti che veicolano.
La svolta culturale per cui un gigante della tecnologia deve vigilare sulla qualità dei prodotti che offre al proprio utente apre un altro fronte che questa volta è meno giuridico e più culturale: un social network o un servizio informatico può mai essere considerato del tutto neutrale? In America, da mesi, il dibattito su questo tema è intenso e qualche giorno fa è intervenuto sul mensile «The Atlantic» uno dei più importanti e noti giornalisti del settore, Alexis Madrigal.
La tesi di Madrigal è che ormai le realtà tecnologiche non si limitano a essere ripetitori di altri contenuti ma fanno cose diverse. Da un lato incentivano a prendere una posizione su un determinato tema perché tendono a rafforzare le nostre idee senza darci la possibilità di confrontarci con il pensiero degli altri. Dall’altro tendono ad alimentare un fenomeno che è stato ridefinito «maoismo digitale». La definizione di maoismo digitale è di un gigante del pensiero tecnologico, Jaron Lanier, che tempo fa ha sintetizzato così il suo pensiero: «La condivisione tecnologica è un’aberrazione fondata sulla leggenda che il sapere collettivo sia inevitabilmente superiore alla conoscenza del singolo esperto e che la quantità di informazioni, superata una certa soglia, sia destinata a trasformarsi automaticamente in qualità».
Nel mondo in cui viviamo oggi, possiamo davvero illuderci che esista qualche notizia che arriva a noi in modo neutrale? Non è vero quando si parla di vecchi media, forse non è vero nemmeno per i nuovi sistemi di comunicazione.
![]()
La (non) neutralità della rete
Esiste davvero la net neutrality? Ovvero: esiste davvero la possibilità che la rete sulla quale navighiamo sia realmente neutrale? Un importante consulente di social media marketing, l’americano Daniel Gallant, ha pubblicato sul «Wall Street Journal» un intervento interessante in cui ha spiegato perché occorre superare una volta per tutte il falso mito della neutralità della rete. «Gran parte delle discussioni sulla net neutrality ignorano un fatto importante: l’internet che quasi tutti noi usiamo è già ben lungi dall’essere neutrale, a causa degli algoritmi e delle opache linee guida in base a cui le aziende di social media come Facebook, Twitter e Instagram gestiscono i loro siti.»
Il ragionamento continua così: «Attraverso questi portali online personalizzati apprendiamo le notizie, condividiamo video, scopriamo dettagli della vita dei nostri amici, e discutiamo di tematiche sociali. Queste piattaforme, però, non trattano tutti i contenuti in modo equo, né li distribuiscono in modo giusto. Facebook e Instagram gestiscono i contenuti in maniera decisamente innaturale, usando tattiche che favoriscono gli sponsor con ingenti risorse e i venditori con un talento per il content-targeting».
Il dato più interessante sul quale riflette il «Wall Street Journal» riguarda però un problema di carattere non commerciale ma culturale. I social network, anche per poter immagazzinare dati sui nostri profili, tendono spesso, come abbiamo visto, a consigliare a ciascuno di noi articoli simili a quelli che già abbiamo letto, musica simile a quella che abbiamo già ascoltato, video simili a quelli che abbiamo appena visto. In questo senso la rete non è neutrale e la domanda su cui vale la pena discutere è: la diffusione capillare delle comunicazioni via social ha contribuito o no a ingrossare la democrazia della bolla? In altre parole, ha contribuito o no a creare una società ultrapolarizzata all’interno della quale le bolle non riescono a comunicare tra loro? La risposta, a mio modo di vedere, è sì.
![]()
Una repubblica da due miliardi di abitanti
Alcuni numeri sbalorditivi certificano una realtà che ci ostiniamo a non voler comprendere. Sono i numeri che racchiudono coloro che abitano all’interno di quei continenti che sono i social network. Sapete quanti sono gli utenti attivi di Facebook? Due miliardi. Sapete ...