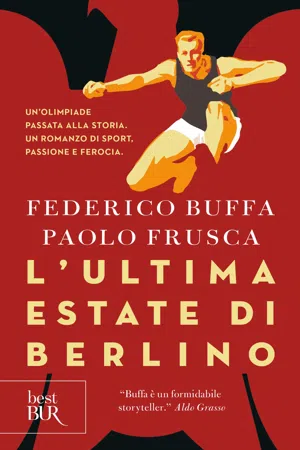![]()
1
Berlino, 17 giugno 1936. Mattino.
Acqua bollente e asciugamano di spugna intorno al collo.
Sono in piedi davanti allo specchio del bagno.
Rito mattutino, celebrazione di virilità.
Radersi tranquillizza. Toglie dalla mente le scorie di una notte agitata.
Mescolo col pennello il sapone nella ciotola.
Coramella di cuoio chiaro. Rasoio affilato.
Oggi la rasatura deve essere perfetta.
La lama di Solingen trascina la schiuma lungo i noti percorsi delle guance e del collo.
Forse dovrei lasciarmi crescere un poco le basette.
No. Meglio di no. Per gli ufficiali il regolamento non lo prevede.
Agitazione crescente al pensiero delle personalità del Governo che mi attendono. Non ci sarà solo Adolf Hitler.
E un vago senso di inquietudine.
Continua a ronzarmi in testa la vicenda dei danni causati dai visitatori al Villaggio.
Perché? In fondo si tratta solo di una piccola macchia sul mio curriculum.
Il sapone è eccellente, morbido.
La lama scorre.
Spero proprio che nessuno di questi pezzi grossi tiri fuori la faccenda.
Appena sopra il labbro. È una zona difficile, da radere delicatamente.
E anche quel fogliaccio di propaganda idiota che ha pubblicato allusioni sulle origini razziali di mio nonno.
Insignificante, certo, ma spiacevole. Nessuno metterà in discussione i miei meriti verso lo Stato per un articolo di calunnie.
Eppure.
Non riesco a fare a meno di pensarci.
Propaganda razziale che ci sta facendo perdere la faccia di fronte al mondo civile.
Ahi! Maledizione! Ecco. Mi sono tagliato. Quando penso a certe questioni mi tremano le mani.
Brucia. Sanguino. Strofino le dita sulla ferita.
Contemplo la goccia di sangue sulla punta del mio indice e, per quanto mi sforzi, non riesco a distinguere la mia parte ariana da quella ebraica.
Dovrò farlo sapere ai giornalisti dello «Judenkenner»!
Taglio superficiale, comunque. Niente di grave.
Ma non è un rasoio di Solingen?
Allume di rocca dalla bottiglietta verde smeraldo.
Bene. Finito.
Adesso ci vuole acqua bollente e l’asciugamano di spugna.
Dopobarba.
Controllo tirando la pelle del viso se la rasatura è perfetta.
Pare di sì. Il taglietto sopra il pomo d’Adamo è già cicatrizzato.
Spio la mia espressione allo specchio: le guance scavate, gli occhi infossati.
Oggi sento ciascuno dei miei quarant’anni.
Un macigno la stanchezza di queste settimane, ma passerà.
Passerà presto. Una volta che tutto sarà finito per il meglio.
Ma perché quell’articolo è uscito proprio ora?
Ancora quell’inquietudine. Mi prende lo stomaco.
La mia uniforme per oggi, scelta con cura.
Pantaloni grigi da ufficiale con doppia striscia rossa lungo la gamba.
Stivali lucidi, appena spazzolati dall’attendente.
Camicia chiara stirata, senza la minima piega. Cravattino nero.
Cinturone. Fibbia d’acciaio, in rilievo il Gott mit uns.
Sciabola? No. Niente sciabola, sarebbe eccessivo.
Giacca d’ordinanza, estiva, da cerimonia. Candido fresco di lana.
Spalline dorate. Luccicano i gradi di capitano della Wehrmacht.
I nastri colorati di tutte le mie campagne militari sfilano in bella mostra lungo il taschino della giacca.
Rossignol, Somme, Loretto, Brody, Galizia, Tolmino, Fiandre.
Ventitreesimo reggimento fanteria Winterfeldt.
I figli della Slesia.
Croce di ferro di prima classe all’occhiello della giacca.
L’arrivo di questi ospiti va degnamente celebrato.
Berretto rigido. Coccarda nera, bianca e rossa. Guanti di pelle.
Sono pronto per il Führer, adesso.
![]()
2
Porto di New York, 15 luglio 1936.
Aveva ragione il reverendo Bridges a credere che sarei diventato un grande giornalista.
A spingermi a diventare un giornalista.
Non fosse stato per lui, io, Dale Fitzgerald Warren, non sarei qui, in procinto di salpare per l’Europa, corrispondente dell’«Herald Tribune» per le Olimpiadi.
No. Niente Olimpiadi.
Più probabilmente starei raccogliendo patate nei campi attorno alla mia città, a Decatur, traballando sul rimorchio del trattore coi miei fratelli, lungo le strade polverose dell’Alabama, tergendomi il sudore col fazzoletto del nonno e bevendo sidro dal bottiglione di vetro.
Invece ora guardo l’oceano dal ponte principale di questo transatlantico.
Fiancata bianca, striscia rossa e blu.
La nave si chiama Manhattan, è lunga come due campi di football e porterà in Europa la nostra delegazione per i Giochi olimpici. È un privilegio essere qui.
Viaggio di prima classe pagato dal giornale, mica male per uno che viene da Decatur, Alabama, e nella vita era destinato a raccogliere patate.
Sento il salmastro dell’Atlantico sul viso e ripenso al giorno in cui tutto è iniziato: io a diciassette anni, la faccia piena di brufoli, che scrivo per il giornaletto della scuola la cronaca della partita Red Riders contro Patriots, campionato di football fra High School.
Benson Field, il nostro campo spelacchiato di erba gialla.
Tre cheerleader per squadra, «… e datemi una R, e datemi una E», quattro trombettieri disperati a suonare la carica e una dozzina di spettatori sulla tribunetta di legno.
Caschi scoloriti, per chi li aveva, e il mio professore di religione, il reverendo Bridges, che era anche l’allenatore della squadra di football, che porta di persona (oh, di persona!) la mia cronaca della partita al direttore del «Decatur Daily», il principale quotidiano della città. Anzi, l’unico.
Dalla chiesa alla sede del giornale nove chilometri in bicicletta per andare e nove per tornare, non proprio dietro l’angolo, sotto il sole dell’Alabama.
Il direttore fu talmente entusiasta che pubblicò la mia paginetta manoscritta nell’edizione del giorno successivo, senza cambiare una virgola.
No. Questo non è vero, forse qualcosa cambiò… non lo ricordo esattamente, è roba di vent’anni fa.
Comunque, due giorni dopo ero in redazione, con indosso le scarpe di vernice di mio fratello, la camicia stirata e un quaderno con i fogli azzurrini per prendere appunti che mi aveva regalato il reverendo.
Da quell’articolo iniziò la mia carriera. Una straordinaria carriera.
Non potrò mai ringraziare abbastanza il reverendo Bridges.
Ora ci vorrebbe un drink. Vediamo dove si trova il bar su questo ponte…
La sirena del piroscafo sta fischiando. Già si parte? Impossibile, dovrebbe salpare fra un’ora. E perché fischia allora? Ancora non esce fumo dai comignoli.
Guardo in basso, sul molo, movimento di gente, colleghi giornalisti e semplici lavoratori del porto, ufficiali e scaricatori, tutti in grande subbuglio. Una decina di marinai, divise candide, escono da un boccaporto e corrono verso la fiancata dove mi trovo, si tengono i berretti in testa con la mano perché non volino via nel vento, ridono felici, si affacciano. Come aspettassero qualcuno.
Urlano, saltano. Anche le altre navi intorno fanno fischiare le loro sirene. C’è aria di festa.
Guardo il molo. Distinguo solo atleti, colleghi e dirigenti della squadra americana che stanno salendo sulla nave. Non capisco cosa abbia provocato tutta questa agitazione.
Un giovane ufficiale arriva con gli altri alla balaustra, si colloca proprio al mio fianco e lo interrogo: «Ehi, guardiamarina, mi dici che succede?».
«Sta arrivando! Viene a bordo!» Poi mi guarda stupito per l’assenza di una mia reazione.
«Davvero non hai capito chi sta salendo?»
«Oh, “ammiraglio”, non te lo avrei chiesto.»
Lui alza di un tono la voce, se possibile ancor più emozionato: «Ma Babe Ruth, lo hanno detto alla radio militare… viene a bordo a salutare gli atleti in partenza».
Ora mi spiego la confusione. George Herman Ruth, detto “Babe”. Il dio del baseball, il più famoso sportivo d’America. Forse il più popolare personaggio d’America.
Altri marinai si accalcano intorno a me, tutti esaltati. Guardo di nuovo verso il basso e lo riconosco. È proprio lui che sale lungo la scaletta con passo veloce, atletico.
L’ho intervistato molte volte, ma vederlo da vicino è sempre emozionante.
Eccolo sul ponte. E i primi atleti gli vengono incontro alla spicciolata, eccitati e intimiditi, a rispettosa distanza.
«Ehi, Babe, vieni a giocare con noi in Europa?»
La domanda arriva da un terzabase della squadra nazionale di baseball, che per la prima volta sarà sport olimpico.
«Credo vincerete lo stesso, anche senza di me!»
«Babe, è vero che sei più famoso del presidente?»
«Ovvio ragazzi, anche ai repubblicani piace il baseball!»
Risposte fulminanti e risate di tutti i giovani intorno. Ruth sempre disponibilissimo, ge...