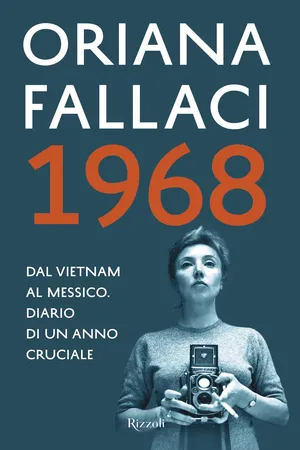![]()
La tragedia incomincia con la paura
Gennaio-Marzo
Il 1968 di Oriana Fallaci si apre a migliaia di chilometri da casa, in Vietnam, dove si trova insieme al fotografo Gianfranco Moroldo per documentare la guerra in atto per conto dell’«Europeo».
È il grande incarico che la consacra corrispondente di guerra, cui seguiranno molti altri. È arrivata nel paese nel novembre 1967 e vi ritornerà dodici volte in sette anni, documentando menzogne e atrocità, ma anche eroismi e umanità di un conflitto che lei stessa definì una sanguinosa follia.
Durante la sua permanenza nell’ex Indocina incontra e intervista tutti i protagonisti dello scontro: generali USA, governanti del Sud e del Nord del paese, soldati americani, vietcong, religiosi, gente comune, fornendo un affresco crudo e impietoso delle ragioni del conflitto.
In Vietnam incontra anche François Pelou, corrispondente di France Presse, con cui avrà una relazione durata fino al 1973.
Salvo un breve ritorno a New York durante la battaglia di Saigon, resterà nel paese fino a fine marzo. Rientrando si ferma a Hong Kong, il cui futuro è nelle mani della Cina della Rivoluzione culturale.
![]()
1
Dio, non farmi morire
Con Gianfranco Moroldo si reca in uno dei posti più pericolosi della guerra: Dak To. Per partire devono firmare una «liberatoria» al governo degli Stati Uniti, in caso di morte. «Io sono qui per capire,» scrive «per sapere cosa pensa un uomo che ammazza un altro uomo che a sua volta lo ammazza: senza conoscerlo.» «Non aver paura,» le ha scritto François Pelou su un bigliettino. In mezzo ai bombardamenti incontra i soldati americani, tra nostalgia di casa e paura di morire. «Guarda,» le dice uno di loro «io non voglio essere un eroe.»
Dak To, gennaio
«Quando morirò andrò in Paradiso perché su questa terra ho vissuto all’Inferno. Vietnam, 1967.»
«Ho dormito sotto Joe. Era morto e faceva caldo. Dammi una sigaretta. Hai mai dormito sotto un morto che faceva caldo?»
«Signora, lei crede che ce la farò? A volte ho paura di no. E prego, sa, non faccio che pregare. Prego anche quando non ho tempo, per esempio quando vado all’assalto. Dico alla svelta: Dio, non farmi morire.»
«Dio, che cosa schifosa è la guerra. Dev’esserci qualcosa di sbagliato nel cervello di quelli che si divertono a fare la guerra, che la trovano gloriosa o eccitante. Non c’è nulla di glorioso, nulla di eccitante, è una sporca tragedia.»
«Io non voglio essere ricco, non voglio essere eroe. Io voglio vivere e basta. La vita è bella, sai, bella. Ora lo so che la vita è bella, prima non lo sapevo, credi che morirò?»
«Non voglio tornare in battaglia. Sono così giovane e ho tanto tempo da vivere, e non si viene al mondo per morire a venti anni alla guerra. Si viene al mondo per morire in un letto, quando si è vecchi.»
«E poi ammazzai un uomo. Era un piccolo viet. Correva, correva, e gli sparavano tutti. Sembrava d’essere al tirassegno di un luna park. Gli ho sparato io ed è caduto. Ma è stato come sparare ad un albero. Non ho sentito nulla, sai, nulla.»
«Signora, è vero che è così brutto lassù?» «Ma no, soldato, ma no. Oggi è quieto, vedrai.»
«Lasciatemi in pace. Non m’importa di nulla, non m’importa nemmeno di morire.»
Poi è arrivato un razzo. E di lui è rimasta soltanto una scarpa.
LUNEDÌ MATTINA. La tragedia incomincia con la paura. E la paura incomincia appena sali sul cargo militare che ti conduce alla zona del fuoco insieme ai soldati che tacciono in un rassegnato silenzio. Ieri un cargo come questo è precipitato, sembra per un sabotaggio, e nessuno ha fatto in tempo a usare i paracadute con cui dovremo buttarci se saremo colpiti. Del resto, il paracadute a che serve? Mentre cali a terra ti sparano, voliamo su una regione che pullula di vietcong. Fa caldo, sudi. Anche perché il soldato accanto ti fissa da almeno mezz’ora scuotendo la testa e poi, cercando di superare il rombo dei motori, ti grida: «Sei giornalista?». «Sì.» «E il lungo con te è un fotografo?» «Sì.» «Andate a Dak To?» «Sì.» «Idioti, chi ve lo fa fare?» Te lo chiedi anche tu, all’improvviso. Hai superato tanti ostacoli per arrivare fin qui, visti permessi burocrazie, e all’improvviso vorresti esser mille miglia lontano dove la guerra è solo una parola, una fotografia sul giornale, una immagine alla televisione. Provi a scherzare, la voce ti suona falsa: «Moroldo, ci pensi alla faccia dell’ambasciatore quando gli consegnano i nostri cadaveri?». Per raggiungere Dak To abbiamo firmato un foglio con cui sdebitiamo le forze armate e il governo degli Stati Uniti della nostra possibile morte, e in fondo al foglio c’era questa domanda: «A chi dovrà essere consegnato il vostro cadavere?». Presi alla sprovvista, abbiamo scritto: «Ambasciata italiana a Saigon». Moroldo brontola che lo disturba solo un particolare: l’intera faccenda è avvenuta di venerdì 17. Anche le uniformi le abbiamo prese di venerdì 17, ma bando alle spiritosaggini: in poco più di due anni sono morti dieci giornalisti in Vietnam. Ricordiamoli, non lo fa mai nessuno. Maggio 1965, Pieter Ronald Van Thiel: ucciso dai vietcong a sud di Saigon. Giugno 1966, Jerry Rose: precipitato con l’aereo colpito da una cannonata a Quang Ngai. Ottobre 1966, Bernard Kolenberg: precipitato con un caccia sulla zona demilitarizzata. 1966, Huynh Thanh My: ucciso in battaglia a Can Tho. Novembre 1966, Dickey Chapelle: saltata su una mina a sud di Da Nang. Novembre 1966, Charlie Chellapah: disintegrato da un mortaio a Cu Chi. Dicembre 1966, Sani Castali: ucciso in combattimento nelle pianure centrali. Febbraio 1967, Bernard Fall: sventrato da una mina nella foresta di Hué. Marzo 1967, Ronald Gallagher: ucciso per errore dall’artiglieria americana nei pressi di Saigon. Maggio 1967, Felipa Schiller: mitragliata sull’elicottero che la portava a Da Nang.
Di feriti, quest’anno, ce ne sono stati una trentina. Ieri a Saigon ho conosciuto Catherine Leroy, fotografa francese. Ha ventitré anni, il braccio destro, la gamba destra, la parte destra del volto coperti di cicatrici, e cammina zoppa. Lo scorso maggio, durante un combattimento al 17° parallelo, le scoppiò accanto un colpo di mortaio. È stata tre mesi in ospedale, dal corpo le hanno tolto diciotto schegge, ma al piede la ferita continua a riaprirsi, riaprirsi, e i medici non sanno più cosa fare. Le ho chiesto: «Perché non torni a casa, Catherine?». Ha sorriso senza rispondermi. Che strani tipi questi miei colleghi in Vietnam. Alcuni sono fior di giornalisti e potrebbero stare a Londra o a Parigi: invece bestemmiano e rimangono qui. Altri sono reporter improvvisati, nessuno li voleva mandare: ma hanno supplicato o sono venuti da sé, a loro spese. Cosa cercano, dimmi. Uno scopo che non avevano prima? Un brivido che li scuota dalla noia? Una pallottola che risolva un loro dolore? Un’imitazione di Hemingway? Ho tentato un’indagine, uno ha risposto: «Voglio dimostrare a mio padre di non essere il cretino che dice». Un altro ha risposto: «Mia moglie ha divorziato». Un altro ha risposto: «È eccitante e, se fai la foto giusta, sei a posto per sempre». Quasi nessuno m’ha dato la sola ragione che a me sembra valida: «Sono qui per capire».
Io sono qui per capire, per sapere cosa pensa un uomo che ammazza un altro uomo che a sua volta lo ammazza: senza conoscerlo. Sono qui per provare qualcosa a cui credo: che la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre. Sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo quando si esalta su un siero che curerà il cancro, o sull’operazione chirurgica che sostituisce un cuore con un altro cuore: mentre migliaia di creature giovani e sane, senza cancro, col cuore a posto, vanno a morire come animali, vacche al macello. C’è la guerra da tre anni in Vietnam e la gente che piange su Washkansky dice: «Uh, che noia». Ci si massacra da venti giorni a Dak To, e la gente che prega sorride: «Davvero?». Dak To è un villaggio situato a dieci miglia dal confine col Laos e la Cambogia, proprio dove sbocca la pista Ho Chi Minh: vale a dire la strada da cui arrivano i rifornimenti di Hanoi alle formazioni vietcong e alle truppe nordvietnamite infiltrate nel Sud. Verso la fine di ottobre a Dak To c’era solo un battaglione di americani con una base aerea, minuscola. Poi un disertore nordvietnamita rivelò che i suoi compagni erano riusciti ad ammassare sulle colline intorno a Dak To ben settemila soldati e con questi si accingevano a sferrare l’attacco. Il generale Westmoreland reagì concentrando diecimila fra paracadutisti e soldati, il 1° novembre ebbe inizio la più sanguinosa battaglia combattuta fin oggi in Vietnam. A Saigon si dice: «O gli americani vincono entro sette giorni o Dak To diviene la loro Dien Bien Phu». Non è facile obbedire al consiglio che un amico della France Presse, François Pelou, mi ha lasciato in albergo con un bigliettino: «N’aie pas peur».
I viet sono come gli Apache e i Cheyenne
LUNEDÌ POMERIGGIO. Invece è facile. La paura ti passa, di colpo, con la paura degli altri. L’elicottero su cui siamo saliti alla base di Pleiku, ultima tappa prima di Dak To, ha posto per quattro persone oltre i due piloti e i due mitraglieri. Uno dei quattro è un telecronista appena giunto da New York. Il suo viso ha il colore del gesso, il suo corpo è scosso da un tremito convulso, e tutte le sue dieci dita sono ficcate dentro la bocca dove tutti i suoi trentadue denti le mordono furiosamente. Dopo pochi minuti si alza, batte alle spalle di un pilota, lo scongiura invano di tornare indietro, e provi tanta vergogna per lui che di colpo sei un’altra persona. Tranquilla, lucida, con ogni tuo nervo pronto a scattare per salvarti la pelle. Puoi perfino osservare con curiosità le colline a sinistra da cui si alzano fumate nere, il napalm che gli americani sganciano sui nordvietnamiti, poi le colline a destra da cui si alzano fumate bianche, le bombe che i nordvietnamiti lanciano sugli americani: ben consapevole che ci stai passando nel mezzo, come sotto un arcobaleno, sorvolando la giungla dove sono nascosti i vietcong i quali mirano dritto alle pale dell’elicottero. Puoi perfino capire perché questa guerra è una guerra diversa da ogni altra guerra che hai studiato a scuola, e perché dicono che non ha un fronte preciso, che il fronte è dovunque. Il mitragliere dietro di te s’è abbassato sulla mitraglia e spara raffiche contro una macchia da cui è partito un colpo appena avvertito. Sembra il personaggio di un western dove i bianchi sparano dal vagone agli indiani. Anche allora i bianchi tenevano in pugno un paese di cui possedevano solo qualche fortino, e per andare da fortino a fortino bisognava ammazzare o venire ammazzati. Sostituisci alla parola fortino la parola base aerea, alla parola indiani la parola vietcong, alla parola vagone la parola elicottero: ed ecco il Vietnam. Ecco il nostro viaggio a Dak To, con quel poverino che geme. Siamo a Dak To. Un campo militare con una pista nel mezzo, bucata dai mortai di stanotte. Decine di elicotteri e aerei che decollano o atterrano in una tempesta di polvere rossa, un fragore che spacca gli orecchi. Centinaia di camion e di jeep che trasportan soldati dalla barba lunga e lo sguardo stanco. Postazioni di artiglieria che vomitano cannonate ogni trenta secondi facendo tremare la terra e il tuo stomaco. Eppure come doveva esser bello il Vietnam quando non c’era la guerra. I monti dove ora si muore son blocchi di giada e smeraldo, il cielo dove ora schizzan le bombe è una cappa color fiordaliso, e il fiume che ora serve a spegnere gli incendi ha un’acqua così limpida, fresca. Come doveva essere facile sentirsi felici quaggiù, andando a pescare sulle rive, a passeggiare nei boschi. Poi un tenente ci viene incontro e ci offre una rivoltella ciascuno. «Badate, ve la consiglio, quasi tutti i corrispondenti ce l’hanno, chiunque porti l’uniforme è un bersaglio: i nordvietnamiti non fanno prigionieri. Se dovete crepare, tanto vale che vendiate cara la vostra pelle.» E sembra molto sorpreso, anzi offeso, quando gli rispondiamo «no, grazie». Povero tenente. Ha due baffetti cretini su un muso di topo, e un elmetto che sembra nato con lui. Infatti non lo vedremo mai senza e un giorno gli chiederò se ci dorme. È addetto alla stampa, nella tasca dei pantaloni tiene una scatola di fotocolor che mostra a ogni nuovo arrivato: la sua fidanzata in camicia da notte e senza camicia da notte. La mostra anche a me, è una bionda cicciuta con due grossi seni, mi spiega che la fotografò durante una licenza a Honolulu. Parlando ci conduce alla tenda dei giornalisti ma prima di entrarci faccio in tempo a vedere due MP che trascinano un soldatino giallo in uniforme kaki. Cammina perché lo sostengono, ha i piedi scalzi, la bocca aperta e le palpebre chiuse. Ha sì e no diciott’anni, lo hanno preso stamani sulla collina 1383, era svenuto di fame e di sete. «Dove lo portano,» chiedo «all’infermeria?» «No, no,» spiega il tenente «lo portano all’interrogatorio e poi ad incidere un disco da trasmettere con l’altoparlante sulle colline.» «E cosa inciderà su quel disco?» «Inviterà i suoi compagni ad arrendersi.» «E se lui non vuol farlo?» «Oh, lo farà, lo farà.» Il prigioniero inciampa, gli MP lo sollevano, e per un attimo i suoi piedini nudi pendono giù grotteschi. Forse fu lui a ordinare la giacca ricamata che vidi da un sarto a Saigon. Il ricamo diceva: «Quando morirò andrò in Paradiso perché su questa terra ho vissuto all’Inferno. Vietnam, 1967». Però era una giacca americana. E le parole ricamate, in inglese.
Dieci piloti partono ne ritornano due
LUNEDÌ NOTTE. La sensazione che hai in questo campo è d’essere chiuso in un pozzo, cioè in trappola. Le colline dei nordvietnamiti ti circondano proprio a raggiera e solo tre sono in mano degli americani: la 1383, la 1121 e la 1089. Notte e giorno sei esposto al fuoco dei mortai, dei razzi, questo buco a trenta centimetri dalla nostra tenda lo ha fatto stamani un mortaio. Veniva dalla collina 875, quella che non riescono a prendere: la notte scorsa la 173a airborne aveva l’ordine di arrivarci in cima a ogni costo ma l’attacco è fallito. Ho parlato col pilota di un elicottero, quasi piangeva. M’ha raccontato che gli uomini sono ammassati in un perimetro angusto da cui non possono andare né avanti né indietro: i nordvietnamiti li circondano da tutte le parti, sono dietro a ogni albero. In quel mucchio di carne umana vi sono almeno cento morti e altrettanti feriti, nel buio gridano supplicando acqua e morfina. Il sole decompone i cadaveri, molti feriti muoiono dissanguati; evacuarli è impossibile. Dieci elicotteri ci hanno provato, otto sono stati abbattuti, questo pilota è uno dei due che son riusciti a tornare. «Capisce, non ci si muove che con gli elicotteri in questa giungla maledetta. Il terreno è troppo ripido, pieno di bambù e di liane, per far cento metri ci si mette due ore, e i nordvietnamiti vi si muovono invece come i gatti.» «E i sudvietnamiti dove sono?» «Non ci sono. Chi li ha mai visti? Ci sono solo americani a Dak To.» I soldati al campo hanno un’aria cupa, arrabbiata. Mi sono affacciata a una tenda e un portoricano gridava: «Questo lo zio Sam non ce lo aveva detto. Devi combattere il comunismo, gracchia lo zio Sam. Io cosa sia questo comunismo non lo so, e non me ne frega un corno di saperlo, e non me ne frega un corno dei dannatissimi vietnamiti. Se lo combattano da sé il comunismo, non c’è neanche un sudista qui fra noi. Sì, aveva ragione mio padre quando si arrabbiò perché andai volontario. Mio padre è un operaio e sai che ti dico? Sono sempre i figli degli operai che vanno a morire alla guerra». Gli è saltato addosso il caporale e ha urlato: «Hector, chiudi il becco!». Ma Hector ha continuato a sfogarsi e io sono uscita. Ero alla mensa quando è suonato l’allarme.
È suonato quando i primi colpi di mortaio erano già caduti sul ponte e sulla pista. Sono scappati tutti rovesciando i vassoi, i bicchieri di tè, e sono scappata anch’io, con Moroldo, ma era molto buio e il bunker non si vedeva. Si vedevano solo sagome nere che correvano dandosi spintoni e ripetendo: «I mortai, i mortai». A ciascuno chiedevo: «Il bunker, dov’è il bunker?» ma nessuno mi rispondeva. Si diventa egoisti alla guerra. L’artiglieria intanto s’era scatenata con un lancio di razzi, il cielo bruciava fiammate rosse in fuga verso le colline, non distinguevi più tra i colpi in arrivo e i colpi in partenza, d’un tratto una mano ha afferrato il mio polso e una voce ha detto: «Viens avec moi». Era François Mazure, un collega francese, con lui e Moroldo mi son tuffata in un bunker pieno di soldati cadendoci a capofitto. Siamo rimasti un’oretta nel bunker, i soldati ogni tanto accendevano un fiammifero sotto la mia faccia per vedere se fossi davvero una donna. I loro discorsi erano interessanti: parlavano esclusivamente di quelli che sono riusciti a evitare il Vietnam. Quando l’allarme è cessato ci hanno detto che il ponte era quasi distrutto e che si temeva un contrattacco sulla collina 1383. Domattina ci andremo, intanto cerchiamo di dormire. Di giorno fa caldo, di notte fa freddo, ma il peggio è che le brande sono tutte occupate e bisogna dormire per terra. Qualcuno mi ha dato il suo sacco a pelo ma per terra i colpi di cannone rintronano come legnate sul ventre. Nel sonno sento Moroldo che brontola: «E spara e spara e spara. Ma quanto costa ogni colpo? Mezzo milione? Un milione? Come sono ricchi gli americani. Io, la guerra agli americani, non gliela farò mai».
Una bomba da 300 chili ha fatto un massacro
MARTEDÌ MATTINA. Si chiama Pip, ha ventitré anni, un volto buono e arguto, un fucile, una Leica e un blocco di carta col lapis. È addetto al servizio informazioni della 4a divisione fanteria e sarà lui a portarci sulla collina 1383. Gli andiamo incontro ridendo, ci siamo svegliati contenti, com’è bello essere vivi. Se imparassimo a esser contenti per il semplice fatto d’essere vivi. Capiremmo perfino il piacere di lavarsi la faccia con un bicchiere d’acqua, l’altro bicchiere è pei denti, e pazienza se nell’uniforme ci hai dormito e sudato, se il sacco a pelo puzzava, se trovare un gabinetto è un regalo. Il generale Peers m’ha offerto l’uso del suo gabinetto che è una scatola di legno su cui è scritto «Privato», ma tutte le volte che provi ad andarci c’è lui. Al terzo tentativo l’ho sorpreso sotto la doccia che si insaponava. «Oh!» ha esclamato arrossendo e non si capiva a guardarlo perché tutti ne abbiano tanta paura. Così nudo e indifeso non sembrava davvero il demonio che nell’ultima guerra mondiale terrorizzava i giapponesi della Birmania, ancor meno sembrava il grande stratega che da venti giorni manda i ragazzi a morire e ogni sera ripete: «Stanotte la collina 875 sarà nelle nostre mani». Uscendo senza scarpe scansava i sassolini come fossero spilli. L’ho raccontato a Pip che continua a ripetere: «Devi dirlo al capitano Scher!». Il capitano Scher è colui che ha conquistato le tre colline e Pip sostiene che se la 875 fosse toccata a lui non sarebbe successo quello che è successo. Sulla 875 la situazione sta facendosi ancora più tragica. Stamani i Phantom bombardavano i bunker dei nordvietnamiti, uno ha sganciato troppo presto una bomba e anziché sui nordvietnamiti la bomba è caduta sul perimetro degli americani. Era una bomba da trecento chili, ha fatto un massacro.
Be’, per dirmi questo Pip ha indugiato un po’ troppo e l’elicottero su cui dovevamo salire è partito. Dobbiamo attenderne un altro e, quando arriverà, ci diranno: «Chi di voi tre porta bene? L’elicottero che avete perduto è precipitato per una raffica di mitra alla pala».
«Sono andato volontario, poi me ne pentii subito»
MARTEDÌ MEZZOGIORNO. Ci si abitua a tutto, anche a non stupirsi perché la morte t’è passata accanto senza vederti. Ci si abitua a saltare sull’elicottero che non ha nemmeno una cintura alla quale legarti sicché quando vira devi stringere forte un appiglio sennò scivoli giù. Ci si abitua a volare rasente i boschi da cui i vietcong sparano. Ci si abitua ad affacciarsi mentre il mitragliere risponde al fuoco. Ci si abitua a non battere ciglio dinanzi alla desolazione, l’orrore. Non sono rimasti che mozziconi anneriti di alberi su questa collina. Si levano contro il cielo in mille schegge che sembrano dita tese a chieder pietà e intorno a essi vedi solo buche, voragini, trincee, bunker coperti da sacchi di sabbia, uomini dall’espressione sbalordita, il passo incerto. Ci siamo calati nel punto dov’è appostata l’artiglieria. Nel recinto dei mortai stanno tre ragazzini vestiti da soldato. Quello che infila gli obici ha due occhi tristi che spaccano il cuore. «Larry, ti ho portato un pacco» gli dice Pip. «Vengo subito» risponde Larry. Infila un’altra granata nella bocca del mortaio, si inginocchia appoggiando la testa bionda alla canna e: «3048, uno-due, fuoco!». «Larry!» insiste Pip. «Un momento» dice Larry «3049, uno-due, fuoco!» Poi cede il posto a un altro e prende il pacco che viene dalla zia Dolores di Kansas City e contiene pop-corn, burro di noccioline, torroni ma soprattutto caramelle perché a Larry piacciono le caramelle. Le mangiamo insieme, seduti sul tronco di un castagno. «Larry, ma è vero che sei volontario?» «Cosa vuole, eran tre anni che il Vietnam incombeva su me, alla fine mi dissi: meglio andar volontario, o la va o la spacca, se va e se ritorno mi becco un congedo di centocinquanta dollari al mese. Mi pentii subito di aver fatto quello che avevo fatto. Ma ormai lo avevo fatto. I miei genitori si arrabbiarono molto, la mamma piangeva. Mi sembra un secolo, e fu solo tre mesi fa. Tre. Ho ancora nove mesi da passare qui. Lei crede che ce la farò? A volte ho paura di no. E prego, sa, non faccio che pregare. Prego anche quando n...