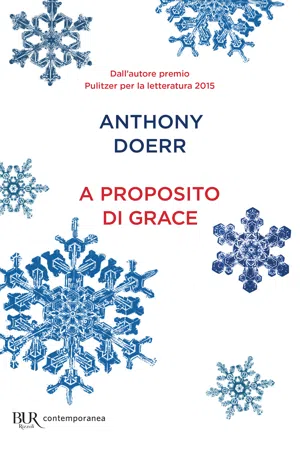![]()
LIBRO SESTO
![]()
1
Prese l’autobus numero 2 con un completo nuovo addosso e una cheesecake incartata in mano. Nei pantaloni si era perso, da qualche parte della cintura, il filo di plastica che aveva retto il cartellino del prezzo e che ora gli pungeva il fianco a intervalli regolari. Scese sulla Quindicesima Avenue e tirò fuori di tasca una piantina strappata da un elenco telefonico.
Cinque traverse verso sudest. Il traffico sibilava invisibile sulla A Street. Era pomeriggio, il cielo era grigio e i palazzi di abitazioni sembravano perlopiù vuoti: chi ci abitava era al lavoro o magari non c’era proprio più. Di tanto in tanto si vedeva una villetta ben tenuta, con tulipani o lillà sul davanti, ma era soprattutto un quartiere di gente in affitto: complessi in legno eretti su colmate, o case Sears da scatola di montaggio mollate lì decenni prima da tecnici degli oleodotti o delle ferrovie, mai ristrutturate dopo il progetto iniziale, e qualcuna ancora con l’isolamento in crine di cavallo o carta di giornale visibile tra le assicelle mancanti.
Se mai era passato da questi marciapiedi, sicuramente non se lo ricordava. Quasi tutto della città gli pareva nuovo: come la muffa, Anchorage si era sviluppata e allargata, era strisciata su per Hillside, si era ammassata intorno ai laghi, le strade si erano ispessite fino a diventare autostrade, le zone industriali si erano addentrate fra i pantani. Veicoli impolverati aspettavano accesi in lunghe file ai semafori, palazzi di vetro di uffici stavano accovacciati in ampi parcheggi. Al cinema sulla Quarta Avenue, dove erano soliti vedersi lui e Sandy, non davano più film: la sala era diventata una tavola calda per turisti, l’atrio un museo che non interessava a nessuno.
Ma c’era anche quel vecchio odore, che si sollevava nella scia di un camioncino per le consegne, o di un lieve vento di mezzanotte, o dallo sgocciolio e gorgoglio dell’acqua piovana nei canaletti di scolo: una fragranza di brecciolino e sale e benzina, di alberi e neve mezza sciolta, l’odore dell’Alaska in aprile. Era il posto in cui era cresciuto: gabbiani che planano sopra le strade del centro, il mare che ribolle su per il Turnagain Arm.
Il 208 della Sedicesima Est era costituito da cinque casette a schiera a un piano, rivestite di assi. L’appartamento C era al centro. Gli altri residenti tenevano sui davanzali cactus, trichechi di giada e magnolie in vaso, e sedie in resina nei prati con le erbacce sul davanti, ma l’appartamento C no: aveva solo le tapparelle abbassate e la porta chiusa. Uno zerbino intrecciato, semplice. Il portico non era spazzato.
Sotto una siepe era finito un giocattolo: una mazza da baseball di plastica rossa, comicamente rigonfia in punta.
Di fronte c’era un giardino pubblico zeppo di denti di leone, con giochi per bambini, altalene a due posti e un cartello che diceva: PARCO GIOCHI RANEY. Winkler vi si ritirò con la cheesecake in mano e si sedette sull’altalena di sinistra, fuori vista dalla porta, ma con una buona visuale sulle siepi e su ingressi e finestre degli appartamenti da un lato, l’A e il B.
Il filo di plastica gli infilzava l’anca; si sentiva a disagio. La torta che teneva in grembo guadagnò lentamente peso fino a diventare un macigno, una scatola di pasticceria piena di mercurio. Non riusciva a distogliere lo sguardo dalla mazza giocattolo adagiata tra le siepi; la torta gli stava conficcando i piedi nel terreno.
Una C sulla porta, dietro la quale vivevano sua figlia e suo nipote. Era incomprensibile.
Il furgoncino di un lavasecco, dai parafanghi arrugginiti, passò rumoroso. L’altalena cigolava. Con la mente ripercorse le Grace Winkler che aveva conosciuto: New Jersey, Virginia, Tennessee, New Messico, Boise. La Grace con i sanbernardo; la Grace con i pappagalli. Ci sono molte Grace Winkler e sono tutte la vera Grace Winkler, e in questo senso il suo viaggio non avrà mai fine. Jed aveva ragione.
Eppure, dall’altra parte della strada, dietro quella porta, c’erano una figlia e un nipote che non aveva mai conosciuto. Poteva essere una specie di finale, forse?
Ancora un minuto e l’avrebbe fatto. Si sarebbe alzato dall’altalena con un colpo di reni e avrebbe suonato il campanello. Forse lei avrebbe mostrato disinteresse, o perplessità; forse – anzi, quasi certamente – rabbia. Forse l’avrebbe abbracciato; forse gli avrebbe sussurrato: Finalmente.
Il cielo si abbassava adagio. Le api attingevano ai denti di leone ai suoi piedi. Winkler si trascinò dall’altra parte della strada. L’altalena oscillò alle sue spalle.
La cheesecake aveva un peso incredibile. Le scarpe lasciavano orme bagnate sul marciapiede. L’erba del giardinetto di Grace era alta e floscia: provò l’impulso di noleggiare una motozappa, eliminare l’intero prato e ricoprirlo di zolle nuove. Almeno poteva regalarle quello: strisce curate di erba verde scuro.
Una kitcar imboccò la via con i subwoofer a tutto volume. La metà in vetro della porta esterna di Grace tremò. A lui salì l’adrenalina in petto. Si chinò sui gradini della veranda e posò la torta sullo zerbino. Il campanello era a un braccio di distanza. Adesso suonava. Non ci riuscì. L’automobile rallentò in fondo alla strada e proseguì.
Le braccia gli pendevano ai fianchi, inservibili. Indietreggiò. Una volta raggiunto il marciapiede dovette imporsi di non correre.
Casa di Naaliyah era un appartamento di quattro locali, al secondo dei tre piani di un cubo di legno che si chiamava Camelot Apartments. Oltre alla camera da letto c’erano una cucina, un bagno chiazzato di funghi e un soggiorno non più grande di uno sgabuzzino, dominato da un divano in velluto a coste arancione.
Lei teneva la maggior parte degli insetti in un laboratorio all’università, ma ce n’erano venti o venticinque teche impilate sui ripiani della cucina; le aveva svuotate e ripopolate, superstiti dello Yukon-Charley che fraternizzavano con le nuove reclute: scarafaggi delle cortecce, punteruoli dei cavoli, bruchi di Erebia in diverse fasi di sviluppo.
«Risparmia qualche soldo» gli aveva detto. «Non c’è problema. Aspetta finché non ti torna la voglia di muoverti. Tanto io non ci sto mai.» Il che si rivelò vero: se n’era andata quasi immediatamente, diretta al campus su una bicicletta azzurra arrugginita, e trascorreva i giorni e gran parte delle notti in biblioteca china sui suoi dati, o in riunione con il professor Houseman, o acquattata davanti a un cespuglio con la lente tascabile, a osservare le goffaggini e le afflizioni degli insetti primaverili.
Lui passava le notti sul divano, con i pochi indumenti piegati in una pila sul termosifone. Fissò col nastro adesivo le diciannove foto di cristalli di neve che gli restavano lungo il muro sopra il divano. Le sue conchiglie di neritina trovarono posto sulla modanatura sopra la finestra. Naaliyah gli aveva lasciato lo Stratalab – «Nessuno ne sentirà la mancanza» aveva detto – e lui lo teneva in bilico sul largo ripiano della boiserie a metà parete.
Le prime notti erano state le più difficili: i fanali lungo il Northern Lights Boulevard, gli occasionali belati dei clacson, i passi sul soffitto. Era dall’infanzia che non tentava di dormire in un posto così rumoroso: ogni volta che il vicino di sopra tirava lo sciacquone, l’intero appartamento di Naaliyah riverberava del suono, un’esplosione d’acqua, tubi che trangugiavano tutto a neanche mezzo metro dalla sua testa. Aveva incubi in cui si trovava di nuovo nella cuccetta dell’Agnita, con il divano arancione che straorzava tra le onde, l’oceano che da tutte le direzioni spingeva contro le mura della casa.
Di fronte stavano costruendo un centro commerciale; i muratori avviavano la betoniera prima delle cinque, e c’erano lo sferragliare costante della catena e i tonfi del cemento che ci veniva rimestato dentro. Lui si svegliava, fissava il soffitto e ascoltava: un frastuono non dissimile da quello del suo cuore, che si rigirava su se stesso senza posa.
Si radeva, si faceva la doccia due o tre volte al giorno; l’inverno non se ne andava dalle ossa, dal midollo. Gli colavano gli occhi e si doveva tenere aperte le palpebre con le dita. Certe mattine gli ci volevano due o tre minuti per tirarsi fuori dal divano e mettersi in piedi.
Mangiava pompelmi, pere, una volta addirittura mezzo chilo di formaggio muenster. Le varie sensazioni del succo d’arancia freddo sulla lingua lo distraevano anche per un quarto d’ora.
Studiava lo stradario delle pagine gialle, lanciava occhiate fuori dalle persiane come un ricercato. Magari Grace era lì, o là; magari era quella che scendeva dalla Plymouth, issando la busta rossa della lavanderia dal bagagliaio; poteva essere quella in scarpe da ginnastica con le calze bucate; o quella che correva, in legging e reggiseno sportivo, le cuffie sulle orecchie.
Trovò un lavoro. Aveva preso un autobus fino al centro commerciale della Quinta Avenue per farsi fare un paio di occhiali come si deve e lì aveva notato un cartello: cercavano un tecnico di laboratorio. Il negozio si chiamava LensCrafters. La direttrice, la dottoressa Evans – un’ottica tondetta e capellona in camice e occhialini d’argento – si mostrò perplessa quando nel modulo per la domanda vide il dottorato, e manutenzione alberghiera tra le esperienze lavorative, ma disse che aveva bisogno urgente di una persona, e dopo una breve telefonata a qualcuno «in azienda», assunse Winkler su due piedi.
«Però» disse «deve scegliere una montatura diversa. Bisogna che i nostri impiegati indossino le più attuali. Lei capisce.» Lui capiva, e ne scelse una di Calvin Klein in acrilico nero e miele, modificata per ospitare le sue lenti spesse. E anche un collirio: se lo doveva versare sui globi oculari quattro volte al giorno. Miopia patologica, sentenziò la donna, il che significava che la sua vista sarebbe continuata a peggiorare e che lui avrebbe fatto meglio a non guidare, un’informazione per cui non gli serviva pagare 243 dollari. Le lenti erano così spesse che quando batteva le palpebre ne sfiorava l’interno con le ciglia.
Ricevette la formazione da Gary, un diplomato ventitreenne. Di giovedì, venerdì, sabato e domenica Winkler avrebbe telefonato ai clienti, inventariato montature, archiviato prescrizioni, riordinato materiali e trascinato scatoloni fino al cassonetto sul retro. (Quest’ultimo compito sarebbe diventato il suo preferito: si riposava dopo aver appiattito i cartoni con i piedi e guardava il cielo, dove passava qualche cirro sopra il vialetto del centro commerciale.) A pranzo prendeva l’ascensore fino alla zona ristorazione del quarto piano e mangiava da Thai Town o da Subway a un tavolo infilato tra i vasi di piante tropicali guardando, oltre gli adolescenti che ciondolavano in giro, la piccola fontana piena di monetine dove un salmone di rame sputava acqua in una vasca piena di cloro.
Ormai era quasi maggio e il pomeriggio c’erano ragazzini ovunque. Gli scuolabus passavano gemendo davanti a casa di Naaliyah, zeppi di facce dietro i finestrini.
Prese altre due volte il 2, di tardo pomeriggio, percorse le cinque traverse fino al parco giochi Raney e si sedette sull’altalena, in giacca e cravatta. «Potrai mai…?» chiedeva mormorando. «Credi che ce la farai a…? Dici che noi due…?»
Portò una torta alla ciliegia; portò una torta alla panna decorata con scagliette di cioccolato bianco. Ogni volta diventavano pesanti come macigni; ogni volta le lasciava sullo zerbino senza un biglietto, senza sfiorare il campanello.
Dopo di che, il lungo viaggio di ritorno giù per Lake Otis Parkway verso casa di Naaliyah. Dopo di che, le due traverse da mezzo chilometro l’una, sotto la pioggia, fino a Baxter Road, superando la struttura buia del futuro centro commerciale con i teloni di plastica che si gonfiavano e gocciolavano, e gli schizzi delle automobili degli studenti, delle infermiere, dei gruppetti che usavano una macchina in comune, delle madri lavoratrici. Poi, ripassando sotto l’architrave del Camelot, le scale con la passatoia inchiodata e tutta lisa, l’estintore impellicciato di polvere in corridoio, l’intonaco dalle strane venature nella tromba delle scale, e in alto la lampadina nuda con i suoi festoni di ragnatele.
![]()
2
Dodici giorni dopo il suo arrivo ad Anchorage, Winkler comprò un mazzo di narcisi e andò in taxi alla Heavenly Gates Perpetual Care Necropolis, poco più di venti chilometri a nord della città sulla Glenn Highway, verso Palmer. Tutto un altro cimitero, diceva la pubblicità nell’elenco telefonico. Un progetto «polvere ritornerai». Ecosostenibile. Niente cripte di metallo, niente agenti chimici per conservare i corpi, molti spazi aperti.
Le nubi erano così sottili che il cielo era di un bianco bruciante, doloroso. Winkler teneva gli occhi bassi. Superato l’ufficio alloggiato in un autotreno, un inserviente con la chioma grigia che pareva una nuvola e le unghie sporche gli sorrise e gli porse un pieghevole ciclostilato, qualcosa sull’importanza karmica di comprare un albero da piantare sopra la persona amata. Accanto alla sgangherata sedia a sdraio dell’inserviente c’era una borsa termica dei Seattle Mariners e un’enorme terranova grigia. Winkler si chinò a farle una carezza e lei gli inondò la mano di saliva.
L’elenco delle sepolture era un libretto inguainato in una busta di plastica come la pagella di una scuola media. Trovò facilmente il nome: Sandy Winkler, riquadro 242.
L’inserviente glielo aveva già contrassegnato su una cartina dai tratti fumettistici, e Winkler si incamminò. Le ombre delle lapidi si tenevano strette alle rispettive basi come soggiogate dallo spavento. Ci saranno state trecento tombe all’aperto, sparse sul versante di una collina, e un piccolo colombario fatto di tronchi scortecciati. Alcune sepolture erano contrassegnate da pietre o croci, altre da totem o case degli spiriti: capannette alte fino alla vita, simili a cucce allungate, dipinte in colori vivaci.
Le tombe erano adornate con bandiere statunitensi, o corone di plastica, o anche niente. Al centro esatto di vari riquadri erano piantati giovani alberelli: pioppi tremuli, abeti rossi, qualche sanguinella. Appeso al ramo di un arboscello c’era un biplano fatto con pezzi di lattine di Budweiser, che ruotava lentamente intorno al suo appiglio di filo di nailon.
La tomba di Sandy era semplice e pulita. La lapide era di granito e riportava il suo nome e le date della vita. Dalla posizione in un angolo alto del terreno, che sovrastava l’entrata, l’ufficio, il piccolo taxi bianco e rosso che lo aspettava e l’autostrada, e più oltre le colline in lontananza che si aprivano nella valle del fiume Eagle, era chiaro che chiunque l’avesse scelta aveva agito bene, e che Sandy ne sarebbe stata contenta.
Winkler rimase sulla tomba per vari minuti. Non versò lacrime; formulò pensieri sorprendentemente vacui e banali. Le rondini svolazzavano avanti e indietro, cibandosi di moscerini.
Quando pensava al cancro vedeva una gola nera; vedeva inchiostro che impregnava un tovagliolo; marciume che mangiava un albero da dentro. Avrebbe voluto chieder...