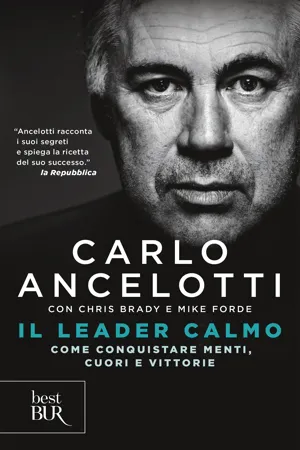![]()
PARTE SECONDA
Il core business
![]()
Introduzione
di Chris Brady
Il 21 giugno del 1999 la rivista «Fortune» uscì con una copertina che si chiedeva: «Perché i CEO falliscono?». La risposta, semplicissima, era: perché concludono poco. Il reportage spiegava come alcuni leader del business mondiale fossero troppo focalizzati su «strategie, missioni e idee», prestando un’attenzione insufficiente ai risultati (ovvero ignorando i colleghi che li criticavano perché portassero questi benedetti risultati). Come puntualizzò in poche parole Herb Kelleher della Southwest Airlines: «Troppe strategie, pochi fatti. La nostra strategia: concretizzare fatti».
Quando Lou Gerstner arrivò all’IBM con l’incarico di riportare ordine nel caos lasciato dal CEO uscente, rilasciò la famosa dichiarazione: «L’ultima cosa di cui ha bisogno l’IBM ora come ora è un’idea». Gerstner licenziò pochi membri senior dello staff – un gesto molto significativo –, ma sostituì il capo delle risorse umane. Capì, insomma, che i CEO hanno successo se sono interessati alle persone. Come concludeva anche il reportage di «Fortune»: «Il motto di un amministratore delegato di successo? Prima le persone, poi le strategie».
Ho passato dieci anni a studiare come si recluta personale. I risultati sono stati pubblicati nel 2007 nel libro scritto insieme a David MacLeod The Extra Mile. La nostra conclusione fu che concentrarsi sui fatti e scegliere manager che operino in base al mantra «prima le persone, poi le strategie» sono fondamentali per il successo, in qualunque settore. Poi, studiando il core business del calcio – quello che succede in campo –, è stato bello scoprire che Carlo Ancelotti e la sua filosofia di leadership calma costituiscono l’incarnazione di queste convinzioni. Perché Carlo, per scelta, è sempre interessato e attento alle persone che guida.
La nuova, attuale politica del mondo del calcio sta distruggendo il talento, tanto quello dei giocatori quanto quello degli allenatori; averlo capito e saper gestire questo dato di fatto con dignità è una delle peculiarità di Ancelotti. Quando dilagarono le speculazioni sul suo futuro al Real Madrid, in una conferenza stampa Carlo rispose così a chi chiedeva cosa ne sarebbe stato di lui:
Io vorrei restare, ma non so se la prossima stagione sarò ancora qui… Non sta a me darmi un voto per quest’anno, sta ad altri. So benissimo come funzionano le cose nel calcio. Io non devo parlare. Se la società è contenta, potrò continuare; se non lo è, prenderà la sua decisione. Un club ha il diritto di cambiare allenatore, se non è contento.
Non lo disse per spavalderia o per confondere le acque, fu una dichiarazione sincera. Ancelotti è consapevole, probabilmente meglio di qualunque altra persona che fa parte del business più spietato del mondo, di quanto sia precario il posto di chi opera in un’industria basata sul talento.
Coloro che sono ancora restii a considerare il calcio come un’industria dovrebbero riascoltare con attenzione le parole del direttore sportivo del Real Madrid, José Ángel Sánchez, che dichiarò: «Noi siamo dei content producers». In altre parole, il Real Madrid e altri giganti dello sport moderno sono diventati industrie commerciali con squadre in allegato. Un format confermato da altri nomi noti, sia degli affari sia dello sport. Thomas J. Watson, fondatore dell’IBM, una volta disse: «Gli affari sono un gioco, il più grande gioco del mondo, se sai come giocare»; Clive Woodward, l’unico allenatore che è riuscito a vincere i Mondiali di rugby con l’Inghilterra, a sua volta la mette in questo modo: «Tra la guida di un’azienda di successo e quella di una squadra sportiva il parallelismo è totale, le abilità richieste sono le stesse». Insomma, il calcio è davvero il modello per eccellenza delle industrie moderne basate sul talento.
La prossima sezione comprende le riflessioni di Carlo su tutti gli aspetti del core business, dalla cultura alle responsabilità, dalle gerarchie all’assetto dell’ambiente di lavoro, dalla gestione del talento alla creazione del prodotto e, infine, all’anticipazione dei fattori analitici e psicologici che in futuro costituiranno dei vantaggi competitivi.
![]()
2
La cultura
La famiglia
Niente è più importante della famiglia. Nel calcio ci sono due forme di famiglia: il gruppo ristretto del mio staff, persone con cui ho lavorato nel corso degli anni condividendo periodi buoni e meno buoni, persone di cui mi fido ciecamente e che rispetto. Sono loro la mia famiglia calcistica, e ne parlerò tra poco. Poi c’è il club che mi ingaggia, concepito anch’esso come una famiglia.
Come ho già detto, quando diventai l’allenatore del Milan per me fu come tornare a casa. Nonostante si tratti di una delle squadre più importanti del mondo, il club in sé è strutturato come una famiglia. A Milanello ognuno ha la sua stanza, compreso il magazziniere: sono tutti lì da un sacco di tempo. C’è un ristorante, e non è a buffet come quello del Chelsea o del Real Madrid, ma un ristorante vero, con un cameriere che arriva al tavolo e ti parla come un amico. I camerieri di Milanello spesso sono persone anziane – anche loro sono lì da parecchi anni – e l’atmosfera è molto alla mano. Quando cominciai a darmi da fare per migliorare l’ambiente al Paris Saint-Germain, aprire un ristorante fu tra le priorità. Proprio il mio periodo al Milan mi aveva insegnato quanto fosse importante per i ragazzi mangiare insieme, perché diventassero un gruppo. Volevo ricreare a Parigi la stessa atmosfera familiare di Milano, e i pasti comuni per questo obiettivo sono fondamentali. È così che mi piace intendere la cultura del club, e sono convinto che questo tipo di clima sia indispensabile per vincere.
Dal tecnico al magazziniere, ognuno ha bisogno di sentirsi parte di questa famiglia e di lavorare verso obiettivi condivisi. La chiave del successo, per ogni organizzazione, è allineare tutti nella stessa direzione. I giocatori sono membri essenziali, e se remano contro questo spirito è un problema, ovvio. Rientra nel mio lavoro far sì che i valori familiari, qualsiasi essi siano, vengano onorati e rispettati.
Al Milan, una società che conoscevo bene, in cui ero stato un giocatore importante, per me fu facile, e a volte penso che il problema, al limite, avrebbe potuto essere che in molti si sentissero troppo grati nei confronti di una persona che aveva significato tanto nella storia del club.
La cultura del Milan era dunque questa, modello famiglia. In altre società può essere diverso. La Juventus, ad esempio, per me fu come un’azienda, e in questi casi le relazioni con i superiori sono più formali. Nei miei anni alla Juve non c’era un centro sportivo di proprietà con le relative facilities; insomma non avevamo una “casa”. La mia esperienza a Torino resta comunque positiva, anche se i risultati non furono all’altezza, purtroppo non sempre è possibile controllarli. Che non significa, però, che il mio rapporto con la squadra non fosse buono. Le cose che potevo controllare funzionavano. I tifosi forse non saranno d’accordo, e infatti loro sono un’altra variabile che non posso controllare.
È importante che l’allenatore calzi con il club dal punto di vista culturale, il suo lavoro è essere un esempio vivente di questa cultura, ne deve mantenere alti gli standard e fare in modo che vengano rispettati all’interno di tutta l’organizzazione. Tra me e il Milan c’era da sempre una sintonia naturale, con la Juve no. L’ambiente di Milanello era tagliato su misura per me, per quello che sono, e lavorare in un’atmosfera affine alla propria personalità è più facile, chiaro. Il guru del business Peter Drucker una volta disse che «la cultura la strategia se la mangia a colazione», e io sono d’accordo con lui. Sì, si può arrivare al successo anche se manca questa empatia culturale, ma spesso è un successo passeggero, difficile da mantenere.
Ovunque io vada, resto sempre me stesso. La mia personalità e il mio stile non cambiano, e in fondo è per questo che mi ingaggiano, per quello che sono. Quando arrivo in un nuovo club ci vuole un po’ per creare l’atmosfera che desidero, creare la famiglia. Perciò a volte il primo obiettivo è diffondere questo spirito, se non esiste già. Il Chelsea, ad esempio, era più un’azienda, come la Juve, ma vidi delle possibilità di costruirci una famiglia.
Quando s’ingaggia un leader è fondamentale che la persona che lo arruola sappia esattamente che compito intende affidargli: mantenere la cultura già esistente o fondarne una nuova? Si è detto, ad esempio – cosa interessante –, che Sir Alex Ferguson fosse stato arruolato per far rivivere una cultura che al Manchester United era svanita. E lui lo ha fatto, ha avuto un successo duraturo rinsaldando di continuo questa cultura, con costanti riferimenti alla storia e alla tradizione del club.
Certo, perché si crei questa sintonia può essere anche che l’allenatore faccia cambiare l’approccio del club, ma è più facile il contrario, ovvero che sia il coach a sintonizzarsi: a meno che, ovvio, la stessa società non voglia un grande rinnovamento o ci siano buoni motivi per abbandonare le vecchie convinzioni. Se, ad esempio, un importante club vuole spezzare il monopolio del suo più grande rivale e crede che l’unico modo sia assoldare un allenatore che ha già avuto successo altrove, può decidere di ignorare il fatto che questi non sia molto in sintonia con la cultura societaria, perché la priorità assoluta è vincere. Quando il Real scelse me sapeva che sarei stato in grado di adattarmi, ma anche che ero abbastanza affine, per natura, allo stile che Florentino Pérez desiderava far risorgere. Per lui il concetto di galácticos restava cruciale, e credeva che la mia capacità di stabilire relazioni con i giocatori fosse fondamentale per gestire le diverse esigenze dei personaggi di forte personalità e di alto profilo dello spogliatoio.
Pérez aveva ragione. Tuttavia, il problema è che le società raramente fanno colloqui sufficientemente approfonditi e scrupolosi per sapere tutto del candidato in esame. Il presidente del Real prese la decisione giusta scegliendo me, ma nel calcio non si può mai dire. Nella mia carriera c’è stato un solo club – a parte il Milan, che già mi conosceva – in cui mi hanno chiesto: «Come alleni? Come lavori con i ragazzi? Qual è il tuo stile di allenamento? Se si creasse la situazione X o la situazione Y, tu come ti comporteresti?». Mi riferisco al Chelsea. Prima della firma ci furono dieci incontri, e secondo me è questo il modo giusto di procedere. Tutte le società dovrebbero tenerlo a mente, invece nel calcio è un’eccezione.
I fan di Pep Guardiola e di Béla Guttmann – leggendario allenatore ungherese – sostengono che il ciclo naturale di un coach duri tre anni, e la mia esperienza di parabole della leadership, tranne che in un caso, lo conferma. A volte, però, tecnici, giocatori e impiegati trovano una seconda casa. Valeriy Lobanovsky alla Dinamo Kiev, Sir Alex Ferguson al Manchester United, Arsène Wenger all’Arsenal, io al Milan: in questi casi il rapporto può durare ben più di tre anni. L’allenatore, appunto, trova una casa e il club la sintonia culturale giusta. Alcuni dicono che questo tipo di longevità non si ripeterà più e alla luce delle politiche attuali non è difficile capirne il motivo, ma se un coach riesce a imbattersi in un ambiente che gli calza a pennello e la società ricambia questa armonia, chi può dire dove possono arrivare?
Cultura internazionale
Ho allenato grandi squadre in tutta Europa, gruppi di giocatori e staff estremamente diversi e di varie nazionalità. Lavorare in un ambiente simile pone sfide uniche dal punto di vista linguistico. Certo, si può dire che l’idioma in comune sia il calcio, ma è altrettanto importante parlare letteralmente la stessa lingua.
In Inghilterra, come anche in Spagna e in Francia, io ero “lo straniero”, così mi sforzai di imparare la lingua del posto. L’ho fatto in ogni club estero che ho allenato e continuerò a farlo, è troppo importante. Ne ho bisogno per comunicare con i ragazzi e con i giornalisti, e anche per dimostrare al datore di lavoro la mia serietà nel volermi adattare alla nuova vita. Imparare la lingua, per me, è un passo imprescindibile per trovarmi bene in una nuova cultura.
Dai giocatori mi aspetto lo stesso, anzi credo sia un metro di giudizio della loro professionalità. Certo, se mi chiedete di scegliere tra uno che segna ogni settimana e uno che impara la lingua del posto scelgo il primo. Alcuni ragazzi sono già abbastanza utili sul campo da non aver bisogno di parole. Tuttavia, io ai miei chiedo entrambe le cose. Il giocatore sarà in condizione di stabilire un rapporto migliore con i compagni e lo staff, e i compagni e lo staff apprezzeranno lo sforzo di adattamento. Questa fatica è anche un indicatore affidabile dell’impegno del ragazzo in questione non solo per fare la differenza in campo, ma anche per evolversi nel nuovo ambiente. Forse è per questo che gli inglesi rendono meno nei campionati stranieri. Tuttavia, se la lingua è stata senz’altro un problema per Gareth Bale al suo primo anno al Real Madrid, la cosa di certo non ha avuto ripercussioni sulle sue prestazioni e con il tempo anche il suo spagnolo è migliorato. Forse Bale è l’eccezione che conferma la regola.
Quando allenavo il Milan volevo che i giocatori parlassero solo in italiano, adesso che in ogni squadra ci sono calciatori di tanti Paesi diversi è più difficile, e spesso i ragazzi tendono a socializzare con i propri connazionali. Al PSG, ad esempio, avevo giocatori italiani e argentini che tra loro comunicavano in italiano, e all’inizio fu un problema, perché i francesi a loro volta parlavano solo francese e si creava una segregazione naturale.
Ecco, questa è una cosa che va messa in chiaro subito con i ragazzi, va fatto loro capire che non possono esserci clan. Io cerco di fare in modo che stiano tutti insieme e parlino tra loro, ad esempio a cena, e se è necessario li cambio anche di posto, perché persone che hanno meno confidenza si ritrovino vicine.
Il trucco è unire il gruppo gradualmente. A Madrid stabilimmo i posti ai tavoli apposta per far integrare meglio i ragazzi, fin dall’inizio. I primi giorni mettemmo il nuovo arrivato Toni Kroos, tedesco, vicino al suo connazionale Sami Khedira, poi però lo spostammo vicino a Sergio Ramos, e così via. L’altra cosa che faccio spesso è organizzare cene di squadra fuori dal ristorante dell’impianto, in modo che i giocatori possano rilassarsi e conoscersi meglio.
Purtroppo non si può fare tutto durante i pasti comuni, e a Parigi il mio obiettivo fu cercare di integrare piano piano i ragazzi pure sul campo, dove passavamo la maggior parte delle ore. Con nonchalance, cercavo di mischiare i gruppi e di formarne di nuovi. Facevo in modo che non fosse un obbligo, ma un suggerimento, un invito: è questa la filosofia del leader calmo. Ho letto alcuni lavori dello psicologo Robert Cialdini, un grande nome della psicologia sociale. Ecco, Cialdini parla dell’effetto che fattori come la costanza, lo scambio e la capacità di farsi amare hanno sulla forza di persuasione, e mi trova d’accordo su tutto.
La dimestichezza dei giocatori e dello staff con la lingua locale è fondamentale per capire in fretta la cultura del Paese e del club. Nel mondo degli affari probabilmente è ancora più importante che nel calcio, dove i giocatori cambiano spesso e il loro rendimento ha poco a che fare con le parole. Quando il business team di una multinazionale deve operare in posti in cui si parlano lingue particolarmente difficili per noi occidentali, come ad esempio il cinese o l’arabo, perfino un anno e mezzo di apprendimento può non bastare. In q...