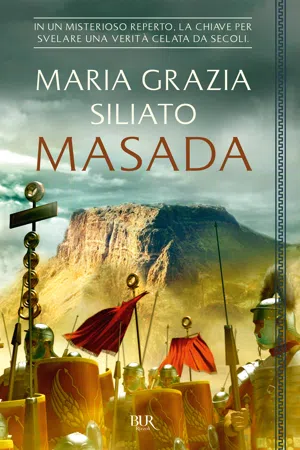![]()
Capitolo sesto
L’assedio di Jerushalem
![]()
A MESADAH, LA PENULTIMA ORA DELLA NOTTE
«Parlaci di Jerushalem» insinuò la ragazza. L’oscurità era sempre più densa, perché nessuno aveva riattizzato i fuochi. Ilan si volse ma non riuscì a rispondere: il solo avere udito il nome della città perduta era diventato un nodo di dolore fisico in mezzo al petto. Un’altra voce di donna, timidissima, arrivò nel silenzio: «Ti prego, parlaci di quell’assedio. C’era mio padre, là dentro». Gettarono uno sguardo agli uomini che tacevano, sprofondati ciascuno per conto suo in una immobilità senza reazioni.
«… era saldamente difesa» incominciò a dire Ilan, e si bloccò. Era davvero una lama di dolore. Due o tre uomini si scossero, girarono intorno al fuoco per avvicinarsi. La ragazza gli si accoccolò più vicino, lo guardò dal basso, lui ricambiò lo sguardo. Intanto le altre donne insistevano, con un affanno incerto, che forse era solo paura del silenzio. Poi anche gli uomini s’intromisero con rudezza: «Racconta…». Dopo i primi vittoriosi mesi di quella guerra, le loro sorti di combattenti o profughi o ribelli clandestini s’erano divise. E poiché la strage in Jerushalem non aveva lasciato testimoni – solo morti o schiavi – nessuno di loro aveva personalmente vissuto lo spaventoso assedio.
Ilan vide gli occhi spalancati delle donne, le pupille scure nella cornea bianca. Si abbandonò, la schiena contro il muricciolo. E in quell’attimo emerse Eleazar: «Parla, Ilan» intervenne. «La mia gente ha diritto di sapere.» Rievocare quella storia per Ilan era come dissotterrare un cadavere da una fossa mal chiusa. Ma Eleazar scattò, con il tono duro del comando: «Parla». Guardò il punto del cielo dove la grande luna di quella notte era intanto arrivata, dichiarò: «So che è una lunga storia, ma abbiamo tutto il tempo».
«Vespasianus aveva agguantato l’Impero» obbedì Ilan, «stava a Roma. Il giovane Titus era rimasto in ozio a Cesarea, con le Legioni.»
E un ufficiale intervenne: «I nostri ridevano della sua storia con la sorella di Agrippa, quella Berenice. La chiamavamo la Regina, ormai».
Un altro commentò: «Alla guerra, il figlio dell’imperatore ha preferito sempre il letto…». Non rise nessuno.
«Per mesi, i Romani non si sono fatti vedere. Molti dei nostri hanno creduto che la guerra non si sarebbe riaccesa.» Era vero: erano tornati i sogni luminosi di un futuro pacifico, tra il mare e le colline verdi del paese liberato. Fra gli Insorti, alcuni avevano suggerito: «Cerchiamo un accordo con Roma…». Altri avevano reagito: «Un accordo da schiavi». La ragazza guardò Ilan. Tutti e due per un attimo pensarono parole impossibili da dire, discorsi che avrebbero riempito non so quante sere, e tiepide notti vicini, per tutta la vita.
Ma Eleazar disse: «Non avevate capito che Vespasianus aveva lasciato in Giudea suo figlio perché non poteva permettersi di perdere». Per il nuovo imperatore, infatti, la guerra di Giudea era regredita a una torbida e remota vicenda coloniale, da risolvere brutalmente, e subito. Esempio a ogni altro ribelle nello sterminato Impero. E Vespasianus aveva delegato a suo figlio una vittoria che sembrava una facile ipoteca sul consolidarsi della dinastia. “Nessuno immaginava i giorni che ci aspettavano” pensò Ilan. Non era mai stato uomo d’armi, lui, aveva sopportato il destino ma il suo coraggio, più che aggressivo, era stato paziente, lontano dalla sfolgorante audacia di altri compagni. Dal primo giorno, aveva scoperto l’inutilità delle stragi, aveva provato una spirituale pietà anche verso i morti Romani. Vide che gli occhi delle donne non lo lasciavano. Disse: «Vespasianus ha messo accanto a suo figlio il Praefectus d’Aegyptus, Tiberius Alexander…».
«Un apostata venduto a Roma, che s’è cambiato anche il nome» commentò un ufficiale. Eleazar dichiarò: «Non siamo stati sconfitti dalla forza. Al servizio di Roma hanno operato tre traditori: Alexander lo stratega, Agrippa il vassallo, Josef lo storico». Entrò in mezzo al cerchio, accennò ai suoi di non muoversi, sedette sulla sponda di un muricciolo. Non aveva bevuto nemmeno un sorso di vino in tutta la notte, lui.
Ilan disse: «Una notte sapemmo che, di colpo, le tre Legioni di Cesarea erano state chiamate in armi. E dalla Syria scendeva la Dodicesima…».
Lo interruppero con vivacità: «Quella presa in trappola a Beth Horon, quella che ha sgozzato i muli…».
Ilan annuì: «Ma Shimon Bar Ghiora mi ha detto: quelli della Dodicesima devono riabilitarsi. E saranno i nostri nemici più feroci».
(Non si sarebbero riabilitati, nonostante le stragi. Finita la guerra, dalla piacevole Syria li avrebbero spediti alle aspre rive dell’Euphrates, tra l’Armenia e la Cappadocia.)
Ilan si sentì le labbra arse, la ragazza lo notò, si precipitò a raccogliere la coppa, gliela tese; bevve con sollievo, inghiottendo adagio, e disse: «Mancava un giorno al plenilunio di primavera, quando li abbiamo visti arrivare». Quando quella nuvola di polvere aveva incominciato a gonfiarsi sull’orizzonte, nella sua mente, come un piccolissimo verme, era entrata la certezza della fine. Aveva reagito, nel profondo di sé, s’era irrazionalmente aggrappato alle profezie.
«Li vedemmo da lontano. In testa marciavano gli arcieri Nabatei, i collaborazionisti, le truppe dei piccoli re e tetrarchi dei paesi vicini. Erano pericolosi perché alla nostra gente non sembravano stranieri, vestivano e parlavano come noi, mostravano che allearsi a Roma era fruttuoso. Ma Johanan ha detto che i Romani li spingevano in testa perché in un’imboscata sarebbero morti per primi. E anche questo era vero.» Gli ascoltatori si lasciarono andare a un’altra risata. Che finì subito. «Poi ci sono comparsi davanti i genieri, gli esperti delle tecniche d’assedio…»
Ilan non aggiunse altro su quei vivi e temibili simboli della tecnologia romana ma Eleazar mormorò: «Li abbiamo visti anche noi». Era stato il momento della sua sconfitta: la costruzione incontrollabile della possente rampa sulla Roccia Bianca.
«Poi sono arrivate le salmerie del Comando.» Una interminabile carovana di muli e carriaggi, una visione di ostentata e potente efficienza, protetta ai lati da scorte bene armate. A quel punto la gente della città aveva incominciato a udire gli squilli lontani, da chissà dove laggiù, ma acutissimi, degli strumenti a fiato, le tube, le buccine; e il solenne, confuso avvicinamento degli infiniti timbri anticipava l’enormità della massa in moto.
«… E ho riconosciuto i reparti speciali, quelli incontrati a Tarichea, a Ashdod, a Jericho.» E i Lancieri sulle loro cavalcature veloci e nervose; e gli squadroni della travolgente Cavalleria di Campagna, protagonista di rastrellamenti devastanti, i fortissimi cavalli dalla groppa larga e gli zoccoli pesanti, la faretra che racchiudeva le Tragulae, i giavellotti micidiali per l’attacco a distanza, l’Hasta, la solida lancia per il primo assalto, il Gladium pesante al fianco, e il Parma, il lungo scudo ovale agganciato alla sella, per l’ultimo mortale combattimento ravvicinato. Ilan non disse come fosse stato sinistro, per lui, il rivedere quei combattenti, apparsi la prima volta ai lontani confini settentrionali e adesso, mai sconfitti, anzi più forti, nel cuore del paese. «Ma nessuno di noi provò timore» dichiarò. E, in un certo senso, era stato vero.
Pensò con sollievo che il racconto avrebbe occupato quasi tutto l’esiguo tempo rimasto alle loro vite. Non provò emozione. Non avrebbe mai creduto che l’idea della morte fosse così spontanea e senza dolore.
Ma una inaspettata voce femminile domandò: «E il figlio dell’imperatore dov’era?». Le altre donne commentarono con un piccolo riso soffocato.
«L’ho veduto» rispose lui, «poco più che un ragazzo.» In mezzo a un’onda di polvere, nel sempre più forte e acuto clamore delle buccine, in groppa agli agili cavalli arabi erano emersi, con le superbe armature ageminate d’argento e orlate di porpora, gli ufficiali del Comando. Al centro di quella corona umana, inaccessibile, alto, le reni diritte sulla sella, cavalcava lui, giovane, con quel celebre, ingannevole, clemente sorriso, lui, Titus Flavius Vespasianus, il Capo supremo, il figlio dell’imperatore romano. Era stato l’apparizione del Potere, la materializzazione del Mito, il Destino.
Infatti, subito dietro di lui, a cavallo, affiancati dalla scorta, avanzavano i Tribuni e i Praefecti delle Cohortes, coloro che guidavano gli uomini sul campo, coloro che nel momento risolutivo gettavano la vita. L’orgoglio era visibile, come una nuvola attorno a loro: perché essi soli, quelli che da anni vivevano di guerra, avevano il privilegio di circondare, come un muro umano, le Insegne delle Legioni, i sacri «Signa», e, al centro di tutto, tenuta alta dal più valoroso degli Alfieri a cavallo, l’Aquila d’Oro, il lampeggiante, divino simbolo di Roma.
Alle loro spalle, con un trascinante colpo d’immagine apparivano, pesantemente trainate, le Machinae, le baliste, le catapulte, gli arieti, le elepoli, gli spaventosi, immani congegni che già avevano demolito le mura millenarie di Jodfat, di Giscala, di Jericho. Mai s’erano visti apparecchi di tali dimensioni, in Oriente; ed era dimostrato che, contro i colpi dei loro devastanti ingranaggi, non esisteva riparo.
Poi – interminabile fiume umano di corazze, daghe, scudi, elmi e pugnali, scandito dai Centurioni e Decurioni – seguivano a piedi, su sei inesorabili ordinatissime file – scompaginarle era reato capitale – i circa ottantamila Legionari impegnati in quella campagna. Ciascuno di loro, oltre alle armi, portava su di sé, in una spietata autonomia di lotta e di sopravvivenza, gli attrezzi necessari a tagliare, scavare, frantumare, legare, incatenare, e viveri per tre giorni. Il sole di primavera lampeggiava sulla Lorica e la Galea, l’armatura di ferro che non veniva mai deposta. E chi guardava era travolto da una dimostrazione di potenza incontenibile.
Poi seguivano le salmerie dell’esercito, con le migliaia di addetti e di schiavi. E poi i mercenari, massa senza numero. E, per finire, una solida e spietata retroguardia Romana. E Ilan pensò: “In questo modo, con questo volto, ho veduto la guerra salire fino alle nostre mura”.
Jerushalem, città con tre cinte di mura
«Noi vedevamo i Romani e sapevamo che, nello stesso momento, essi vedevano la nostra Jerushalem lassù, grandiosa, con le sue mura di pietra bianca fondate sulla roccia e gli strapiombi attorno. Perfino il traditore Josef ha scritto che Jerushalem era meravigliosa a guardarsi.» Sul fianco occidentale della città, infatti, il precipitoso dirupo della valle di Hinnom, e sul fianco di levante l’altro pendio, che s’affacciava sulla Valle del torrente Kidron, scendevano convergendo a sud, nello sprofondo sotto la sacra piscina di Shiloah. E con un’invenzione architettonica mai veduta, le molte torri della muraglia, dove il suolo era più elevato, arrivavano a un’altezza proporzionata e possente, ma dove il pendio discendeva, erano alte anche fino al doppio, così che da lontano apparivano tutte della medesima altezza. Come le pesantissime pietre di una immensa corona.
«I Tribuni Romani scrutavano le nostre fortificazioni con rispetto, e da lontano.» Tutto l’Oriente, infatti, raccontava che Jerushalem era difesa da una triplice cinta di mura. E nessuna città del mondo conosciuto possedeva una difesa simile, perché, delle due muraglie più interne, misteriosamente, non si vedeva nulla. Molti dicevano, scrollando le spalle, che fosse una leggenda. «Poi ho veduto che l’esercito romano, come tutti gli altri antichi aggressori, s’accostava a Jerushalem per la via di settentrione, l’unica possibile, dove si stende la pianura. E ho capito che il traditore aveva parlato all’orecchio di Titus. Per nostra disgrazia nessuno conosceva la città come lui.»
Gli uomini ascoltavano con passione, come se Jerushalem fosse ancora intatta, lassù. «E d’un tratto ho visto che Titus, lo sventato figlio dell’imperatore, prendeva con sé una piccola scorta di cavalieri e imboccava la grande strada diritta e piana che portava verso di noi. Johanan di Giscala m’era accanto, stavamo in vetta al Terzo Muro, il più esterno. “Guarda come si avvicina” mi ha sibilato all’orecchio, “la guerra può decidersi ora”.» Johanan gli aveva stretto il braccio fino a torcerlo. «Noi ci siamo nascosti tutti. Così il Muro è apparso ai Romani sguarnito e senza rumori, come se la città fosse vuota. Il giovane Titus ha creduto che la nostra gente, terrorizzata dalle sue Legioni, si fosse dispersa nel Deserto. L’ha scritto anche il traditore.»
Risero di nuovo, risate dure, a singhiozzo. Infatti Titus s’era ricordato che a Tiberias e a Giscala i ribelli s’erano ritirati, durante la notte, abbandonando le città. E, per voci di spie, sapeva che anche i superstiti di Tarichea, e Gàmala, Iafo, Jericho, Sekhakah s’erano raccolti a Jerushalem. E anche quel Johanan, di Giscala appunto, che era sparito con i suoi la notte di quel celebre Sabato. Risero, con un suono chiaro, anche le donne. Eleazar, il capo, pensò con orgoglio: “Ben pochi uomini e donne, in una notte come questa, avrebbero fiato per ridere”. E comandò: «Portateci da bere».
Ilan tese la mano verso la coppa, la ragazza gliela porse, gli sorrise con complicità. Anche Eleazar levò la coppa. Uomini e donne bevvero, tutti. Eleazar depose quasi subito la sua.
«Titus procedeva a cavallo e contemplava la città come un cacciatore s’avvicina alla preda. Ma noi intanto lo scrutavamo, da una stretta fessura tra le pietre. Johanan mi ha detto: “Guarda! sta a capo scoperto e non ha nemmeno l’armatura”. Dalle nostre mura non emergevano combattenti. E nessun rumore. Nella muraglia erano incastrate due torri. Forse qualcuno ha detto a Titus che erano chiamate, per una vecchia storia, Torri delle Donne, perché l’ho visto ridere. In basso, sotto di noi, c’era la Porta di ferro, chiusa.»
«Dopo Giscala, Titus e Johanan per la seconda volta di fronte» disse Nachman fra i denti. Ed era vero: la sorte aveva spaventosamente dilatato il potere di ambedue. Titus era il comandante in capo e il figlio dell’imperatore, adesso; e Johanan aveva in mano i luoghi simbolo dell’insurrezione: la Fortezza Antonia e il Tempio. Gli uomini deposero coppe e boccali, uno dopo l’altro.
«Ho visto che Titus s’avvicinava ancora. E poi ha svoltato a destra, ha imboccato il percorso proprio a fianco delle mura. La scorta si è allungata dietro di lui. Ho notato che era un buon cavaliere. Qualcuno gli si è accostato, forse gli ha detto di non fidarsi. Ma lui continuava ad avanzare. Alle sue spalle la scorta si disordinava perché il terreno era sparso di orti, recinzioni, piccoli fossati, inadatto ai cavalli. E di colpo Johanan ha gettato un ordine, la Porta di ferro s’è spalancata, una squadra dei nostri s’è avventata fuori. Prima che il giovane Titus si voltasse, l’abbiamo assalito e diviso dal grosso della scorta. Lui non poteva lanciare il cavallo su quel terreno difficile, mentre i nostri gli venivano addosso. E la sua scorta ha voltato i cavalli, via, in fuga. Il traditore li scusa: “Hanno creduto che si fosse liberato…”.» Tra gli ascoltatori scoppiarono insulti sprezzanti; ma tacquero subito. «Titus ha capito che lui e i suoi pochi compagni dovevano difendersi da soli. S’è aperto la strada menando fendenti, mentre i compagni gli si stringevano ai fianchi. Quella violenza e la velocità del suo cavallo l’hanno salvato. Josef ha scritto che era stato divinamente protetto: lui e il cavallo, nemmeno un graffio. Ma noi, invece, avevamo mirato a portarcelo vivo in città. E tutta la guerra sarebbe cambiata, se l’attacco di Johanan riusciva.»
Gli uomini imprecarono. Ilan pensò che era vano e disperato tornare a quei momenti, ma Eleazar impose: «Continua».
«… due soli, fra i Romani, sono rimasti a terra…» disse Ilan, e pensò, con una nausea retrospettiva: “I primi due insensati morti dell’assedio”. Continuò: «Quella sera, Tiberius Alexander, l’apostata, si è detto con spavento che il Figlio dell’Imperatore, invece di cadere onorevolmente in guerra – cosa comunque sopportabile – avrebbe potuto finire vivo in mano nostra, dentro le mura. E ha compreso che li aspettava una dura battaglia».
Chiusi dentro le tre cinte di Jerushalem, gli Insorti all’inizio avevano sognato la città come il luogo sublime in cui, finalmente, realizzare la loro libertà, il loro sociale e religioso modello di vita. La rivolta s’era accompagnata a un noncurante dispregio della forza romana, che ai loro occhi era svalutata dalla lunga guerra civile di tanti aspiranti imperatori. Ma, quando avevano scoperto che Roma non era disfatta, anzi riemergeva con una potenza tremendamente nuova, quando avevano visto avanzare l’immensa macchina di quell’esercito, l’esaltante psicologia della rifondazione di una società s’era trasformata nell’angosciante psicologia di un assedio. Alcuni, non potendo sperare in aiuti, s’erano rifugiati nell’irrazionale, anestetizzante attesa delle profezie apocalittiche. Ma i più forti, di fronte alla prospettiva della schiavitù, avevano semplicemente messo in conto la morte.
Il traditore racconta (e forse suggerisce)
«Titus con tre Legioni, la Macedonica, l’Apollinaris, e la vergognosamente famosa Dodicesima, ha posto il campo a settentrione» raccontava Ilan. «L’ho veduto, a cavallo, salire sul colle di Safein: di lassù si poteva osservare tutta la nostra santa città, nelle sue mura bianche, e la mole splendente del Tempio. Ma la Decima Legio Fretensis, quella che ci sta attorno stanotte, ha alzato il suo Castrum sul Colle degli Ulivi. Il vallone del torrente Kidron la separava dalla nostra muraglia orientale, quella del Tempio. Lavoravano sparpagliati, senz’armi. E d’un tratto Johanan ha lanciato fuori un drappello dei nostri. Si sono precipitati giù per il vallone, sono risaliti sull’altro pendio, hanno messo la Decima vergognosamente in fuga. E il traditore l’ha scritto.»
Infatti Josef – dopo aver esaltato il ferreo e sperimentato sincronismo della macchina militare romana – s’era velenosamente divertito a descrivere i Legionari sbalorditi e dispersi da un attacco di gente che gli si buttava addosso alla disperata: «… i Romani, addestrati a combattere sotto ordini precisi, di fronte all’imprevisto si scompigliano. E questi erano, in fondo, solo pochi Giudei…». Era vero, pochi Giudei. Ma la superba Decima Legio s’era disintegrata. «Scappavano da tutte le parti.» Fra gli uomini che ascoltavano, le risate di scherno si accesero forti, con sollievo, suonarono irreali in quel buio. «È accorso Titus, con la sua Guardia, s’è buttato nella mischia, e la Decima Legio s’è salvata.»
Un sorriso sfuggì anche a lui. «È capitato spesso» commentò. «Titus interveniva disastrosamente dopo, invece di dare gli ordini giusti prima.»
«Ma poi ho visto che i Tribuni e gli ingegneri militari incominciavano a esplorare il nostro fianco settentrionale.» Era il segnale più sinistro che potesse mostrarsi. Da sempre, quella pianura era stata il lato debole di Jerushalem. Già sei secoli prima, nonostante il vecchio muro di Solomon, per quella pianura, in un ardente mese d’agosto, era dilagato senza ostacoli l’esercito di Babylon. Lo sconfitto re di Jerushalem aveva dovuto contemplare l’uccisione dei suoi figli; poi – affinché quella immagine rimanesse per ultima nella sua memoria – gli avevano cavato gli occhi e se l’erano trascinato via in catene, con il suo popolo. Molto tempo dopo, anche il romano Pompeus aveva facilmente lanciato il suo esercito per la stessa strada. Lo scaltro Herod se n’era b...