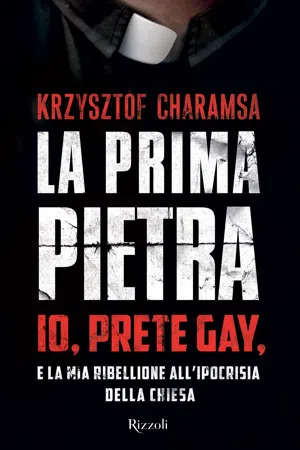![]()
Parte seconda
La bella e la bestia
![]()
Famiglia
Per capire me stesso, devo tornare indietro, molto indietro…
Devo tornare alla genesi, alla mia famiglia d’origine. Devo tornare al grembo di mia madre.
Dovrei forse svelare subito quando sono nato? Lo dico dunque: sono nato il 5 agosto, un sabato di piena estate; per questo, il giorno del mio compleanno amo vedermi sempre su una spiaggia. Prima al Nord, nella penisola di Hel sul mar Baltico, con le sue lunghe, profonde distese di sabbia un po’ selvagge a una cinquantina di chilometri da casa; poi, nel tempo, sulle spiagge più a sud.
Sono nato nel 1972, l’anno in cui il grande Guy Hocquenghem pubblicava il suo testo programmatico Le désir homosexuel1. Sono nato sotto la buona stella del manifesto della rivoluzione omosessuale che denunciava con forza la strisciante ossessione omofoba. Descriveva le dinamiche dell’omofobia e poneva le basi per un movimento di liberazione degli omosessuali, dopo aver fatto in quello stesso anno il suo coming out. Guy aveva detto la verità per smascherare l’ipocrisia collettiva e così fu espulso dal partito comunista, a cui era iscritto. La società a cui apparteneva non voleva sentire le sue denunce.
In quell’anno nasceva anche il termine “omofobia”: lo psicologo americano George Weinberg, nel suo Society and the Healthy Homosexual, assegnava un nome alla paura irrazionale che si prova di fronte a un omosessuale, a quella fobia al cospetto della diversità da se stessi che genera violenza, odio, distruzione. Dare un nome preciso al male è il primo passo verso la vittoria sul male stesso. Eppure, secondo la mentalità dell’ambiente cattolico in cui io ero nato, quel nome non doveva esistere2.
Correva l’anno 1972: la parola che denuncia la paura e l’odio verso gli omosessuali non doveva mai essere pronunciata. Il desiderio omosessuale non doveva mai essere rivelato. Forse neanch’io sarei dovuto nascere? Invece, sono nato. Il desiderio omosessuale è stato coraggiosamente affermato. E, grazie a Dio, uno scienziato ha finalmente definito l’odio verso i gay…
Ero nato in un tempo e in uno spazio in cui i gay ufficialmente non esistevano. Rappresentavano il tabù perfetto. In verità anche oggi, se l’omosessualità viene alla luce, bisogna fare di tutto per tornare al tabù imposto: quella cosa vergognosa, malata, indicibile, perversa, peccaminosa, diabolica… ufficialmente non esiste. Quella cosa che ti rende lebbroso non deve avere neanche un nome. La si deve sottacere con vergogna.
Nel mondo in cui ero nato, non importava a nessuno che nel 1973, quando cadeva il mio primo compleanno, venisse organizzato a Parigi il primo congresso mondiale delle organizzazioni omosessuali (a cui non potevo essere invitato!). Non importava a nessuno che in quell’anno l’associazione americana di psichiatria cancellasse l’omosessualità dai suoi accreditati elenchi di disturbi psichici3. La scienza correggeva dunque i propri errori, ma il mondo cattolico nel quale ero nato bollava queste nuove posizioni semplicemente come infondate. Eppure, anche in ambito cattolico, in quell’anno un gesuita catalano, Salvador Guasch, svelò pubblicamente di essere omosessuale e di esserne felice. Un gay che pretende di non sentirsi lontano da Dio! La semplice presunzione di un disgraziato! Dicono che pagò questa sua sincerità con diversi mesi di manicomio e subendo terapie brutali per guarire o almeno reprimere i suoi malsani desideri e i suoi pensieri “contro natura”. Allora avevo un anno e non potevo ancora sapere nulla della sua sprovveduta uscita alla luce del sole, ma il mio mondo castrava chi si permetteva di essere felice senza l’autorizzazione della Chiesa e dello Stato.
Sì, sono nato in un mondo cattolico.
Amo la mia famiglia. Mia madre era una donna dalla fede incrollabile. Con la sua fede era capace di fare miracoli, di resistere a prove insopportabili. La sua fede non ha mai vacillato neanche davanti ai comportamenti aberranti della Chiesa: lei aveva un che di geniale che la poneva oltre la mediocrità umana. I miei genitori erano economisti di formazione. Lavoravano entrambi, anche se, secondo la mentalità cattolica, doveva essere il padre – da vero maschio – a mantenere la famiglia. Io ero il loro primogenito; dopo tre anni nacque mio fratello e, quando avevo dodici anni, mia sorella. Eccoci tutti al completo.
Mio padre se ne andò di casa nello stesso giorno in cui, dopo la maturità, entrai in seminario per farmi prete: all’epoca non conoscevo altri casi di separazione, ma la fine del matrimonio dei miei genitori fu del tutto insolita. Fummo lasciati senza nulla, in un appartamento disastrato, con tutti i risparmi raccolti per la nuova casa svaniti assieme a mio padre. In sede di divorzio mia madre non intraprese alcuna difesa e non lottò per il pieno rispetto dei diritti suoi e dei figli. La capivo nella radicalità dei suoi silenzi. Dentro di sé non accettava il divorzio e quindi si rifiutava di combattere per quel che le sarebbe spettato. A pensarci bene, però, per difendere i propri diritti c’è anche bisogno di un buon avvocato e noi non potevamo permettercelo. Così mio padre se ne andò via, senza pensare troppo alle necessità dei figli: inviava solo quanto stabilito dal giudice per mia sorella, ma almeno noi rimanevamo in pace.
Per me, la separazione da mio padre fu una liberazione. Forse per i miei fratelli fu diverso. Entrando in seminario, io cominciavo una nuova vita, mentre loro restavano a casa. Ma la quotidianità con mio padre, di cui conservo solo un vago ricordo, era diventata insopportabile: era assente, non aveva instaurato una vera relazione paterna con noi. Adesso so che lui, a modo suo, ci amava, ma in una maniera possessiva, come si può amare una proprietà, in una forma non molto diversa da quella di molte famiglie patriarcali e maschiliste. Oggi non serbo alcun rancore nei suoi confronti, però mi è rimasta, purtroppo, la sensazione di non avere un padre al mio fianco.
Secondo un’interpretazione spesso ripresa in ambito cattolico, un ragazzo con un padre assente e una madre iperprotettiva (cosa che mia madre non è mai stata) sarebbe predisposto a diventare effeminato, ergo omosessuale, cioè deviante e peccaminoso. Perciò, negli anni, cercando una spiegazione per me stesso, ho fatto mio questo stereotipo: ero gay, perché i rapporti con mio padre erano stati negativi o inesistenti (per questo la Chiesa aveva già la soluzione perfetta per me: con il celibato mi offriva un nascondiglio, una “dignitosa” scappatoia al matrimonio eterosessuale). Con il tempo avrei incontrato decine e decine di gay che con i rispettivi padri avevano rapporti splendidi o almeno del tutto normali… sempre che mi sia permesso di usare l’aggettivo “normale” che pare di esclusiva competenza della Chiesa cattolica, tanto rigorosa quanto in passato è stata solo l’insuperabile dottrina marxista, contro la quale proprio la Chiesa era in lotta!
Penso di non essere mai stato il figlio che mio padre sognava di avere: sentivo più affinità elettive per l’arte, l’opera lirica, il teatro, il balletto, che non per il calcio. Ero un ragazzo che si rifugiava nei libri, e per di più non in quelli di matematica, ma di letteratura, di poesia, di storia. Non ero quindi il tipico figlio maschio che poteva desiderare lui, in grado di mostrarsi forte picchiando un compagno, il modello virile di ragazzo destinato a occuparsi, come lui, di economia e di finanza. Un economista: non un sognatore, un romantico, un idealista! Ho sempre avuto l’impressione che per mio padre il figlio prediletto fosse mio fratello il quale, oltre ai libri, onorava anche il pallone, come ci si aspetterebbe da un “sano” maschio.
Sì! Io ero gay. Lo sono da quando i miei genitori mi hanno dato la vita. Ma non sono stati loro, né nessun altro, a infondermi la mia omosessualità. Non sono un padre né una madre a trasmettere al proprio figlio l’essere omosessuale o eterosessuale: si può invece riversare nell’altro l’omofobia, la paura e l’odio verso i gay e il proprio essere gay. Dagli altri si eredita l’omofobia; l’omosessualità è data. È il dono per un omosessuale così come lo è l’eterosessualità per un eterosessuale. È il dono del mio Dio, il dono della natura, il dono della vita. È la buona energia data e diversificata tra le persone. L’energia buona può essere contaminata solo dall’omofobia.
A volte penso che mio padre sospettasse qualcosa di me già quando ero piccolo: sarebbe stato curioso assistere alla sua reazione al mio coming out. Avrebbe detto «l’ho sempre saputo», «lo sospettavo» o «lo temevo»? Ma oggi non riesco a immaginare di tornare a stabilire una qualsiasi relazione con lui: dopo tanti anni di assenza ingiustificata, è come se fosse morto. Non credo nel «dogma del medesimo sangue» che ti spingerebbe a oltranza verso qualcuno, anche quando quel qualcuno ti ha per molto, troppo tempo, ignorato e calpestato.
Amavo mio fratello e mia sorella. Oggi penso di non essere sempre riuscito a dimostrarlo pienamente a mio fratello, e me ne dispiace. Forse ero proprio come mio padre? Forse la sensazione che lui fosse il prediletto mi bloccava? A mia sorella invece non risparmiavo le cure premurose da fratello maggiore: la accudivo, la proteggevo, la sostenevo sostituendomi quasi a mio padre. Nacque così istintivamente in me l’idea di dover mantenere la mia famiglia dopo che eravamo stati abbandonati: mi sentivo responsabile per il loro sostentamento, desiderando solo che fossero felici. Rinunciavo a tutto pur di aiutarli, provando a rendere più lieve la loro quotidianità e a infondere sicurezza. Anni dopo arrivai anche ad aiutare negli studi gli altri. Nella vita avevo incontrato delle persone buone, dei mecenati sinceri che avevano sostenuto la mia istruzione, quindi sentivo di dover rinunciare a parte dello stipendio per aiutare qualcun altro a studiare, come era stato fatto con me. Esistevo per gli altri. A volte penso di aver fatto dei passi più lunghi della gamba, passi che mi sono costati grandi sacrifici, ma rifarei tutto mille volte. In quegli anni io e i miei fratelli avevamo raggiunto una nostra felicità, una nostra stabilità. Tutto ciò che facevo per i miei cari mi sembrava la manifestazione di un amore tipicamente gay: a volte esuberante, barocco, esagerato, quasi che, nel mio subconscio, cercassi di guadagnarmi un’approvazione, di conquistare un amore per quello che ero realmente (ma di cui loro non sapevano nulla).
Ogni volta che penso alla mia infanzia, mi chiedo se non prendessi tutto eccessivamente di punta. Ero sempre serio, come se fossi troppo maturo; non mi concedevo mai ciò che dovrebbero concedersi i ragazzi. In un certo senso, sono stato adulto fin da subito. Era forse questo un modo per nascondermi, per costruire sin dall’infanzia un muro tra il mio animo, delicato e sensibile, e il mondo? A quel tempo, tutti i bambini cattolici dovevano sapere che si doveva provare solo un enorme schifo per quelli a cui piacevano i maschi. Orrore, rifiuto per la vergognosa depravazione o “abiezione”, come direbbe Julia Kristeva4. Io ho preso sempre sul serio la fede della mia famiglia e della mia Chiesa. Ma forse proprio la Chiesa mi ha confuso riguardo all’amore per se stessi. Non esitavo ad accogliere il comandamento di amare gli altri, ma altrettanto avvertivo il sospetto dei predicatori della Chiesa sull’amore per se stessi e per la propria verità.
Quando qualche tempo fa ho confessato a mia madre di essere omosessuale, la sua risposta è stata per me del tutto inattesa: non la reazione imposta dalla mentalità della Chiesa, ma una manifestazione di amore sconfinato fin dal primo momento. Ripeteva solo che non riusciva a immaginare quanto avessi sofferto per “questa cosa” e che non poteva pensare a quanto dolore mi avesse provocato un segreto come quello portato dentro di me tanto a lungo. Mi chiedeva perché non gliene avessi parlato prima, quando ero adolescente. Non trovavo le parole per rispondere: l’unica cosa che ho saputo fare è stato lasciare sul desktop del suo computer il link al film del 2009 Prayers for Bobby (Preghiere per Bobby), la storia vera di Mary Griffith, una devota cristiana, e del suo percorso verso la comprensione dell’omosessualità dopo il suicidio dell’amato figlio gay. In quel film si possono intravedere alcune delle ragioni per le quali fino a quel momento non avevo potuto rivelare la mia omosessualità: la nostra Chiesa, come Mary aveva fatto con Bobby, avrebbe provato a curarmi. Forse avrebbe chiesto qualche miracolo a san Sebastiano, visto che il problema non doveva essergli estraneo. Ma la ragione di fondo era che, a quei tempi, di omosessualità non si parlava quasi per nulla: il silenzio era ciò che la Chiesa imponeva ai propri fedeli su qualcosa di sospetto, inesistente. Se esisteva, era solo per essere l’argomento delle peggiori barzellette omofobe.
Per di più, io desideravo diventare prete e, per questo, dovevo essere omofobo, cioè dovevo odiare quel diabolico “prodotto” della società moderna, da cui solo la Chiesa cattolica e le dittature comuniste – in questo paradossalmente alleate – potevano proteggere le persone. Io per primo ero imbevuto del giudizio di condanna verso tutti gli omosessuali pervertiti: sapevo che rappresentavano il male, un male che non poteva riguardarmi. Perciò, quello che provavo dentro di me doveva per forza essere frutto di un grande errore oppure un sentimento passeggero, destinato a svanire in pochi giorni. Fu così che, convinto si trattasse solo di confusione adolescenziale, mi abituai a pensare che il desiderio che sentivo per i ragazzi fosse solo una naturale tendenza a paragonarmi a loro. Oggi, prima di farmi prete, probabilmente rifletterei a lungo sulla coerenza dei precetti di una istituzione religiosa così disumanamente ignorante circa l’identità umana. Ma in quel tempo cercavo solo di assicurarmi che non ci fosse nulla di vero nel mio desiderio omosessuale. Lo nascondevo a me stesso, lo declassificavo come qualcosa di effimero e irreale, come un momento di smarrimento, o peggio una malattia. E soprattutto come un peccato. In realtà, per la mentalità cattolica gli unici peccati gravi sono quelli che riguardano la sessualità, in particolare quando a un uomo piacciono gli altri uomini. È, questo, un peccato innominabile. “Quella cosa” è senza nome…
Nella mia famiglia c’è sempre stata una certa dose di grandeur. Ai nostri genitori davamo del lei, un’antica e rara abitudine, ma non ho mai pensato che questa maniera di comunicare ci tenesse a distanza o infondesse “ufficialità”, specialmente nel rapporto con mia madre. Lei era la mia migliore amica e un’ottima confidente, eccetto che per “quella cosa”. Negli ultimi anni, però, nell’era di skype e di whatsapp – diventati i canali di comunicazione privilegiati con mia madre – ha cominciato a risultarmi forzato rivolgermi a lei in terza persona, in brevi e frequenti messaggi. Ma so anche quanti genitori la invidiassero per questa espressione di rispetto filiale e di nobiltà. I suoi nipoti sono più sbrigativi, e grazie a Dio!
Con il tempo, mia madre prese a indossare cappelli sempre più grandi e scenografici. Io la imitai presto, ponendomi sul capo il cappello nero. Quanto mi piacevano i suoi, colorati, eleganti, di mille fogge diverse, ora nobili ora stravaganti! Anch’io gliene regalavo. Con gli anni, è passata gradualmente a prediligere modelli più piccoli e sportivi, forse perché, essendo tutto sommato una donna moderna, oltre alla messa quotidiana, non manca di andare ogni giorno in palestra.
Alla fine dei conti, la mia non è stata un’infanzia infelice. Uno dei ricordi più piacevoli e spensierati è legato alle vacanze che passavamo ad Amburgo da mia zia o a Londra da mio zio. La sorella e il fratello di mio padre – che furono la mia madrina e il mio padrino di battesimo – si erano sposati rispettivamente con un tedesco evangelico e con un’inglese cattolica: erano entrambi molto diversi da mio padre. Erano medici e, purtroppo, morirono tutti e due per un male incurabile intorno ai quarant’anni. Passavo tutto l’anno a sognare le vacanze in Occidente, come un tempo felice: mi veniva spontaneo immedesimarmi in quell’Europa libera e moderna, un mondo molto diverso dalla Polonia. Amavo soprattutto Amburgo con l’Alster, il lago in centro, nelle cui vicinanze vivevano i nostri zii. Sognavo le grandi case, i giardini, le strade, i negozi della città, ma anche la messa domenicale meno pomposa e più sobria della nostra. Invidiavo i loro orari di lavoro che al mattino lasciavano tempo per una lunga colazione, un’abitudine impensabile con i ritmi opprimenti della Polonia comunista. Ad Amburgo, quando ero ancora piccolo, mi portarono a una mostra di Andy Warhol, la prima di un artista gay che abbia mai visitato (allora ignorando quel fatto “devotamente”). A un certo punto iniziai a identificarmi a tal punto con quel mondo, da sognare che la mia vita in Polonia altro non fosse che una breve, grigia parentesi di quasi un anno nella mia vita nell’Occidente libero.
Mia zia aveva idee liberali che m’inquietavano e mi ammaliavano allo stesso tempo: poneva domande, coltivava il dubbio, amava l’arte. Mi fece conoscere il metodo di auto-educazione alla consapevolezza attraverso il movimento, di Moshe Feldenkrais5; inoltre, con lei potevo godermi la sua splendida collezione di quadri di pittrici polacche. Confrontandomi con mia zia, nonostante le certezze della mia fede, cercavo di non chiudermi mai di fronte ai suoi dubbi, al coraggio di relativizzare, all’audacia dell’«insostenibile leggerezza dell’essere» appresa da Milan Kundera. Volevo dialogare con lei, mi piaceva la sua inquietudine, mi affascinava il suo essere libera dagli schemi e dagli stereotipi, lontana anni luce dal provincialismo del cattolicesimo polacco.
Casa nostra, in Polonia, era sempre piena di amici di mio padre: sembrava quasi che ci stessero a maggior diritto di noi che abitavamo lì. Tuttavia, quello che non ci mancava era la biblioteca di mia madre, con tutti i classici polacchi e stranieri, e tantissimi volumi d’arte che erano la mia passione. Mi ero formato all’ombra di quei libri. C’erano anche le opere di Miron Białoszewski6, tranne ovviamente Tajny dziennik (Il giornale segreto), pubblicato postumo solo nel 2012. La vicenda personale di Białoszewski era forse la più interessante tra quelle dei gay vissuti nel regime comunista: era riuscito ad abitare per anni sotto lo stesso tetto con il suo compagno. Da quello che avevo letto di lui a casa nostra non potevo certo immaginare nulla di tutto ciò, e soltanto molto tempo dopo ebbi modo di scoprire i suoi viaggi a New York, la sua “ubriacatura” della libertà concessa agli omosessuali in quel Paese, la funzione salvifica di quei soggiorni. Anche lui, come me, stava nella nostra casa ma nessuno sapeva che fosse gay.
Solo la biblioteca dei nonni paterni superava quella di mia madre. Amavo guardare quella parete piena di libri dal soffitto al pavimento. Tra i volumi del nonno c’era di tutto, e fu là che scovai una vecchissima guida di Lugano che lessi prima di partire per i miei studi in Svizzera. Capii ben presto che, più che una capitale, era una cittadina, senza l’abbondanza di teatri, grandi biblioteche e gallerie d’arte che mi aspettavo di trovare. Scoprii però che c’era un museo: non uno di provincia bensì una delle più importanti collezioni private d’arte al mondo, la pinacoteca Thyssen-Bornemisza, ospitata nella monumentale Villa Favorita che si affacciava sul lago. Eccitatissimo, già mi pregustavo delle interminabili visite, per poi scoprire, appena arrivato a Lugano, che nell’estate precedente la baronessa aveva trasferito tut...