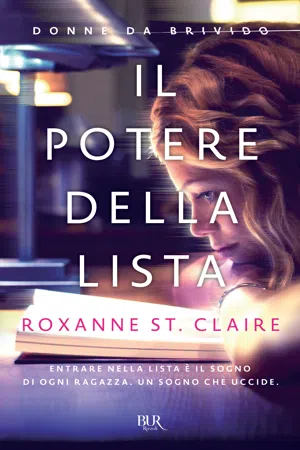![]()
PARTE PRIMA
Bene qui latuit bene vixit
Ha vissuto bene chi ha saputo stare ben nascosto
![]()
1
Esco di casa correndo nel mezzo di un nubifragio.
Il senso di colpa mi attanaglia lo stomaco, si aggroviglia prima di catapultarsi in gola, deglutire o respirare è impossibile. Eppure devo respirare. Devo soffiare via il sapore delle parole che io e mia madre ci siamo appena vomitate addosso.
Non puoi andare, Kenzie. È pericoloso! Potresti morire.
È solo un autobus per Philadelphia, mamma, non un’astronave!
Gli autobus vanno fuori strada! Non ci sono le cinture di sicurezza! E se l’autista è ubriaco?
Mi stai soffocando, mamma! Ti odio! Ti odio!
L’ultima parola è esplosa come un colpo di pistola, accentuata dalla porta sbattuta alle mie spalle. Lei però mi ha seguito, urlando il mio nome, senza fiato, disperata: Mackenzie Grace Summerall! Non osare metterti al volante con questo tempo!
Ho ignorato la raccomandazione, mentre il rumore della pioggia sovrastava il suo ultimo grido e mi sedevo al posto di guida. Perfino in quel momento, mi sono rifiutata di girarmi per guardare mia madre ancora una volta.
Non la odio veramente. Ma detesto quell’espressione tormentata, triste, spaventata, sofferente che trasforma gli occhi grigi di Libby Summerall in due pezzi di carbone bruciato. Quello che non sopporto è la sua paura. Non voglio avere paura della vita; la vita, io, voglio viverla.
L’eco del litigio riempie l’abitacolo, non provo nemmeno a cancellarlo con un po’ di musica, lascio il compito al ticchettio della pioggia battente sul tetto dell’auto. Non le ho mai gridato contro, stasera è stata un’eccezione. Di solito mi tengo tutto dentro; capisco il suo atteggiamento iperprotettivo, ma di tanto in tanto scalcio via quella coperta di piombo e scappo.
Stringo il volante e percorro le vie buie di Vienna, la cittadina della Pennsylvania Occidentale in cui abitiamo, finché non imbocco la Route 1. Per fortuna a guidarmi in mezzo alla pioggia accecante ci sono le luci di un centro commerciale lungo la strada e quelle dei pochi semafori. Non ci sono tante macchine in giro. Non in una notte come questa.
Schiaccio l’acceleratore e mi lancio nella corsia di sinistra, quella pericolosissima in cui mia madre non mi ha permesso di avventurarmi per tutta la durata del foglio rosa. Ora però ho la patente e la libertà, e pure una macchina comprata con i soldi delle ripetizioni – più un piccolo contributo da parte di papà. Diciamo pure che nella corsia di sorpasso, ormai, ci vivo.
Nonostante la pioggia aumento la velocità, le gomme schizzano tra pozzanghere e buche: la mia Accord vecchia di undici anni dimostra i suoi duecentomila e passa chilometri. Il semaforo è verde, quindi premo sul pedale e la macchina scivola sull’acqua per un secondo, giusto il tempo di mandarmi nel panico.
Non c’è verso di calmarmi. Ho bisogno di pensieri felici, rassicuranti. Ho bisogno di qualcosa di comprensibile, di qualcosa capace di tranquillizzarmi davvero.
Al ritmo dei tergicristalli sul parabrezza, mi nascondo nella parte più confortevole del mio cervello, lontana dai rimorsi, dalle preoccupazioni e dalle discussioni che non sono in grado di vincere. Comincio a declinare il termine latino che significa «forte»: Fortis, fortis, forti, fortem…
Il suono di quella lingua antica mi riporta con i piedi per terra nel giro di pochi secondi. Ha regole complesse, ma hanno un senso preciso, e io adoro le cose che hanno senso, sono esattamente come ci si aspetta che siano, sempre, ogni volta: niente sorprese, niente deviazioni casuali, nessun tassello che non combaci. E il latino ce l’ha in un modo speciale, in un modo che di rado vale per il resto delle cose; mi scivola morbido tra lingua e palato tanto che a tratti mi chiedo se, in una vita precedente, non abbia vissuto nella Roma antica.
Ed è per questo che, se solo potessi salire su uno stupido autobus per Philadelphia e partecipare alla gara di latino, potrei diventare la numero uno in tutto il Paese per quanto riguarda la grammatica. Eppure non posso… sarebbe fin troppo sensato.
Ripensando a come è cominciata la lite, mi infurio di nuovo con mia madre. Non si prende nemmeno la briga di leggere il modulo di consenso dei genitori, figuriamoci firmarlo e farlo convalidare. E quindi addio ai campionati statali.
Già, perché per la mamma il pensiero che io esca di casa è diventato il peggiore degli incubi. Insomma, uno dei peggiori. Nell’elenco ci sono anche guidare da soli, fare una doccia durante un temporale, attraversare la strada, usare un coltello, uscire con un ragazzo o… vivere, semplicemente. In sostanza, la mamma è terrorizzata dalla vita perché… accidenta eveniunt. In altre parole, a volte può andare di merda, e questo potrebbe essere il motto di mia madre. Lei, però, è decisa a eliminare l’eventualità che possa verificarsi un altro incidente. Mai più.
Il filo della memoria mi si aggroviglia nel petto, un frammento vago e frustrante della voce di Conner. Ricordo ancora un sacco di cose di lui, ma non riesco a rievocare la sua voce come vorrei. Provo e riprovo – il suono della sua risata, il modo in cui mi salutava una volta arrivati a scuola.
Falli neri, Mack.
Come se io fossi in grado di fare qualcosa, qualsiasi cosa, come sapeva fare lui… con disinvoltura. È stato così in gamba, così importante da vivo. E lo è ancora adesso che è…
Mors, mortis, morti, mortem…
Nemmeno declinare il sostantivo «morte» mi è di grande aiuto. Batto le palpebre nell’oscurità, distinguo a malapena il prossimo semaforo davanti a me. Credo sia verde, ma potrebbe scattare il giallo. Odio prendere certe decisioni, non avere la certezza di superare illesa l’incrocio.
Ma ascoltati! Parli proprio come lei!
Un flash di fari alle mie spalle, le luci alogene, alte, brillanti di un SUV costoso. Impreco a bassa voce, poi mi sposto sulla corsia di destra per lasciarlo passare. I tergicristalli puliscono il parabrezza dandomi il tempo di scorgere uno di quegli stupidi adesivi sul retro del macchinone. Perché le persone pubblicizzano quanto perfetta sia la loro famigliola? Mamma, papà, il bambino che gioca a calcio e la bambina che danza. Tutto perfetto. Tutto così… vivo.
Le spazzole scivolano di nuovo sul vetro e, in cima a una salita, intravedo un pick-up che si avvicina da destra; probabilmente raggiungerà l’incrocio insieme a me. Avrò anche la patente da un mese, ma conosco la legge universale dei furgoni: ti taglieranno la strada ogni volta che ne avranno la possibilità. Quindi resto nella mia corsia da fifoni e, quando schiaccio il freno…
La macchina schizza sull’asfalto, totalmente fuori controllo. Senza fiato, sterzo bruscamente per rientrare in carreggiata; le ruote sollevano ondate e sento l’adrenalina bloccarmi lo stomaco. Alla pozzanghera successiva sono tentata di inchiodare, però ripenso alla pagina del manuale di guida sulle manovre sotto la pioggia: «Su superfici bagnate, schiacciare il freno a più riprese per evitare…» non ricordo più cosa. Allagamenti, forse? Non so quale parte della macchina possa allagarsi, tuttavia meglio non rischiare. Spingo ancora il pedale, una pressione leggera, una volta, due. Non funziona: l’auto sta prendendo velocità lungo la discesa.
«Merda.» I tergicristalli scorrono e vedo di nuovo il furgone, il semaforo, poi il velo d’acqua sul parabrezza offusca ogni cosa. «Oh, andiamo!» grido. Vorrei che le spazzole si muovessero più in fretta e ripulissero il vetro il prima possibile. Appena riacquisto un minimo di visibilità, freno con più decisione.
Nulla.
Inspiro, confusa; mi sforzo di non cedere al panico e pigio il pedale un po’ più forte.
La macchina non rallenta.
E nemmeno il pick-up nero. Il semaforo diventa giallo e a quel punto inchiodo, premendo sul freno talmente forte che il piede sbatte sul pavimento dell’auto. Mi aspetto che la coda della macchina slitti di lato, cerco di reagire all’istinto di chiudere gli occhi, di accettare l’inaccettabile: i freni sono fuori uso.
La mia Accord adesso sta letteralmente volando sull’asfalto, l’acqua schizza altissima ai lati dell’auto che sfreccia inarrestabile verso il semaforo. Tra pochi secondi scatterà il rosso. Il pick-up è a circa cinque metri dall’incrocio. E anche io.
«Ferma!» grido al conducente, e alla mia stupida macchina, e a qualunque altra cosa al mondo. Ma non si ferma proprio nulla. Le spazzole schiaffeggiano la pioggia e l’auto si lancia in avanti mentre quel maledetto furgone non accenna a rallentare. Tento di tirare il freno a mano, però non ne ho il tempo e non ce la faccio a stringere la leva da quanto mi tremano le dita.
Sono a un metro e mezzo dal bivio, scatta il rosso e io continuo a schiacciare il piede sul pedale, ancora e ancora. Un urlo mi monta dentro; lancio un’occhiata a destra e vengo accecata dalle luci del pick-up diretto a tutta velocità contro di me.
«Ferma!» strillo ancora, e finalmente riesco a strattonare la leva del freno a mano con tutta la forza che ho in corpo. Guardo a destra e a sinistra in cerca di una via d’uscita, mentre l’auto procede sbandando in direzione dell’incrocio.
Non sento le mie grida, ma sono lucida e registro ogni cosa. I muscoli tesi come acciaio, pronti alla violenza dell’impatto. Il terrore, gelido, che mi avvolge. La macchina che si muove come un vagone delle montagne russe. Tutto quello che percepisco è lo stridio acuto e continuo del clacson del pick-up, suonato da un autista incazzato.
Uno scatto a destra, poi a sinistra; chiudo gli occhi nel momento in cui ciò che mi circonda comincia a girare e oscillare. La cintura di sicurezza mi schiaccia contro il sedile e preme sul torace, opprimente.
E il mio unico pensiero è… Conner. È questo che mio fratello ha provato quando la cinghia del nastro trasportatore l’ha trascinato giù? Quando il suo collo si è spezzato? Quando il mondo è diventato scuro e freddo e…
Un tonfo e tutto si ferma. La macchina, le sbandate, i ricordi macabri. Sento solo il monotono tamburellare delle gocce, un ticchettio meccanico, e un ronzio lieve, uno scampanellio, che riecheggia nel silenzio.
Ci vogliono quattro secondi perché mi volti di lato e veda attraverso la pioggia due archi gialli e luminosi: l’insegna di McDonald’s non è a testa in giù. E quindi neppure io. E la cosa più importante è che… sono viva.
Non mi muovo, però; faccio un rapido inventario del mio corpo, in attesa di provare dolore… da qualche parte. Eppure non ho male, e l’unico rumore è un ronzio ripetuto che proviene dal sedile del passeggero.
Il telefono, registra il mio cervello sconvolto. Un messaggio.
Mamma! Gioia e terrore mi gonfiano il petto, e nella mia testa scorrono le immagini di un universo parallelo: la mamma appesa a un filo mentre un poliziotto bussa alla porta di casa nostra per annunciare la peggiore delle notizie…
Perdere un altro figli...