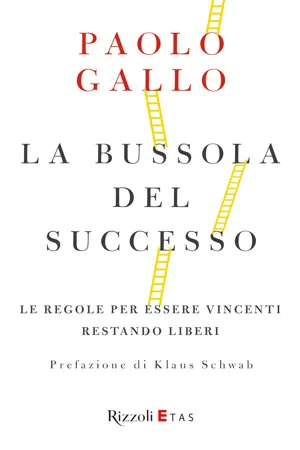![]()
Parte seconda
La bussola
![]()
2
Prima di partire
Capire qual è il villaggio giusto per noi
Se non sai dove stai andando, tutte le strade ti portano lì.
Lewis Carroll, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie
CHE COS’È LA CULTURA?
Nel primo tratto del nostro viaggio insieme abbiamo imparato un segreto semplice ma di vitale importanza: il tesoro che cerchiamo da sempre, del quale a volte mettiamo in dubbio l’esistenza, in realtà l’abbiamo già trovato. È nascosto dentro di noi. Nel nostro cuore, nella nostra mente, nei nostri occhi. La strada giusta per scoprire il tesoro è quella che conduce a nuove domande, invece di indovinare vecchie risposte. Come scrisse Proust, la vera scoperta non consiste nel trovare nuovi paesaggi ma nel guardare lo stesso panorama con occhi nuovi.
È arrivato quindi il momento di guardare fuori, di aprire le finestre per scorgere all’orizzonte il villaggio giusto. In altre parole, cercheremo di stabilire quale sia la cultura che meglio si adatta ai nostri valori o, viceversa, se i nostri valori siano in linea e si possano adattare alla cultura di cui facciamo o vorremmo far parte.
Come già accennato, lavoro nella funzione Risorse Umane da 25 anni, molti dei quali trascorsi nel ruolo di direttore del personale. Ho conosciuto centinaia e centinaia di storie personali e professionali e ho imparato che solo chi capisce veramente la cultura organizzativa ha una seria possibilità di crescita e sviluppo in un’organizzazione.
Quasi tutte le persone che lavorano sono preparate e motivate, poche però vanno avanti con successo. Sono convinto che il fattore discriminante sia la capacità di comprendere a fondo la cultura di cui si fa parte, evitando di finire lost in translation. Tutti conoscono il proverbio: “Quando sei a Roma, fa’ come i romani”, che sottolinea la capacità essenziale di adattarsi a un sistema di riferimento e a una cultura diversi dai propri. Il problema è che nessuno sa cosa facciano davvero i “romani”, intesi come le persone che fanno parte del villaggio o sistema sociale.
Dobbiamo considerare la cultura d’impresa come qualcosa che l’organizzazione è, in contrapposizione a quello che fa, vende, ha o guadagna, temi consoni a produzione, ricerca, marketing, finanza, contabilità. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, ammetteremo che conduciamo lo stesso tipo di analisi quando scegliamo i nostri più cari amici e i nostri partner per la vita: dobbiamo comprendere innanzitutto chi sono, non solo cosa fanno o cos’hanno. In questo capitolo, dunque, ci focalizzeremo sul capire come sono le organizzazioni, condizione imprescindibile per trovare un significato profondo nel nostro lavoro.
Ma che cos’è la cultura? Il termine “cultura” è indubbiamente inflazionato: tutti ne parlano ma è ben difficile che due persone siano d’accordo sulla sua definizione. Anche quelle che possiamo leggere nei vari dizionari mettono in evidenza aspetti molto differenti di questo vocabolo che copre estetica, morale, antropologia.
E proprio questa sarà la chiave di lettura utilizzata in questo capitolo: una caratteristica della cultura, nella sua accezione antropologica, è che non deve essere obbligatoriamente esplicita. Un gruppo può vivere secondo un proprio modello di cultura senza esserne consapevole oppure accorgendosi di quanto esso differisca dagli altri solo quando esce dai propri confini conosciuti.
Le persone possono reagire in vari modi al contatto con nuove culture. Per esempio, durante i miei anni universitari ho fatto da guida e interprete a gruppi di studenti italiani a Londra, molti dei quali all’estero per la prima volta. Tanti giovani, dopo essersi accorti di quanto erano diversi dagli inglesi, si impegnavano per restare, se possibile, ancora più coesi e chiusi: cercavano disperatamente ristoranti italiani e non solo non imparavano l’inglese, ma tornavano a casa con l’accento degli amici italiani frequentati durante il soggiorno londinese. Altri studenti, invece, si divertivano ad assorbire una nuova cultura, apprezzavano il tipico fish and chips e si trovavano amici e fidanzati locali per alcune intense settimane, imparando benissimo la nuova lingua.
Studiare la cultura è quindi fondamentale per la propria sopravvivenza e crescita personale e professionale. È opportuno allora chiederci come la si possa definire in termini operativi.
Ho selezionato tre definizioni che, a mio avviso, possono chiarire questo aspetto. In Culture e organizzazioni, dello psicologo sociale olandese Geert Hofstede, la cultura è il software della mente, il nostro sistema operativo, ovvero il modo in cui siamo programmati in parte o del tutto inconsciamente.
Una seconda definizione è quella data da Peter Senge, fondatore della Society for Organizational Learning e autore del libro La quinta disciplina, che identifica la cultura come mental model, uno schema mentale fatto di ipotesi, generalizzazioni, immagini che permettono di decifrare la realtà e prendere decisioni secondo i propri canoni individuali.
Nella mia esperienza, infine, ho sempre considerato la cultura personale come una lente attraverso la quale osservare il mondo. La terza definizione è, in termini organizzativi, considerare la cultura come il collante invisibile che tiene unita una società o un’organizzazione. Lenti e colla: funziona! Per spiegarlo con un esempio: può essere considerata culturale la reazione degli americani di fronte all’11 settembre 2001. George Bush era un Presidente inviso a molti, ma nelle 48 ore successive agli attentati ritrovò l’approvazione incondizionata di più del 90% dei cittadini. Il sano patriottismo americano, quel valore condiviso trasmesso già a partire dalle scuole elementari, quando tutti i bambini cantano con la mano sul cuore l’inno nazionale, agì da collante. Il forte sistema di valori condivisi ha tenuto unita una nazione devastata in un momento storico terribile.
COME CAPIRE LA CULTURA DI UN’ORGANIZZAZIONE?
Andrew Pettigrew1 aggiunge un ulteriore elemento alla definizione di cultura come collante: “La cultura è il sistema di significati pubblicamente accettati, operante per un gruppo determinato in un momento determinato”, ponendo enfasi su come questi valori possano cambiare, e in genere mutino quando varia il leader del gruppo o si devono fronteggiare crisi. Per decifrare la cultura di un villaggio, inteso come organizzazione, bisogna quindi osservarne i simboli, gli eroi, i rituali, le regole scritte e non scritte, le storie che circolano e i valori condivisi dai membri in un dato momento specifico, chiedendoci: “Sono compatibili con i nostri valori e il nostro background culturale?”.
Ma quali sono i fattori da considerare, per valutare questa nostra compatibilità? Tra le centinaia di studi e analisi sui concetti di cultura, Hofstede ne fornisce una chiave di lettura straordinariamente efficace. Nel libro Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, vengono elencate diverse caratteristiche come per esempio: l’individualismo, la disuguaglianza, la distanza dal potere, l’avversione all’incertezza. Vediamole nel dettaglio.
Individualismo: in una cultura individualista ci si attende che ciascuno si prenda cura di se stesso e sono esaltate concezioni della vita basate sull’autonomia assoluta. La cultura degli Stati Uniti è fortemente orientata in questa direzione: ne sono esempio il proliferare continuo degli eroi di produzione hollywoodiana o la resistenza cronica verso qualunque forma di controllo delle armi, percepita come una limitazione alla libertà. Al contrario, in una cultura collettivistica sono maggiormente rilevanti valori come l’ordine, la sicurezza, la famiglia, il bene comune. Le persone nascono e crescono in ampie famiglie o clan che le proteggono in cambio della loro lealtà.
Disuguaglianza: il concetto di disuguaglianza è definito in base al livello di tollerabilità che una nazione, o un’organizzazione, ha al suo interno. Si pensi per esempio ad alcuni Paesi, come il Messico o la Russia: ci sono poche centinaia di persone ricche all’inverosimile mentre la stragrande maggioranza della popolazione vede peggiorare sempre più le proprie condizioni economiche e sociali. Cosa vuol dire? Stiamo forse tollerando, con una contagiosa indifferenza nel nostro modo di pensare, che un crescente grado di disuguaglianza sia normale e accettabile?
Distanza dal potere: un’altra dimensione importante per capire le culture è la distanza dal potere, che indica la misura in cui una società accetta che il potere sia distribuito in modo ineguale. Ricordo che anni fa avevo un capo originario dell’India, proveniente da una casta privilegiata: non perdeva occasione di ricordarlo a tutti, pretendendo all’estero gli stessi privilegi di cui avrebbe beneficiato in patria. Non si faceva mai scrupolo di utilizzare la sua posizione per chiedere a tutti, me compreso, favori personali, commissioni private, o di servirgli il caffè. All’inizio acconsentii alle sue richieste, ma dopo un paio di mesi mi vidi costretto a dirgli che non avrei più fatto niente che non facesse parte dei miei doveri di lavoro. Lui reagì con sincero stupore al fatto che mi stessi ribellando a un’abitudine consolidata. In un altro scenario, molti anni più tardi, mi trovai nella situazione completamente opposta, stavolta con un capo svizzero. Un giorno lui uscì dal lavoro molto presto, ma lo rividi tornare in ufficio dopo circa due ore perché aveva dimenticato le chiavi di casa. Gli dissi che avrebbe dovuto chiamarmi e che gliele avrei portate volentieri, visto che sarei tornato a casa comunque e che abitavamo molto vicino. “Abbiamo abolito la schiavitù in Svizzera, non te lo avrei mai chiesto”, mi rispose. Questi esempi sono esplicativi di una diversa concezione della distanza dal potere, intesa come il grado di accettabilità sociale di disuguaglianze: l’India ha un grado di accettabilità molto alto e la Svizzera, al contrario, un grado molto basso.
Avversione all’incertezza: un’alta avversione all’incertezza – da intendersi come instabilità economica, lavorativa – comporta un livello elevato di aggressività, che si traduce in un impulso a lavorare duramente e a essere intollerante verso i devianti. L’incertezza è sentita come una minaccia continua alla propria stabilità, per la quale bisogna combattere. Si esige che le regole, scritte e non scritte, vengano osservate e rispettate in modo assoluto. Prendiamo in esame il modo di vestirsi o di parlare che hanno le persone che fanno parte di un’organizzazione. Sono tutte uguali? Come vengono trattati coloro che non si adattano a queste regole?
Le caratteristiche elencate da Hofstede diventano rilevanti per valutare la cultura delle organizzazioni. In base a queste, abbiamo la possibilità di comprendere l’identità di un’organizzazione e domandarci se davvero ne vorremmo far parte.
Se pensiamo alla cultura come a uno strumento che ci aiuta a vivere, secondo la magistrale definizione di Jomo Kenyatta, presidente del Kenya dal 1964 al 1978, possiamo utilizzare quanto appreso da Hofstede. Risulterà più semplice farsi rapidamente un’idea del grado di disuguaglianza accettato nelle organizzazioni. Per esempio, osservando l’architettura e l’ampiezza degli uffici, da sempre un privilegio visibile legato al potere. All’Unione Africana, l’equivalente dell’Unione Europea con sede ad Addis Abeba, ogni Commissario, il grado gerarchico più alto, ha un piano intero a propria disposizione. Al World Economic Forum nessuno ha un ufficio, tutti lavorano in open space.
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
“Nel 1951 iniziai la mia carriera in Giappone in una prestigiosa azienda, con grandi speranze e aspirazioni. Trovai regole rigide e non scritte di lavoro – o di non lavoro – come per esempio quella di non uscire mai dall’ufficio prima del tuo capo e di presenziare alle interminabili ubriacature al bar insieme ai tuoi colleghi. In questo ambiente non erano accettate idee nuove, l’unica cosa che contava era l’assoluta devozione e fedeltà del subordinato al capo che, in cambio, lo avrebbe protetto. In questo ambiente non c’era nessuno spazio per le donne di talento, non solo per fare carriera ma pure per sopravvivere. Anche per un uomo come me, non vedevo nessun futuro… Le cose non sono cambiate in Giappone. Fortunatamente, dopo aver sopportato anni di soffocamento e sofferenza, fui assunto da un’azienda americana nella filiale giapponese, dove ho lavorato per il resto della mia vita, prima di andare felicemente in pensione negli Stati Uniti.” Questo è il messaggio inviato dal lettore dell’Economist Muneyuki Nakano e pubblicato sul settimanale il 19 aprile 2014; in poche righe si capisce la vera e propria sofferenza di una persona che si sentiva soffocata da una cultura che non riusciva a digerire.
Caratteri cubitali all’entrata della lobby: Integrità, Comunicazione, Rispetto, Eccellenza. Eravamo all’Enron, quasi tutti i dirigenti sono finiti in prigione per frode; l’azienda non esiste più: bancarotta fraudolenta. Eppure avevano esposto esattamente queste parole, chiamate value statement, in bella evidenza. È chiaro che non era esattamente così.
Molte aziende utilizzano parole simili. Sta a noi individuare quali siano i veri valori, la reale cultura dell’organizzazione, non quello che viene proclamato.
Come si fa allora a capire quale sia la cultura che fa esattamente per noi? In questo capitolo svelo alcuni trucchi – tutti assolutamente legali – utili per scoprire l’anima delle organizzazioni e per evitare errori potenzialmente costosi.
Nell’Introduzione vi ho già segnalato quanto sia fondamentale valutare un lavoro in base a criteri che noi stessi abbiamo stabilito. Per garantirci la possibilità di compiere la migliore scelta possibile dobbiamo osservare, capire, studiare determinate caratteristiche dell’organizzazione presso la quale intendiamo lavorare:
1. Come svolgono i colloqui?
2. Quale linguaggio parlano?
3. Chi viene assunto e promosso, e perché?
4. Che cosa è successo alla persona che ricopriva l’incarico prima di noi?
5. Quali sono i sistemi di incentivi?
6. Quali sono i cinque numeri cui prestare attenzione?
7. Quali sono le regole del gioco, scritte e non?
Osservando questi aspetti, facendo domande pertinenti, otterremo informazioni utili a prendere le giuste decisioni, come una vera e propria bussola che guida nella corretta direzione collegata a un radar per evitare ostacoli. Per capire se un villaggio sia quello giusto per noi, non serve una laurea in management, abbiamo già tutto quello che ci serve. Anzi, dirò di più: se per caso avessimo una laurea in management, per cortesia dimentichiamoci di quello che pensiamo di sapere. Dobbiamo solo notare, osservare, porre domande chiave, fare un po’ di ricerca, usare l’intuito, diventare una via di mezzo tra l’archeologo, il ricercatore e l’esploratore. Per spie...