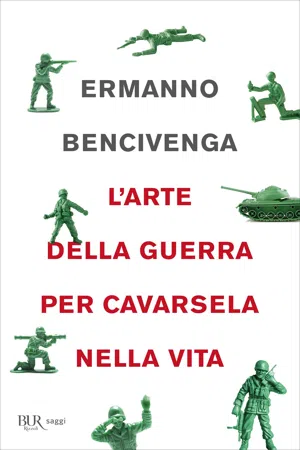Pochi Stati sono divisi da un’inimicizia così radicale, nel mondo contemporaneo, come Israele e l’Iran. Per citare solo qualche evento significativo, l’ayatollah Khamenei ha definito Israele «un tumore canceroso» e nel 2005 il presidente Ahmadinejad dichiarò che doveva essere spazzato via. Per anni, il servizio segreto israeliano è stato sospettato di aver assassinato diversi scienziati nucleari iraniani, mentre nel 2012 l’Iran è stato considerato responsabile di un attentato a un autobus in Bulgaria, in cui persero la vita turisti israeliani. Oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è il critico più spietato dell’accordo che l’Iran ha stretto con i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti), con la Germania e con l’Unione Europea per bloccare lo sviluppo di ordigni atomici, primo segno di distensione internazionale dopo decenni di attrito. Potrà dunque stupire il fatto che i due Paesi siano accomunati da un profondo rispetto per uno stesso uomo, quello che gli iraniani chiamano «Padre» e nella Bibbia è chiamato – in Isaia 45:1 – «Messia», «Unto del Signore», unico non ebreo a ricevere questo epiteto. L’uomo è Ciro, il fondatore dell’impero persiano, il Gran re che estese i suoi domini più di quanto chiunque avesse fatto prima di lui: dalle coste orientali del Mediterraneo fino all’India.
Ciro fu un guerriero straordinario. Erede al trono dei persiani ma vassallo dei medi, su cui regnava Astiage (che era suo nonno), si ribellò, sconfisse e depose Astiage, ma gli risparmiò la vita e si riconciliò con lui sposandone la figlia. Marciò poi contro la Lidia, che occupava la maggior parte dell’Anatolia, ne sbaragliò il re Creso, ritenuto all’epoca l’uomo più ricco del mondo, ma, seguendo lo schema che gli era abituale, lo mantenne come proprio consigliere. Fu poi la volta di Babilonia, presa nell’autunno del 539 a.C., dopo che il suo esercito venne distrutto da quello persiano nella battaglia di Opis. A quel punto l’intera Asia sudoccidentale, esclusa la penisola arabica, era nelle sue mani, ma Ciro continuò a combattere, e morì combattendo contro i massageti, che abitavano le steppe degli odierni Kazakistan e Uzbekistan.
Non è sulle sue vittorie, però, che intendo porre l’accento qui, ma sul suo modo di utilizzarle per costruire uno Stato armonioso e giusto, perché è questa sua caratteristica ad averne fatto una figura riverita nei secoli. Con la complicità di Senofonte, che nella Ciropedia ne tracciò un ritratto nobile e magnanimo, Ciro è rimasto un modello di saggezza e di equilibrio per vari personaggi, da Alessandro Magno, che dopo averne conquistato l’impero ordinò di restaurarne la tomba, a Thomas Jefferson, che possedeva due copie della Ciropedia e vi si ispirò nel preparare la Dichiarazione d’indipendenza. Quando nel 2003 Shirin Ebadi ricevette il premio Nobel per la pace, prima iraniana e prima donna islamica a cui sia stato assegnato, durante il suo discorso di accettazione disse:
Ciro è rimasto un modello di saggezza e di equilibrio.
Io sono iraniana, discendente di Ciro il Grande, l’imperatore che duemilacinquecento anni fa, al culmine del suo potere, proclamò che non avrebbe regnato sul popolo se il popolo non lo voleva. E promise di non costringere nessuno a cambiare la sua religione e fede e garantì la libertà a tutti. La Carta di Ciro il Grande è uno dei documenti più importanti che dovrebbero essere studiati nella storia dei diritti umani.
La Carta menzionata da Ebadi è il cosiddetto Cilindro di Ciro, un cilindro di terracotta inciso in caratteri cuneiformi, scoperto nel 1879 e conservato al British Museum, in cui il Gran re dichiara di aver migliorato la vita dei cittadini di Babilonia – che lo acclamavano come «Liberatore» –, di aver ripristinato templi e santuari e aver rimpatriato popoli esiliati. Per quanto l’attendibilità del documento abbia ricevuto la sua parte di critiche, appare innegabile che, quantomeno, Ciro abbia posto fine all’esilio degli ebrei a Babilonia, e questo è il motivo per cui viene chiamato «Messia» nella Bibbia. In Esdra 6:3-5 è riportato il suo editto in proposito:
Nell’anno primo del re Ciro, il re Ciro prese questa decisione riguardo al tempio in Gerusalemme: la casa sia ricostruita come luogo in cui si facciano sacrifici; le sue fondamenta siano salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la sua larghezza di sessanta cubiti. Vi siano nei muri tre spessori di blocchi di pietra e uno di legno. La spesa sia pagata dalla reggia. Inoltre gli arredi del tempio fatti d’oro e d’argento, che Nabucodonosor ha portato via dal tempio di Gerusalemme e trasferito a Babilonia, siano restituiti e rimessi al loro posto nel tempio di Gerusalemme e ricollocati nella casa di Dio.
Quanto a popoli diversi dagli ebrei, questo dice Senofonte nell’epilogo della Ciropedia:
Chi altri se non Ciro fu in grado di morire, dopo aver demolito un impero, ricevendo dai sudditi l’appellativo di Padre (evidentemente più degno di un benefattore che di un usurpatore)?
L’immagine di Ciro tramandata dalle varie fonti che ne parlano, dunque, è quella di un uomo e un sovrano generoso, in particolare generoso con i vinti. Da questa immagine c’è molto da imparare. Si impara che la guerra è solo una fase di un confronto tra popoli, quindi va gestita in modo tale da facilitare quelle successive. È una tentazione naturale, quando se ne esce trionfanti, approfittare della propria condizione di superiorità per umiliare il nemico. È però una tentazione pericolosa, e per illustrare tale pericolo riferirò un altro aneddoto relativo a Ciro.
La guerra è solo una fase di un confronto tra popoli, quindi va gestita in modo tale da facilitare quelle successive.
Narra Erodoto che Solone, semimitico legislatore di Atene e uno dei sette savi dell’antica Grecia, si recò in visita da Creso e il re, per impressionarlo, gli fece visitare la sua reggia e quindi gli chiese chi fosse per lui l’uomo più felice del mondo. Solone rispose: Tello di Atene, che morì eroicamente in battaglia e fu celebrato dai suoi concittadini. Deluso, il re gli chiese allora chi fosse per lui il secondo uomo più felice del mondo e Solone rispose: a pari merito, i fratelli Cleobi e Bitone, i quali, un giorno in cui la madre voleva andare a una cerimonia religiosa, ma non erano disponibili i buoi per tirare il suo carro, si aggiogarono loro stessi al carro e lo trasportarono a destinazione, guadagnandosi lodi entusiaste e morendo entrambi quella notte. Incapace di trattenersi, Creso protestò che Solone continuava a parlare di morti, mentre lui era ben vivo, ricco e potente, ma non gli veniva riconosciuta la felicità di cui dava prova. Solone rispose, in sostanza, che non si sa mai. Poi il regno di Creso fu invaso da Ciro, i suoi cari furono uccisi o ridotti in schiavitù, le sue ricchezze furono confiscate e lui stesso fu legato a una pira per essere arso vivo. Al che Creso si mise a gridare: «Solone, avevi ragione!». Ciro, incuriosito, lo fece tirar giù e gli domandò spiegazioni. Quando Creso gliele fornì il Gran re, riflettendo sulla caducità e variabilità delle umane sorti, gli salvò la vita.
L’aneddoto è probabilmente apocrifo, ma mi servirà per sviluppare il mio discorso. È certo possibile che la generosità fosse una dote naturale di Ciro, un tratto del suo carattere. Questa storia però mostra che esistono anche ottimi e razionali motivi per essere generosi, che si riassumono in una frase che ho appena usato: non si sa mai. Chi vince oggi forse perderà domani, quindi farebbe bene a non montarsi la testa e a non approfittare troppo della sua vittoria. Nella migliore delle ipotesi, cioè se riuscisse a mantenere la posizione di privilegio, il suo comportamento esaspererebbe l’avversario e lo indurrebbe a nuove forme di aggressione. Nella peggiore, questi nuovi attacchi sconvolgerebbero la situazione e lo trasformerebbero da vincitore in perdente. Se pure l’episodio raccontato da Erodoto non rispondesse a verità, possiamo immaginare che esso si sia svolto nella mente di Ciro, quando si trovava dalla parte del vincitore, e che lui ne abbia tratto un ammonimento ad agire con moderazione.
Un esempio recente e molto appropriato di questa dinamica è offerto dalle potenze occidentali all’indomani delle due guerre mondiali. Dopo la Prima, nel trattato di Versailles, imposero alla Germania condizioni estremamente punitive, favorendo il manifestarsi, nei tedeschi, di un forte spirito di rivalsa e aprendo la strada al successo del nazismo e allo scoppio ravvicinato di una nuova guerra, più sanguinosa della precedente. Dopo la Seconda, agirono in modo opposto, condonando in buona parte i debiti di guerra e anzi adoperandosi concretamente per incoraggiare la ripresa economica dei Paesi sconfitti; le conseguenze furono una pace europea che dura da più di settant’anni e la trasformazione dei membri dell’Asse (Germania, Italia, Giappone) in solidi alleati dell’Occidente. C’è da rimpiangere che Israele e l’Iran non abbiano finora voluto imitare questo esempio.
Il mio filosofo preferito, Immanuel Kant, sostiene che bisognerebbe condurre la guerra come se si potesse in ogni momento interromperla per far posto alla pace. In altre parole, durante la guerra non si dovrebbe mai perdere il rispetto umano del nemico – mai demonizzarlo, mai trattarlo in modo incivile e disumano – e, a conflitto concluso, andrebbe fatto del proprio meglio per ristabilire condizioni di normale convivenza.
Proviamo a pensare negli stessi termini alla nostra convivenza con vicini, colleghi, amici, avversari o concorrenti: in questi rapporti attraverseremo inevitabilmente periodi di tensione e di scontro. Con il senno di poi, dall’esterno di quei periodi, sarà ovvio vederli come fasi del rapporto, soprattutto se saremo riusciti a superarli. Quel che impariamo da Ciro, da Kant e dalle potenze occidentali all’indomani della Seconda guerra mondiale è che sarebbe vantaggioso – oltre che giusto dal punto di vista morale, ammesso che la cosa abbia per noi un peso – renderci conto della natura in linea di principio passeggera delle ostilità anche dall’interno delle ostilità stesse, mentre avvengono.
Durante la guerra non si dovrebbe mai perdere il rispetto umano del nemico.
In qualsiasi momento di uno scontro, possiamo scegliere fra comportarci in modo distruttivo o generoso. Anche se lo scontro non è terminato, avendo acquisito un piccolo vantaggio, dobbiamo scegliere se sfruttarlo al massimo, senza fare prigionieri (se girare il dito nella piaga), o invece offrire una prospettiva di accordo, di riconciliazione. Scegliere il primo corno del dilemma si rivolterà contro di noi, non subito forse, ma a lungo andare.
Spesso mi capita, osservando i dibattiti politici in televisione, di rimanere perplesso davanti alla cieca vanità di chi ha vinto le ultime elezioni e, appollaiato sul pulpito di colui che ha avuto temporaneamente ragione, si rivolge agli altri in tono saccente e beffardo; fantastico quindi su come sarebbe davvero spiazzante (ed efficace) se uno di questi personaggi tendesse per una volta la mano ai suoi interlocutori, trovasse qualcosa di corretto in quel che dicono, accettasse, senza venir meno alla propria coerenza, qualcuna delle loro proposte. Se, per una volta, si mostrasse generoso.
Ma lasciamo i politici al loro destino e pensiamo alle tensioni e agli scontri che viviamo in famiglia, in ufficio, nel condominio o nelle scuole dei nostri figli, a come il viverli con generosità, rinunciando alle facili soddisfazioni che ci offrirebbe un’occasionale supremazia, potrebbe risolvere quelle tensioni invece di aggravarle, far cessare quegli scontri invece di rimandarli. È significativo, in un libro dedicato alla guerra, che la lezione offerta dal primo dei nostri grandi strateghi ci inviti a guardare oltre la guerra, quella fra Stati e quella che combattiamo a livello individuale, e a riflettere su quanto sarebbe meglio non dire e non fare, in guerra, ciò che in seguito potremmo rimpiangere. Su quanto la generosità mostrata da Ciro il Grande si riveli spesso l’arma, anzi, no, non l’arma, ma lo strumento più prezioso.
Il periodo dal 722 al 481 a.C., in Cina, è detto delle primavere e degli autunni; il nome deriva dagli Annali delle primavere e degli autunni, attribuiti a Confucio. Fu un’epoca di grande confusione politica, in cui la dinastia Zhou, che governava dal 1045, perse gradualmente potere, mentre vari stati feudali acquisirono crescente autonomia, impegnandosi in continue guerre gli uni contro gli altri. Verso la fine di questo periodo, intorno al 512, il re Helu dello stato di Wu assunse come generale Sun Tzu e, con la sua collaborazione, guadagnò una posizione di preminenza fra le potenze rivali (durò solo una decina d’anni). Non è chiaro se Sun Tzu sia davvero esistito, e non è chiaro quanta fede dobbiamo prestare all’aneddoto che viene narrato sul suo incarico. Secondo il racconto, il re lo mise alla prova chiedendogli di organizzare il suo harem di centottanta concubine in due eserciti contrapposti. Sun Tzu divise le donne, mettendo a capo le due favorite del re. Poi ordinò loro di girarsi a destra, ma in risposta ricevette dei risolini. Diede l’ordine di girarsi a sinistra, ottenendo lo stesso risultato. Pretese allora che le due favorite fossero decapitate. Il re protestò, ma Sun Tzu gli spiegò che, se i soldati non obbediscono, la colpa è degli ufficiali e che un generale, una volta in carica, deve assolvere il suo compito indipendentemente dalle proteste del re. Le due donne furono così messe a morte e le altre presero a comportarsi con perfetta disciplina. Una leggenda, probabilmente, misogina come spesso sono le leggende, ma un’indicazione significativa del clima cinico e pragmatico che si respira nel testo per cui Sun Tzu – reale o meno che sia stato, un po’ come Omero – è ancora famoso: L’arte della guerra, una raccolta di aforismi che per venticinque secoli è stata oggetto di attenta lettura da parte di aspiranti strateghi.
Molti dei temi trattati da Sun Tzu sono diventati patrimonio comune e alcuni riaffioreranno nei capitoli successivi: una guerra prolungata è dannosa per lo Stato; i viveri vanno procacciati in territorio nemico; occorre adattarsi alle condizioni del campo e dell’avversario e non rimanere legati a un unico schema; il successo è basato sull’efficace controllo delle truppe – chiedete a quelle concubine!–, sulla rapidità di movimento e sulla capacità di concentrare le proprie forze su un punto debole dello schieramento nemico. Qui mi limiterò a discutere il tema che in Sun Tzu sembra dominante, come nell’Odissea prevale la caratterizzazione del protagonista «ricco di astuzie»: la guerra non è soltanto, e neppure soprattutto, una questione di forza; la si combatte in primo luogo con menzogne e trabocchetti, con gli «stratagemmi». «La guerra si fonda sull’inganno.»
Il nemico va osservato con costante attenzione, traendo informazioni dai comportamenti in apparenza più modesti: «Quando i soldati si appoggiano alle loro lance, sono deboli per il desiderio di cibo. Se coloro che sono stati mandati a prendere l’acqua cominciano per primi a bere, l’esercito soffre di sete». «La vista di uomini bisbiglianti in piccoli capannelli o sottovoce è segno di disaffezione tra i ranghi e le file.» D’altro canto, dobbiamo adoperarci perché il nemico si faccia un’idea errata delle nostre condizioni: «Un comandante qualificato [...] sostiene false impressioni [...] sacrifica qualcosa affinché il nemico possa cadere in trappola». «Un disordine simulato richiede una perfetta disciplina, e un timore simulato richiede coraggio; una debolezza simulata ipotizza una forza.» «In guerra, pratica la dissimulazione e vincerai.» E naturalmente dobbiamo accorgerci se il nemico sta cercando a sua volta di ingannare noi: «Proposte di pace non accompagnate da un giuramento convenzionale indicano un tranello [...] Quando alcuni sono visti avanzare e altri indietreggiare, è un tranello». Due millenni e mezzo prima di John von Neumann sembra di leggere un minitrattato di teoria dei giochi, in cui il bluff, l’imbroglio e l’identificazione dei bluff e degli imbrogli altrui sono vitali per imporsi, a poker come sul campo di battaglia.
L’ultima parte del libro, la tredicesima, è dedicata all’uso delle spie. Comincia con una saggia considerazione sui costi economici e sociali della guerra:
Radunare un esercito di centomila uomini e farli marciare a grandi distanze comporta dei forti aggravi sul popolo e un impoverimento per le risorse dello stato. La spesa quotidiana ammonterà a mille once ...