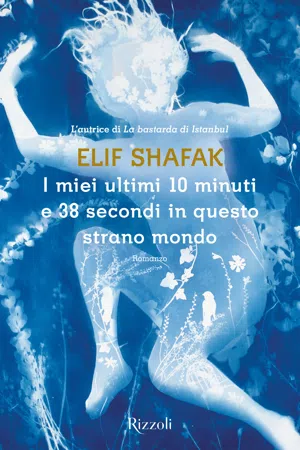Nel primo minuto successivo alla sua morte, la coscienza di Leila Tequila cominciò a scemare, in modo lento e costante, come la marea che si allontana dalla riva. Le cellule del suo cervello, a corto di sangue, erano ormai del tutto prive di ossigeno, ma non si spensero. Ancora no.
Un’ultima riserva di energia attivò innumerevoli neuroni, collegandoli come per la prima volta. Benché il cuore avesse cessato di battere, il cervello resisteva, guerriero fino alla fine: in uno stato di intensa consapevolezza, osservava il venir meno del corpo ma non era pronto ad accettare il proprio. La memoria di Leila Tequila si sprigionò, impaziente e accurata, decisa a raccogliere i pezzi di una vita che stava correndo verso la fine. Prese a rievocare cose che nemmeno sapeva di poter ricordare, cose che aveva creduto perse per sempre; il tempo divenne fluido, una corrente veloce di ricordi che si infiltravano l’uno nell’altro, passato e presente inseparabili.
Il primo ricordo che le tornò in mente riguardava il sale: la sensazione che lascia sulla pelle e il sapore che lascia sulla lingua.
Si rivide da neonata: nuda, viscida e rossa. Era uscita da pochi secondi dall’utero di sua madre, sgusciando per un passaggio bagnato e scivoloso, colta da una paura per lei completamente nuova, e adesso eccola in una stanza piena di suoni, colori e cose sconosciute. La luce del sole attraverso le vetrate colorate chiazzava la trapunta sul letto e si rifletteva nell’acqua di un catino di porcellana, nonostante fosse un gelido giorno di gennaio. In quella stessa acqua una donna anziana vestita con i colori delle foglie d’autunno – la levatrice – intinse un asciugamano e lo strizzò, facendosi colare il sangue lungo l’avambraccio.
«Mashallah, mashallah. È una femmina.»
La levatrice prese una punta di selce che teneva infilata nel reggiseno e tagliò il cordone ombelicale. Per farlo non usava mai coltelli, né forbici: trovava che la loro fredda efficienza non fosse adatta a quel gran pasticcio che è accogliere un bambino in questo mondo. La vecchia era molto apprezzata nel quartiere e considerata, con tutta la sua eccentricità e misantropia, una di quelle persone misteriose la cui personalità ha due facce, una terrena e una ultraterrena, e che, come una moneta lanciata in aria, possono rivelare in qualsiasi momento l’una o l’altra.
«Una femmina» fece eco la giovane madre sdraiata nel letto a baldacchino in ferro battuto, con i capelli color del miele impastati di sudore e la bocca secca come la sabbia.
Lo aveva temuto, che sarebbe andata così. Poco tempo prima aveva fatto una passeggiata in giardino in cerca di ragnatele tra i rami; trovatane una, ci aveva infilato con cura un dito. Poi, per diversi giorni, l’aveva tenuta d’occhio: se il ragno avesse riparato il buco, sarebbe nato un maschio. Ma la tela era rimasta lacera.
La ragazza si chiamava Binnaz, «mille lusinghe». Aveva diciannove anni, anche se quell’anno si sentiva molto più grande. Aveva labbra piene e generose, un naso delicato e all’insù che in quella parte del Paese era considerato una rarità, un viso lungo con il mento a punta e grandi occhi scuri punteggiati di macchie azzurre come le uova di storno. Era sempre stata snella e di corporatura esile, ma ora lo pareva ancor di più, nella camicia da notte di lino beige. Aveva qualche tenue segno di vaiolo sulle guance; una volta sua madre le aveva detto che li aveva perché era stata accarezzata dal chiaro di luna mentre dormiva. Le mancavano, sua madre, suo padre e i suoi nove fratelli, che vivevano in un paesino a diverse ore di distanza. La sua famiglia era molto povera, cosa che da quando, novella sposa, era entrata in quella casa, le veniva ricordata spesso:
Sii riconoscente. Quando sei arrivata qui, non avevi nulla.
E nulla continuava ad avere, pensava spesso Binnaz; tutti i suoi beni erano effimeri e privi di radici, come i semi dei soffioni: un vento forte, un acquazzone torrenziale, e sarebbero spariti così, come niente. La opprimeva il fatto che da quella casa poteva essere cacciata in qualsiasi momento; e se fosse successo, dove sarebbe andata? Suo padre non se la sarebbe mai ripresa, con tutte quelle bocche da sfamare. Si sarebbe dovuta risposare, ma non stava scritto da nessuna parte che il matrimonio successivo sarebbe stato più felice o il nuovo marito più di suo gradimento… E poi chi l’avrebbe voluta, una divorziata, una donna usata? Appesantita da questi timori, si muoveva per casa, in camera da letto, dentro la sua stessa testa, come un’ospite non invitata. Almeno fino ad allora. Perché adesso sarebbe stato tutto diverso, con la nascita della bambina, si disse. Non si sentiva più così a disagio, non più così insicura.
Quasi contro la propria volontà, Binnaz lanciò uno sguardo verso la porta. Lì, con una mano sul fianco e l’altra sulla maniglia – come in dubbio se rimanere o andarsene – c’era una donna dall’aspetto robusto e dalla mascella squadrata. Pur avendo passato da poco la quarantina, i segni dell’età sulle mani e le pieghe attorno alla bocca sottile come una lama la facevano apparire più vecchia. Sulla fronte aveva rughe profonde, irregolari e amplificate, come un campo arato, soprattutto perché aggrottava le ciglia e fumava. Dalla mattina alla sera tirava boccate di tabacco contrabbandato dall’Iran e sorseggiava tè contrabbandato dalla Siria. I capelli, rosso mattone grazie a generose applicazioni di henné egiziano, erano pettinati con la riga in mezzo e formavano una treccia perfetta che le arrivava quasi alla vita. Gli occhi nocciola erano ripassati accuratamente con del kohl scurissimo. Era l’altra moglie del marito di Binnaz, la prima: Suzan.
Per un istante gli sguardi delle due donne si incontrarono. L’aria intorno a loro sembrava densa e sapeva leggermente di lievito, come un impasto che sta crescendo. Avevano condiviso la stanza per più di dodici ore, ma ora si ritrovavano scagliate in mondi separati: sapevano entrambe che con la nascita di quella bambina le loro posizioni in famiglia sarebbero cambiate per sempre. La seconda moglie, malgrado la giovane età e l’arrivo recente, sarebbe stata promossa al vertice.
Suzan distolse lo sguardo, ma non a lungo. Quando tornò a osservare Binnaz, aveva sul viso una durezza che prima non c’era. Fece un cenno verso la bambina. «Perché sta così zitta?»
Binnaz si fece cinerea. «Già, c’è qualcosa che non va?»
«No, niente» rispose la levatrice, lanciando a Suzan un’occhiata fredda. «Dobbiamo solo aspettare.»
La levatrice lavò la neonata con l’acqua santa dal pozzo di Zamzam, avuta grazie a un pellegrino appena tornato dall’hajj. Il sangue, il muco, la vernice caseosa, tutto fu sciacquato via. La neonata iniziò ad agitarsi e continuò a farlo anche dopo il bagnetto, come se stesse litigando con sé stessa, in tutti i suoi tre chili e settecento grammi.
«Me la dai in braccio?» chiese Binnaz, attorcigliandosi i capelli tra le dita, un’abitudine ansiosa che aveva preso nell’ultimo anno. «Però… non piange.»
«Piangerà eccome, questa qui» disse la levatrice in tono deciso, e subito si morse la lingua: la frase suonava come un presagio sinistro. Allora la donna sputò rapidamente a terra per tre volte e si pestò il piede destro col sinistro. Questo avrebbe impedito alla premonizione – se poi lo era – di andare lontano.
Seguì un silenzio impacciato, mentre tutte le presenti – la prima moglie, la seconda moglie, la levatrice e due vicine – scrutavano la neonata con un senso di attesa.
«Che succede? Dimmi la verità» chiese Binnaz a nessuno in particolare, con una voce più tenue dell’aria.
Avendo avuto sei aborti spontanei in pochi anni, ognuno più straziante e più difficile da dimenticare del precedente, per tutta quella gravidanza era stata attentissima. Non aveva toccato nemmeno una pesca perché il bambino non nascesse coperto di peluria; non aveva usato spezie né erbe aromatiche per cucinare perché il bambino non avesse lentiggini o nei; non aveva annusato rose perché al bambino non venissero voglie in faccia. Non si era tagliata i capelli nemmeno una volta per evitare che la fortuna del nascituro fosse scorciata allo stesso modo. Si era astenuta dal piantare chiodi per evitare di colpire in testa qualche spirito malvagio addormentato; e dopo il tramonto, sapendo bene che i jinn organizzavano i loro sponsali intorno ai gabinetti, era sempre rimasta in camera arrangiandosi con un vaso da notte. Conigli, topi, gatti, avvoltoi, porcospini, cani randagi: era riuscita a evitare di guardarli tutti quanti. Anche quando sulla loro via era comparso un musicante che si portava dietro un orso ballerino, e gli abitanti del posto si erano accalcati per assistere allo spettacolo, lei non si era unita a loro, temendo che il suo bambino potesse nascere coperto di peli; e ogni volta che si era imbattuta in un mendicante o in un lebbroso, o che aveva visto un carro funebre, si era voltata e si era allontanata nella direzione opposta. Ogni mattina aveva mangiato un’intera mela cotogna perché al bambino venissero le fossette, e ogni notte aveva dormito con un coltello sotto il cuscino per tenere lontani gli spiriti maligni. E in segreto, ogni sera dopo il tramonto, aveva raccolto i capelli dalla spazzola di Suzan e li aveva bruciati nel camino per ridurre il potere della prima moglie di suo marito.
Non appena erano cominciate le doglie, Binnaz aveva dato un morso a una mela rossa, dolce e ammorbidita dal sole, che ora si andava scurendo pian piano sul comodino accanto al letto. Dopo sarebbe stata tagliata in più pezzi e data alle donne del vicinato che non riuscivano a rimanere incinte, per permettere anche a loro, un giorno, di avere un bambino. Aveva pure sorseggiato del sorbetto al melograno dalla scarpa destra del marito, aveva sparso semi di finocchio nei quattro angoli della camera ed era saltata sopra una scopa posta a terra proprio sulla soglia, come confine per tenere lontano Sheitan. Via via che le doglie si intensificavano, tutti gli animali in gabbia della casa erano stati liberati, uno dopo l’altro, per agevolare il travaglio. I canarini, i fringuelli… L’ultimo era stato il pesce combattente nella boccia di vetro, orgoglioso e solitario, che ora si trovava a nuotare in un torrente nei pressi, con le lunghe pinne fluttuanti e blu intenso, come lo zaffiro più fine. Se avesse raggiunto il lago alcalino per cui quella città dell’Anatolia orientale era famosa, non avrebbe avuto molte possibilità di sopravvivere nelle acque salate e ricche di anidride carbonica. Ma se fosse andato in senso opposto, poteva raggiungere il Grande Zab e, prima o poi, persino arrivare al Tigri, il fiume leggendario che sgorgava dal Giardino dell’Eden.
Tutto questo perché il bambino arrivasse sano e salvo.
«La voglio vedere. Mi porti mia figlia?»
Appena Binnaz ebbe formulato la richiesta, un movimento attirò la sua attenzione. Silenziosa come un pensiero fugace, Suzan aveva aperto la porta ed era scivolata fuori, senza dubbio per dare la notizia a suo marito, al loro marito. Binnaz si irrigidì dalla testa ai piedi.
Harun era un uomo sfavillante nelle sue contraddizioni. Incredibilmente generoso e caritatevole un giorno, e tutto chiuso in sé stesso e quasi reso insensibile dai suoi pensieri il giorno dopo. Il maggiore di tre fratelli, aveva cresciuto da solo i due minori dopo che i genitori erano morti in un incidente automobilistico che aveva distrutto il loro mondo. La tragedia aveva dato forma alla sua personalità, rendendolo iperprotettivo nei confronti della famiglia e diffidente verso il mondo esterno. A volte si rendeva conto che qualcosa gli si era spezzato dentro e desiderava ardentemente poterlo riparare, ma questi pensieri non lo avevano mai portato da nessuna parte. Amava l’alcol e temeva la religione in egual misura. Mentre buttava giù l’ennesimo bicchiere di raqı faceva enormi promesse ai suoi compagni di bevute, e poi, quando si riprendeva, carico di sensi di colpa, ne faceva di ancor più sostanziose ad Allah. Aveva difficoltà a tenere sotto controllo la bocca, ma con il corpo le cose andavano anche peggio: ogni volta che Binnaz era rimasta incinta, la pancia si gonfiava parallelamente anche a lui, non molto, ma quanto bastava perché i vicini gli ridessero alle spalle.
«È di nuovo incinto!» dicevano, levando gli occhi al cielo. «Peccato che non possa pensarci lui, a partorire.»
Harun voleva un figlio maschio più di ogni altra cosa al mondo, e non uno soltanto. A tutti quelli che lo stavano a sentire diceva che ne avrebbe avuto quattro, e che li avrebbe chiamati Tarkan, Tolga, Tufan e Tarik.1 Ma i lunghi anni di matrimonio con Suzan non avevano generato prole; a un certo punto gli anziani della famiglia avevano trovato Binnaz, una ragazza di appena sedici anni, e dopo settimane di trattative fra le famiglie, Harun e Binnaz si erano sposati con una cerimonia religiosa. Non era un matrimonio ufficiale, e se in futuro qualcosa fosse andato storto non sarebbe stato riconosciuto dai tribunali laici, ma era un dettaglio che nessuno aveva sottolineato. I due si erano seduti sul pavimento, davanti ai testimoni, di fronte all’imam strabico la cui voce variava dall’esile al gutturale quando passava dal turco all’arabo. Binnaz aveva tenuto lo sguardo sempre fisso sul tappeto, pur non potendo fare a meno di lanciare occhiate verso i piedi dell’imam i cui calzini, marrone chiaro come fango secco, erano vecchi e logori; ogni volta che l’uomo si spostava, uno degli alluci minacciava di trapassare la lana consunta, cercando una via di fuga.
Poco dopo il matrimonio Binnaz era rimasta incinta, ma la gravidanza si era conclusa con un aborto che l’aveva quasi uccisa. Panico notturno, calde schegge di dolore, una mano gelida che le ghermiva l’inguine, l’odore del sangue, il bisogno di aggrapparsi a qualcosa, come se stesse cadendo senza riuscire a fermarsi. Era andata così a ogni gravidanza successiva, e anche peggio. Non poteva dirlo...