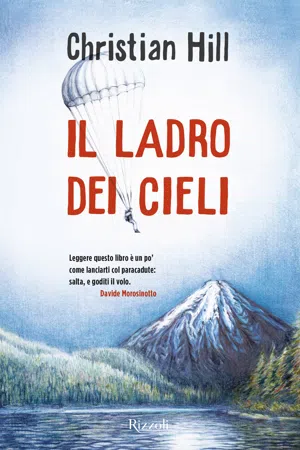Mi ricordo esattamente di quando ho incontrato il vecchio la prima volta.
Eravamo io, Sonny Boy e Derek. E poi, d’accordo, c’erano anche Luiz e Duck, ma loro non contano: non fanno che annuire e ridere a ogni cavolata di Sonny Boy. Tipo: “Domani secondo me non piove”. E loro giù a ridere, come se fosse la battuta del secolo.
Siamo a Santa Fe, quasi in mezzo al deserto: praticamente non piove mai comunque. Almeno da quindici anni, da quando ci sono io. Prima non so.
E, tanto per essere chiari, so anche che avrei dovuto dire che eravamo Sonny Boy, Derek e io. Ma per una volta, visto che questa è la mia storia, facciamo che vengo prima io, okay?
Quindi.
Dicevo.
Eravamo io e gli altri, e stavamo gironzolando fuori dal centro commerciale, di fronte alla vetrina del negozio di chitarre di Harry Wilson. Nella classifica delle vetrine, per me sta in cima. Forse di meglio c’è solo quella con i televisori accesi, quando sono sintonizzati sulle World Series di baseball o roba del genere. Ma le chitarre sono forti. Da guardare, almeno: a suonarle, non saprei nemmeno dove attaccare la spina. Ammesso che ce l’abbiano una spina. Ma sono elettriche, quindi…
Comunque.
Sonny Boy si era procurato delle sigarette e Derek aveva alleggerito la dispensa di casa sua di una bottiglia di Malbec da venti centesimi, che teneva nascosta in un sacchetto di carta decisamente stropicciato.
Stavamo per cominciare la nostra festicciola. O, forse, dovrei dire “stavano”, perché a me le sigarette fanno schifo e il vino pure, soprattutto quella robaccia che compravano i genitori di Derek nel discount all’angolo.
Il sole era ancora alto nel cielo. Sembrava indeciso se cominciare finalmente a puntare verso ovest o starsene ancora lì fermo a farci crepare di caldo.
Ed è arrivato lui.
Il vecchio.
Avrà avuto tipo mille anni, o forse qualcuno in più; è uscito dalle porte del centro commerciale. Il grande paradiso dei vecchi. Con l’aria condizionata e tutto il resto. Doveva essere andato al Fai Da Te, perché aveva il carrello pieno di cianfrusaglie inutili, ammonticchiate così male che era evidente che gli sarebbe caduto tutto a terra al primo dosso. Garantito.
«Ehi» ho detto agli altri, «cinque dollari che gli si ribalta tutto.»
Sonny Boy ha alzato gli occhi. La sigaretta gli penzolava dal labbro, nonostante avesse la bocca aperta. Gli piaceva tenerla così, da quando l’aveva imparato. L’ha presa con le dita unte e ha detto: «Ovvio che gli cade tutto. Non appena succede facciamo una passata veloce e gli portiamo via un po’ di mercanzia».
Usava spesso la parola “mercanzia”. Chissà dove l’aveva imparata.
Comunque Duck e Luiz hanno cominciato a battere le mani e a sghignazzare.
Derek ha avvitato il tappo della bottiglia. «Ci sto.»
E così è andata.
Non al primo dosso, ma al secondo: il carrello si è inclinato e anche se lui ha provato a rimetterlo dritto, una tonnellata di fuffa è precipitata a terra.
Sbadabam!
«Via!» ha sibilato Sonny Boy e si è lanciato su quella robaccia come un falco in picchiata.
E noi dietro.
Mentre il vecchio cercava di ricordare come si facesse a piegare la schiena e contemporaneamente le ginocchia per raccogliere le cose da terra, aveva già attorno Sonny Boy e Derek e Luiz e Duck che si chinavano, prendevano qualcosa e via a perdifiato.
Io ero l’ultimo. Avevo corso anche io, intendiamoci, ma non ero mica tanto convinto di quello che stavamo facendo. Insomma, va bene farsi due risate alle spalle di una mummia che cammina, ma rubargli della roba che a noi non serviva, che senso poteva avere? Si vedeva lontano un chilometro che era roba da niente. Lo capiva anche un bambino. Eppure noi era così che vivevamo. Nel niente e per niente.
Intanto, però, mentre pensavo queste cose, correvo.
Ed è stato in quel momento che lui è scattato.
Ha fatto una specie di balzo, di sterzata, non lo so. Tant’è che me lo sono ritrovato proprio in traiettoria.
Ho provato a frenare. Ho messo le mani avanti. Ho imprecato.
Ma gli sono finito addosso comunque.
È stato come abbracciare un sacco vuoto. Non pesava niente e così me lo sono portato dietro per quasi un metro. Per fortuna non è caduto, altrimenti andava a finire che si spaccava, mille pezzi di vecchietto a rotolare sull’asfalto del parcheggio con le sue cianfrusaglie inutili.
E poi ci siamo fermati.
Lui mi ha guardato.
Aveva gli occhi castani.
Cavolo, che occhi.
«Che botta» mi ha detto.
Non capivo se stesse tossendo o ridendo o se magari da lì a un attimo sarebbe morto soffocato.
«S-scusi» gli ho risposto, con un filo di voce.
Avevo anch’io il fiatone, ma non era per la botta. Era più un fiatone per la vergogna, di quelli che salgono dallo stomaco quando ti beccano che stai facendo una cosa stupida, e lo sai benissimo che è stupida.
Con la coda dell’occhio vedevo i miei amici che avevano raggiunto una Pontiac verde pisello e mi controllavano a distanza, gli eroi. E intanto mi lasciavano lì con il vecchio ancora in braccio.
Lui si è scostato, si è dato una spazzolata alla giacca economica e ha aggiunto: «Questa roba non vale niente, prendetevela pure, se ne volete…».
Mi ha indicato questo e poi quello e quell’altro pezzo di lamiera, un po’ ammaccato, un po’ arrugginito, con la vernice un po’ scrostata. E la sua mano, ecco, la sua mano era messa peggio delle cianfrusaglie che erano rotolate per terra: aveva le dita deformate, piegate, nodose, con le giunture gonfie. La pelle, praticamente trasparente, era punteggiata di macchioline come quella di un giaguaro.
Mi sorrise.
E sembrava davvero allegro. Non c’era dubbio. I suoi denti erano gialli, soprattutto gli incisivi. E anche i baffi bianchi, al centro, sopra la bocca, erano color della birra. Solo gli occhi sembravano quelli di un giovane. Cioè, l’ho già detto, ma è una cosa importante. Erano occhi di uno ancora vivo. Vivo davvero, intendo.
«Sul serio» ha continuato. «Chiama pure i tuoi amici, e se volete un po’ di questa robaccia, avanti.»
Non sapevo cosa rispondere e nemmeno cosa fare. Avevo quasi deciso di scappare, perché quel tipo di conversazione mi stava mettendo a disagio, quando lui ha aggiunto con tono fermo: «Solo, dopo che vi siete presi quello che volete, datemi una mano a raccogliere il resto perché a piegarmi ho un po’ di problemi». Era un ordine.
Sono rimasto lì, a guardarlo per tipo quindici secondi di fila. Che però mi è sembrata tutta la mia vita, perché il tempo non scorre mica sempre alla stessa velocità, e anche questo lo sapevo bene.
«Affare fatto?» mi ha chiesto il vecchio, tendendo la mano.
Ci ho messo un po’ a capire che voleva che gliela stringessi, tipo come se stessimo facendo un accordo vero. Ci avrei scommesso le mutande che si aspettava una stretta di quelle lunghe e forti da veri uomini, ma quell’ammasso di nodi poteva essere stata una mano ai tempi dei cowboy e degli indiani, forse. Adesso era un reperto da museo, non una cosa che si poteva stringere tanto allegramente. E se gliel’avessi stritolata?
«Affare fatto?» ha ripetuto, tirando la mano ancora un po’ più su.
No, davvero, cosa avrei potuto fare? Ho lanciato un’altra occhiata ai miei amici, ma se ne stavano ancora tutti in tribuna dietro la Pontiac, e quasi potevo sentirli, i loro pensieri: “Ecco quello scemo di Rust che si sta facendo mettere sotto da una mummia”.
E allora l’ho fatto e amen: gli ho preso la mano e l’ho stretta.
Era fredda.
La pelle, ruvida e asciutta, sembrava quasi gommosa. E nella mia stretta le ossa si muovevano come legnetti gettati alla rinfusa in un sacchetto.
«Vacci piano, ragazzo!» ha commentato il vecchio, senza però perdere il sorriso. «Se me la stringi ancora me la sbricioli!»
Ho mollato la presa di scatto.
«Scusi» ho mormorato.
«Io sono John» ha detto lui, «John Carter. E tu?»
Ecco che di nuovo non sapevo cosa fare. Se gli dicevo il mio nome, poi magari quello mi denunciava. E se non glielo dicevo, mica mi sentivo di aver fatto una cosa da uomo.
E quindi gliel’ho detto.
«Rusty Secatero» ho risposto, ma piano, tipo che speravo non sentisse. Non era poi così impossibile.
Lui ha corrucciato le sopracciglia e fatto un passo indietro. «Secatero? È un nome da pellerossa. Ma tu non sembri…»
Niente, mi succedeva sempre: non mi sono mai offeso quando mi davano del pellerossa anziché del “nativo americano”, come invece dicevano in televisione, ma con un accento tale che ti faceva sentire che tra loro e te c’era più distanza che fra la Terra e la Luna. Quello che mi dava fastidio è che mi domandassero perché io NON fossi un pellerossa.
E comunque quella vecchia cartuccia aveva le mani di un cadavere ma l’udito di un neonato, a quanto pareva. Stava fissando i miei capelli rossi. Tutti fissano sempre i miei capelli rossi. Secondo Sonny Boy dovevo tingerli, per fare carriera nel mondo del crimine. Tipo di nero. Ma io non ci volevo nemmeno pensare. Né al crimine, né a far carriera.
«Mio padre…» gli ho risposto, col tono di chi si sta giustificando. «Ma mia mamma è irlandese.»
Il vecchio ha ridacchiato. E mentre mi guardava un’ultima volta ha aggiunto: «Be’, complimenti al sangue irlandese, allora: si vede solo quello!».
In realtà, anche mio padre era un mezzo sangue. Credo che solo suo nonno fosse un autentico Comanche. Comunque il nome era rimasto.
Quello rimane sempre.
«Rusty. O ...