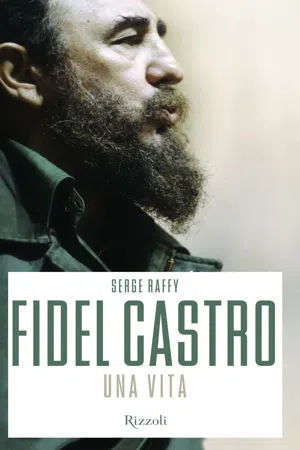![]()
1
«Sporco ebreo!»
L’insulto era partito come una coltellata, più tagliente della lama di un machete. Il bambino non se lo aspettava. Si sentiva diverso dagli altri, sapeva che i suoi compagni di collegio, con i loro sguardi in tralice e i loro stupidi sogghigni, lo squadravano come una specie di bestia rara. All’inizio non capiva perché, in un tono tanto carico di disprezzo, gli lanciassero quello sferzante «Sporco ebreo!». Fidel rimaneva interdetto e credeva che i compagni di scuola lo paragonassero al piccolo uccello dal becco nero curiosamente chiamato judío, che pullula nelle pianure di Cuba. Per quale motivo affibbiare proprio a lui il nome del volatile dei Caraibi? Forse perché, come quell’uccello, faceva fatica a trovare la sua casa?
Di fronte a quell’ingiuria il ragazzino, ferito, alzava le spalle. Tuttavia percepiva che doveva esserci qualcosa di vero in quella storia, ma c’era un mistero che gli sfuggiva. Più si sforzava e meno riusciva a comprendere il motivo dell’isolamento al quale era condannato. Era forse maledetto? Aveva commesso un errore imperdonabile, qualche sacrilegio?
In realtà, come l’uccello caraibico, Fidel non aveva un vero nido. Tale era l’enigma che lo accompagnava.
Furono infine i frati maristi spagnoli del collegio di La Salle, a Santiago di Cuba, a illuminarlo in proposito. Loro stessi non si mostravano molto concilianti con lui, lo maltrattavano regolarmente e spesso lo facevano sentire come l’ultimo degli ultimi, ma un giorno gli avevano svelato la singolare situazione in cui si trovava. A differenza dei suoi compagni, a sette anni, Fidel Ruz non era ancora stato battezzato. Negli anni Trenta, nella cattolicissima Cuba, un bambino non battezzato non poteva che essere ebreo. Così, il piccolo Fidel aveva chiesto se fosse ebreo. I frati gli avevano risposto che non lo era: era soltanto un po’ in ritardo nel suo percorso religioso. Che cosa si aspettava dunque per battezzarlo? Per quale misteriosa ragione gli era precluso un rito che sembrava così importante e che gli avrebbe permesso di essere trattato come gli altri? E se i frati gli avevano mentito? Se in realtà lui era davvero ebreo? Tormentato da un simile dubbio, il ragazzino si sentiva come perso. I voti a scuola erano pessimi e il suo comportamento in classe inqualificabile.
Durante le lezioni di catechismo, aveva imparato che «gli ebrei avevano assassinato il figlio di Dio». Alla luce di quella rivelazione, Fidel aveva cominciato a pensare di essere in parte responsabile della morte di Gesù Cristo. Come poteva guadagnarsi il perdono per un crimine così infamante? Quale castigo gli sarebbe piovuto addosso? La sera, ritornando a casa dai suoi tutori, si interrogava: «Sono dunque un mostro?».
Non riuscendo a ottenere una risposta soddisfacente, Fidel decise di diventare davvero un mostro. Il piccolo paria si era fatto insopportabile, aveva moltiplicato le provocazioni nei confronti degli adulti, veniva continuamente punito e rifiutava ogni autorità. Non riteneva di dover rendere conto a nessuno, poiché solo l’Altissimo era in grado di giudicarlo. Ogni giorno, Fidel si aspettava di essere gettato nelle fiamme dell’inferno. Presto o tardi l’assassino di Cristo avrebbe ricevuto la sua meritata punizione.
![]()
2
L’Ángel e le bestie
Si chiamava Ángel Castro y Argiz. Aveva lo sguardo cupo degli uomini che hanno fatto l’abitudine alla morte e al sangue, e i tratti duri del contadino taciturno e scaltro. Veniva da lontano, da una valle ricca di selvaggina, querce ed eucalipti, nella provincia spagnola di Lugo, in Galizia, una regione aspra e mistica dove si celebravano Dio, gli spiriti della foresta, gli elfi, le fate e le streghe. Una terra in cui si credeva che le pietre e il vento avessero un’anima. I suoi genitori erano poveri fittavoli. Possedevano quattro miseri ettari di un fondo rustico, coltivavano fagioli e ciliegie e il loro unico bene consisteva in una catapecchia dove uomini e bestie vivevano nello stesso locale, riscaldato da un focolare centrale chiamato lareira.
Ángel Castro nacque il 5 dicembre del 1875. Era rugoso come la sua terra e, all’età di vent’anni, si arruolò nell’esercito per andare a combattere a Cuba. In cambio di millecinquecento pesos, partì al posto del figlio di una famiglia della borghesia locale, come succedeva all’epoca a numerosi giovani spagnoli di origini modeste. Ángel era analfabeta e ignorava tutto di Cuba. Il suo era solo un tentativo di sfuggire alla povertà. Per lui, Cuba era un miraggio, un Eldorado tropicale.
Da oltre trent’anni l’isola versava in uno stato di guerra civile quasi permanente, sotto lo sguardo attento e interessato del vicino statunitense. Per le autorità americane, Cuba, geograficamente e storicamente, sarebbe dovuta entrare a far parte degli USA e diventare uno Stato a tutti gli effetti, come la California, il Texas o la Florida. A più riprese, la Casa Bianca aveva persino proposto a Madrid di riscattare l’isola per qualche milione di dollari. Ma invano.
Ángel Castro y Argiz sbarcò all’Avana nel 1895. Assistette alle estorsioni del generale Valeriano Weyler, il sanguinario ufficiale spagnolo che si accanì contro le popolazioni civili sospettate di sostenere la banda di guerriglieri nascosti nella Sierra, in gran parte nella provincia di Oriente. Il conflitto avrebbe potuto trascinarsi per molti anni. Poi, un evento accelerò il processo: il 15 febbraio 1898, l’incrociatore americano Maine, ancorato nel porto dell’Avana, rimase vittima di un’esplosione accidentale. Gli americani sfruttarono la situazione, entrarono in guerra e chiesero alla Spagna di rinunciare a Cuba. In pochi mesi, gli Stati Uniti si imposero come potenza militare di primo piano, infliggendo una severa sconfitta alla Spagna e costringendola a capitolare senza condizioni. Il 10 dicembre dello stesso anno, secondo i termini del trattato di Parigi, Madrid perse il controllo delle Filippine, di Cuba, dell’isola di Guam (a est delle Filippine) e di Porto Rico. Fu la caduta dell’Impero coloniale spagnolo, la fine impietosa e disincantata dell’avventura cominciata quattro secoli prima con l’epopea marittima di Cristoforo Colombo. Per gli storici di lingua spagnola, il 1898 è diventato «l’anno del Disastro».
A ventitré anni Ángel Castro dovette fare ritorno in Galizia, indurito dai trentasei mesi di combattimenti durante i quali aveva assistito ai peggiori abomini: i massacri dei guajiros – i poveri contadini senza terra che appoggiavano la rivolta –, le esecuzioni sommarie, i saccheggi e l’incendio di intere regioni da parte degli indipendentisti. Cuba era un Paese in rovina, un grande campo di stoppie ancora fumanti. Era arrivato il momento della ricostruzione. Ángel esitò a farsi rimpatriare con i resti di un esercito sconfitto e poco glorioso: con il denaro guadagnato come soldato avrebbe potuto restare a Cuba, ricominciare una nuova vita nel Paese, dove l’aria era carezzevole e gli agrumi sembravano crescere senza bisogno di cure. Ma doveva tornare a Láncara, il suo villaggio natale, per ricongiungersi alla sua promessa sposa.
Una terribile notizia, tuttavia, lo attendeva al suo rientro: la fidanzata non lo aveva aspettato. Tutti lo avevano dato per morto, e lei aveva sposato un altro. Fuori di sé dal dolore, umiliato, Ángel riprese le sue cose e se ne andò a La Coruña, il porto del nord. Da lì si imbarcò sul primo piroscafo con destinazione L’Avana. Per dimenticare. Il sole di Cuba cicatrizza tutto, anche le ferite più profonde.
Nel 1899, quando rimise piede sul suolo cubano, Ángel Castro rimase sbalordito. In pochi mesi, gli americani si erano insediati sull’isola e avevano fatto energicamente ripartire l’economia locale. Avevano investito oltre centosessanta milioni di dollari, in particolare nella provincia di Oriente, tra Holguín e Santiago. Il loro obiettivo era lo sviluppo della coltura intensiva della canna da zucchero, destinata al mercato statunitense. Costruirono una linea ferroviaria nella zona di Mayarí, regione particolarmente fertile, vicino alla baia di Nipe. Nella stessa area, la United Fruit Company acquistò più di centomila ettari di terreno e si mise alla ricerca di manodopera. Per un uomo determinato e nel pieno vigore degli anni le opportunità di impiego non mancavano. I dirigenti della società americana ricostruirono Banes, città che era stata devastata dalla guerra. Lì installarono la loro sede e, nella baia di Nipe, edificarono un porto cui venne dato il nome di Antilla e dal quale partivano le merci per Boston e New York. Ángel si stabilì in quella regione in fermento e si mise a lavorare sodo. In un primo tempo venne ingaggiato come operaio sulle linee ferroviarie, poi diventò venditore ambulante sulla ferrovia: offriva acqua e gassosa ai tagliatori di canna da zucchero. Presto, grazie alla conoscenza di un colono spagnolo originario delle Canarie, Fidel Pino Santos, Ángel cominciò prima ad affittare alcuni ettari di terreno dalla United Fruit Company nella zona di Birán, e poi ad acquistarli, uno dopo l’altro.
Pur di ingrandire la sua impresa, Ángel Castro era pronto a tutto. Si dimostrava spietato con i tagliatori di canna da zucchero, di solito haitiani, che trattava duramente, ma anche con i «cugini» galiziani che faceva arrivare a Cuba tramite alcuni trafficanti che li ingaggiavano con contratti quadriennali. Si mormorava che avesse il grilletto facile e che non esitasse a sbarazzarsi degli operai ribelli o troppo esigenti. Questa voce, tuttavia, non ha mai trovato conferma.
In quel Nuovo Mondo implacabile e violento, Ángel si guadagnò la reputazione di duro impietoso nei confronti dei nemici e di uomo inflessibile negli affari. Veniva trattato come un ladrón, ma, al suo avvicinarsi, tutti abbassavano gli occhi. Dopo alcuni anni, a forza di lavoro, sudore, astuzia e violenza, lo spagnolo venuto da Láncara divenne noto come «don» Ángel. Fiero e ieratico, percorreva in lungo e in largo la sua tenuta in sella a un destriero bianco, con una pistola alla cintura. In casa teneva due fucili sempre pronti all’uso. A Birán, Ángel Castro aveva l’impressione di non essere mai partito dalla Galizia, perché il paesaggio che si estendeva tutt’intorno e quello della valle di Láncara si assomigliavano molto. Nonostante il successo economico e sociale, don Ángel provava un certo rimpianto per la terra natale. Soffriva di quella che i galiziani chiamano morriña, la nostalgia del proprio Paese. Eppure perché avrebbe dovuto cercare di tornare al suo villaggio, dove era stato così dolorosamente umiliato da una donna? Ángel sapeva che non sarebbe mai più rientrato in patria. Era troppo orgoglioso per farlo.
In quelle condizioni, come mantenere il legame con le proprie radici? Ángel Castro decise di costruire a Birán, sul fianco della collina, una casa in stile galiziano, una dimora in legno tropicale eretta su palafitte, come le belle casas de campesinos della sua terra dove alla sera le bestie – mucche, cavalli, maiali, capre, polli – andavano a dormire sotto il tetto del signore del posto. Allestì anche una piccola arena per i combattimenti dei galli. I braccianti la frequentavano durante i fine settimana, dilapidando il loro magro salario nelle scommesse che spesso finivano in risse.
In quel clima piuttosto primitivo, don Ángel si trovava perfettamente a suo agio. Aveva una sola passione: il bestiame. Aveva l’anima di un ganadero, un allevatore. Insieme all’amico Fidel Pino Santos, percorreva per ore le terre di loro proprietà. Detestava andare in città, dove era costretto a frequentare avvocati, uomini politici, commercianti e amministratori della United Fruit. Quella gente non aveva niente in comune con lui. Soltanto Fidel Pino Santos comprendeva la sua natura. A lui solo, inoltre, riuscì a confessare di essere analfabeta.
Fu proprio l’amico delle Canarie a offrire a don Ángel qualche consiglio sulla gestione della finca, la sua tenuta. Gli suggerì innanzitutto di imparare a leggere e a scrivere. Gli spiegò che un grande proprietario terriero doveva tenersi informato, consultare i giornali e seguire l’andamento del mercato dello zucchero. E gli presentò la maestra della scuola elementare americana di Banes, María Luisa Argota, una donna dolce e colta. Don Ángel, oltre a imparare da lei a leggere, la prese in moglie. Nacquero due figli, Pedro Emilio e Lidia. Rispettato e temuto, il cacicco di Birán era un uomo felice. Lui, un tempo analfabeta, aveva sposato la maestra della scuola frequentata dai figli della buona società americana di Banes.
Ma a quel punto aveva bisogno anche di protezioni politiche. Divenne così il più fedele sostenitore dell’amico Fidel Pino Santos, consigliere comunale di Banes nonché dirigente del Partito conservatore. Don Ángel preferiva restare lontano dalla ribalta. Amava il potere, ma solo sulle sue terre, che all’epoca si estendevano per oltre diecimila ettari. Decise che avrebbe fatto politica unicamente per proteggere i suoi interessi di grande proprietario terriero. Scaltri e pragmatici, don Ángel e Fidel Pino Santos sapevano che a Cuba niente era possibile senza l’appoggio degli americani.
Questi ultimi, dopo aver sognato di annettere tutto il territorio cubano, optarono per una soluzione meno radicale. Nel 1902, l’esercito americano lasciò il Paese e Washington impose al governo della neonata Repubblica cubana l’emendamento Platt, dal nome del negoziatore americano che aveva autorizzato gli Stati Uniti a intervenire militarmente negli affari del Paese qualora i loro interessi fossero stati minacciati. In poche parole, Cuba era sotto tutela. La Repubblica non era altro che un simulacro. E, cosa più grave, alla fine della guerra americani e spagnoli avevano escluso dalla tavola dei negoziati del trattato di Parigi i mambises, i rappresentanti della borghesia indipendentista che si erano impegnati in una lotta di oltre trent’anni contro i «colonialisti» spagnoli. I capi della ribellione, che avevano creduto all’aiuto sincero degli «yankee», si sentirono beffati e raggirati. Per loro gli Stati Uniti d’America rappresentavano un modello di democrazia, all’opposto della Spagna, chiusa nella sua opprimente arcaicità. Trascurando i mambises, gli statunitensi commisero una grave ingiustizia. Un errore che, cinquant’anni dopo, sarebbe pesato sulle relazioni tra America e Cuba. Una parte rilevante della popolazione dell’isola riteneva di essere stata ingannata. Di fronte ai milioni di dollari che piovevano su Cuba, la tutela di Madrid sembrava infinitamente più flessibile, o perlomeno più lontana. Il nuovo «colono», onnipresente e onnipotente, si era accampato a due passi dalle coste cubane. Alcuni già rimpiangevano i señoritos, i padroni di Madrid. La stampa dell’Avana attaccava i «quaccheri di Wall Street, complici dei banchieri ebrei» che volevano «affogare le chiese cattoliche nei loro dollari».
Senza farsi troppi scrupoli, don Ángel però favorì i gringos, gli statunitensi che lo avevano sconfitto qualche anno prima. Lui era un immigrato diverso dagli altri: era avido di terre, sebbene non cercasse di atteggiarsi a nuovo ricco. Era il padrone assoluto sui suoi possedimenti, il «Caudillo di Birán».
Un giorno, María Luisa Argota ricevette la visita inaspettata di una donna chiamata Dominga Ruz. Da qualche tempo Dominga si era sistemata nella tenuta, in un bohío, una capanna a circa un chilometro dalla casa padronale. Il marito, Francisco, lavorava nei campi di canna da zucchero. Dominga era una mulatta piena di energia, andata a cercare fortuna nella prospera regione di Oriente. La famiglia Ruz era originaria della provincia di Pinár del Río, dalle parti di Artemisa, e aveva attraversato tutta l’isola su un carro trainato da buoi. Il racconto dell’odissea di Dominga colpì don Ángel. Si diceva, inoltre, che la donna fosse dotata di poteri magici: una specie di strega, proprio come le meigas della Galizia. Per aiutarla, don Ángel assunse una delle sue tre figlie come domestica a Manacas. La ragazza si chiamava Lina, era vivace e sfrontata e aveva quattordici anni, la stessa età di sua figlia Lidia. María Luisa Argota accettò di buon grado la nuova domestica: non poteva sospettare di aver appena lasciato entrare in casa sua la sventura.
Non passò molto tempo prima che il padrone di Birán mettesse gli occhi sulla giovane, la quale ben presto rimase incinta. Nacque una bambina, Ángela, che sarebbe stata allevata in casa della nonna Dominga. Intanto, la famiglia Castro decise di ignorare «l’incidente». Dopo tutto, erano molte le haciendas in cui i figli illegittimi non si contavano. Poco tempo dopo venne alla luce un secondo bambino, Ramón. Lina continuò ad allevarlo insieme alla prima figlia in casa dei genitori, una misera catapecchia di argilla, pietre e paglia. Di tanto in tanto, don Ángel andava a dare un’occhiata ai figli illegittimi, sebbene intendesse mantenere il riserbo su tutta la faccenda.
Cogliendo tutti di sorpresa, María Luisa Castro Argota, la moglie discreta e sottomessa, rifiutò di fingersi ignara della situazione e reagì. Sperduta nelle colline di Birán, a venti chilometri da Banes, in un luogo che era possibile raggiungere soltanto a cavallo, María Luisa era alla mercé di don Ángel, per il quale il fatto di avere due famiglie contemporaneamente non costituiva alcun problema. I suoi due figli legittimi, Pedro Emilio e Lidia, avevano raggiunto l’età per frequentare le scuole superiori e María Luisa decise di sistemarsi a Santiago con loro, adducendo il pretesto di volerli seguire negli studi. Perlomeno, a Santiago non avrebbe dovuto subire l’umiliazione di vedere la concubina del marito che andava a fare le pulizie in casa sua. Senza saperlo, così facendo María Luisa aveva lasciato campo libero a Lina. L’adolescente sfrontata si era ormai trasformata in una donna. Dinamica e volitiva, l’ex domestica si impose nella casa di Manacas come la «nuova padrona». E, soprattutto, lei e Ángel si amavano. Il 13 agosto 1926, quando mise al mondo il suo terzogenito, Lina era raggiante. Per quel figlio, don Ángel scelse il nome del suo caro amico: il bambino si sarebbe chiamato Fidel.
A Santiago, María Luisa accusò il colpo. Per la legge, Lina rimaneva l’amante illegittima e i suoi figli erano dei «bastardi», senza alcun diritto a ricevere un’eredità. Ma per don Ángel, che amava la vita agreste, niente era più importante della forza della terra, della natura. In fondo, Lina era proprio la donna adatta a lui: ambiziosa, ribelle e analfabeta, simile in tutto ad Ángel quando era più giovane. Inoltre, dimostrava lo stesso carattere selvaggio e ritroso, lo stesso amore per gli animali del «Caudillo di Birán». In quel mondo rustico, la maestra di scuola faceva la figura dell’intellettuale noiosa e troppo delicata. Lina, invece, apparteneva alla terra, aveva il viso abbronzato dei campagnoli, non esitava a portare i pantaloni e a imbracciare un fucile. María Argota, che suonava il pianoforte e leggeva i classici della letteratura inglese, avrebbe potuto davvero contrastare un simile rapporto? Forse non le rimaneva che un’unica scelta. Da Birán le giungevano voci secondo cui il marito riceveva sempre più spesso i suoi bastardi nella finca. E María Argota chiese il divorzio.
A quell’epoca – la fine degli anni Venti – il divorzio era rarissimo, quasi inconcepibile. La Chiesa cattolica romana lo condannava senza appello. L’affaire Castro suscitò un enorme scandalo. La sposa legittima consultò i giuristi di Santiago. Suo marito aveva tutte le colpe. Era lui a vivere nel peccato e la sua posizione era giuridicamente indifendibile.
Ángel Castro intuì che la sua situazione era delicata. Il «Caudillo» rischiava di perdere il suo patrimonio in un procedimento di separazione. Soprattutto, a nessun costo voleva dividere Manacas, la finca, le terre, i campi di canna da zucchero, il bestiame, le colline, i palmeti e i torrenti, con quella donna di città che, in fin dei conti, non aveva mai amato il suo mondo. Aiutato dall’amico Fidel Pino Santos, don Ángel elaborò un piano per aggirare la legge. Organizzò il proprio fallimento e, per un certo periodo, abbandonò il suo patrimonio e le sue terre nelle mani dell’amico. Don Fidel Pino Santos divenne il proprietario di tutti i beni del galiziano. Da uomo magnanimo, concesse ad Ángel la «gestione» della finca. In questo modo, subito dopo la nascita del figlio Fidel, don Ángel era ufficialmente in rovina, giuridicamente intoccabile e finanziariamente insolvibile. Un classico da divorzio? Non certo a quell’epoca.
Per rendere più credibile tutta la vicenda, per qualche tempo Lina fece ritorno al bohío dei genitori insieme ai tre figli. Le difficili condizioni di vita non la spaventavano. Era una donna temprata nella fatica. In compenso, si disperava perché i bambini non erano battezzati. Lei praticava una religione molto diffusa a Cuba, che fondeva elementi cattolici e riti africani: la santería. Lina, però, voleva assolutamente che la sua discendenza fosse consacrata da un prete. Nessun sacerdote avrebbe osato mai trasgredire le leggi della Chiesa per battezzare i suoi figli. Ma Lina era una donna tenace ed ebbe un’idea. Nel 1930, in piena crisi economica, Lina Ruz, con l’assenso di don Ángel, decise di mandare a vivere Ángela, Ramón e Fidel presso alcuni a...