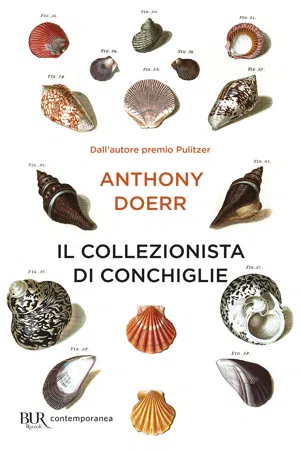![]()
Il guardiano
Joseph Saleeby ha trentacinque anni, e da quando è nato sua madre gli rifà il letto e gli prepara da mangiare a ogni pasto; ogni mattina gli fa leggere una colonna del dizionario di inglese, scelta a caso, prima di lasciarlo uscire. Vivono in una casetta fatiscente sui rilievi fuori Monrovia, in Liberia. Joseph è alto, silenzioso e malaticcio; dietro le lenti degli occhiali troppo grandi per lui, il bianco degli occhi è giallino. Sua madre è minuta ma vigorosa; due volte alla settimana si impila sulla testa due canestri di verdura e fa dieci chilometri a piedi per andarli a vendere al suo banco nel mercato di Mazien Town. Quando i vicini vengono a farle i complimenti per l’orto, sorride e offre loro una Coca-Cola. «Joseph sta riposando» dice; loro sorseggiano la Coca e le guardano alle spalle, verso le finestre scure chiuse, dietro le quali immaginano il ragazzo sudato e delirante nella brandina.
Joseph è impiegato alla Liberian National Cement Company; trascrive fatture e ordini d’acquisto in uno spesso libro mastro rilegato in pelle. Ogni tre o quattro mesi paga una fattura in più e stacca un assegno a se stesso. Dice alla madre che i soldi in più fanno parte del suo stipendio e più ripete questa bugia, più si sente a suo agio. Ogni giorno, all’ora di pranzo, sua madre gli porta del riso in ufficio; il pepe che ci sparge generosamente sopra tiene lontane le malattie, gli ricorda, e lo guarda mangiare seduto alla scrivania. «Bravo, così» gli dice. «Contribuisci a rafforzare la Liberia.»
Nel 1989 la Liberia piomba in una guerra civile che durerà sette anni. La fabbrica di cemento viene sabotata e poi trasformata in un’armeria per i guerriglieri: Joseph si ritrova senza lavoro. Comincia a far girare roba rubata nei negozi della città: scarpe da ginnastica, radio, calcolatrici, agende. Non fa male a nessuno, si dice, i saccheggi li fanno un po’ tutti, i soldi ci servono. Tiene le cose in cantina e dice alla madre che sono scatole che gli ha affidato un amico. Quando la madre è al mercato arriva un camion e porta via la merce. Di notte Joseph paga due ragazzi perché frughino nei sobborghi, forzino finestre, scardinino porte e gli lascino il bottino nello spiazzo dietro casa.
Passa quasi tutto il tempo accovacciato su un gradino davanti a casa a guardare la madre che cura l’orto. La donna strappa erbacce da terra, elimina tralci morti, coglie fagiolini corallo lasciandoli cadere ritmicamente in una ciotola di metallo; lui la ascolta inveire contro gli stenti della guerra, fare prediche sull’importanza di mantenere una vita disciplinata. «Non possiamo smettere di vivere solo perché si combatte, Joseph. Dobbiamo tenere duro.»
Sui colli lampeggiano raffiche; sopra la casa rombano gli aerei. I vicini non li vengono più a trovare; i colli vengono bombardati, più e più volte. Di notte si vedono alberi in fiamme, come avvisi di mali peggiori in arrivo. Davanti a casa sfrecciano tra gli schizzi furgoni rubati pieni di poliziotti con le armi poggiate sui predellini e gli occhi celati dagli occhiali a specchio. Venite a prendermi, vorrebbe gridare Joseph, in direzione dei vetri oscurati e delle cromature. Provateci. Ma non lo fa; tiene la testa bassa e fa finta di avere da fare con i rosai.
Una mattina di ottobre del 1994 la madre di Joseph si avvia al mercato con tre canestri di patate dolci e non torna. Joseph si aggira per i filari dell’orto, sente i tonfi lontani dell’artiglieria, i gemiti delle sirene, gli interminabili silenzi nel mezzo. Quando finalmente l’ultimo lembo di luce scompare dietro le colline, va dai vicini. Quelli lo squadrano da dietro il cancelletto di sicurezza che impedisce l’accesso alla camera da letto e lo avvertono: «Hanno ammazzato tutti i poliziotti. I guerriglieri di Taylor saranno qui da un momento all’altro».
«Mia madre…»
«Sàlvati» dicono, e sbattono la porta. Joseph sente rumore di catenacci e di un paletto. Esce dalla casa e si ferma nella strada polverosa. All’orizzonte si levano colonne di fumo sotto il cielo rosso. Un momento dopo si incammina fino a dove finisce la strada lastricata e imbocca la pista fangosa che porta a Mazien Town, quella che ha seguito sua madre la mattina. Al mercato vede quello che si aspettava: fuochi, un camion bruciato, casse sventrate, ragazzi che saccheggiano i banchi. Su un carretto ci sono tre corpi: nessuno è di sua madre, nessuno gli è familiare.
La gente che incontra non gli rivolge la parola. Quando blocca una ragazza che passa di corsa, le cadono dalle tasche delle musicassette; lei guarda da un’altra parte e non gli risponde. Dove c’era il banco di sua madre c’è solo un mucchio di compensato ridotto a carbone, ben impilato, come se qualcuno avesse già cominciato la ricostruzione. Quando finalmente rincasa, ha già fatto giorno.
La sera dopo – sua madre non è tornata – esce di nuovo. Fruga tra i resti dei banchi del mercato; grida il nome della madre nei passaggi abbandonati. Dove prima era agganciata a due pali di ferro l’insegna del mercato, adesso hanno appeso un uomo a testa in giù. Ha le interiora di fuori che gli oscillano tra le braccia come nere corde infernali, fili recisi di una marionetta.
I giorni successivi Joseph si spinge anche più lontano. Vede uomini che trascinano ragazze incatenate; si fa da parte per lasciar passare un autocarro col cassone stracolmo di cadaveri. Per venti volte lo fermano e lo importunano; ai posti di blocco improvvisati i soldati gli premono la bocca del fucile contro il petto e gli chiedono se è liberiano, se è krahn, perché non combatte i krahn insieme a loro. Lo lasciano andare, ma prima gli sputano sulla camicia. Sente dire che una banda di guerriglieri che indossano maschere di Paperino si è messa a mangiare gli organi dei nemici; sente di terroristi in scarpini da calcio che camminano sui pancioni delle donne incinte.
In giro non c’è nessuno che mostri di sapere dov’è sua madre. Seduto sul gradino davanti alla porta, guarda i vicini che gli razziano l’orto. I ragazzi che pagava per saccheggiare i negozi non vengono più. Alla radio un militare che si chiama Charles Taylor si vanta di aver ammazzato cinquanta caschi blu nigeriani con quarantadue proiettili. «Muoiono proprio facile» si compiace. «È come far fuori le lumache con il sale.»
Dopo un mese, senza aver saputo di sua madre niente di più rispetto alla sera che è scomparsa, Joseph si mette sotto il braccio il dizionario, si imbottisce di soldi la camicia, i pantaloni e le scarpe, chiude a chiave la cantina – gremita di quaderni, medicine per il raffreddore, stereo e un compressore, tutto rubato – e si mette in cammino. Per un tratto viaggia insieme a quattro cristiani che stanno fuggendo in Costa d’Avorio; poi si unisce a una banda di ragazzi armati di machete che vagano di villaggio in villaggio. Sulle cose che vede – bambini decapitati, giovanotti drogati che sventrano una ragazza incinta, un uomo appeso a un balcone con in bocca le mani mozzate – è meglio non approfondire. In tre settimane ne vede a sufficienza per dieci vite di incubi. In Liberia, nel corso di quella guerra, non si seppellisce nulla, e tutto quello che era già sepolto torna allo scoperto: i cadaveri giacciono impilati nelle latrine all’aperto, i bambini in lacrime trascinano per la strada i corpi dei genitori. I Krahn ammazzano i Mano, i Gio ammazzano i Mandingo, metà di quelli che vanno per strada sono armati, metà dei crocicchi sanno di morte.
Joseph dorme dove può: tra le foglie, in un cespuglio, sul pavimento di una casa abbandonata. Nel cranio gli esplode un dolore. Ogni settantadue ore è sconvolto dalla febbre: va a fuoco e poi gela. I giorni in cui non è febbricitante gli fa male respirare; ci deve mettere tutta l’energia che ha, per continuare a camminare.
Alla fine arriva a un posto di blocco dove due soldati rancorosi non lo lasciano passare. Joseph recita la sua storia meglio che può: la scomparsa della madre, i tentativi di scoprire che fine ha fatto. Non è né Krahn né Mandingo, assicura; mostra il dizionario, che loro gli requisiscono. La testa gli pulsa con regolarità; lui si chiede se abbiano in mente di ammazzarlo. «Ho dei soldi» dice. Si sbottona il colletto e fa vedere le banconote che tiene nella camicia.
Uno dei soldati parla alla radio per qualche minuto e poi torna. Ordina a Joseph di salire su una Toyota e lo porta per un lungo vialetto, oltre un cancello. File apparentemente interminabili di alberi della gomma scorrono in vista di una villa col tetto a tegole. Il soldato lo porta al di là della casa, oltre un cancelletto, in un campo da tennis dove c’è una decina di ragazzi sui sedici anni, che poltriscono su sedie da giardino, con in grembo fucili da assalto. La luce del sole si riflette bianca sul cemento. Loro stanno seduti, Joseph sta in piedi e il sole grava dall’alto. Non parla nessuno.
Dopo vari minuti, dalla porta di servizio della casa esce un capitano madido di sudore che trascina un uomo, traversa la tettoia che porta al campo da tennis e lo lancia a terra sulla linea centrale. L’uomo porta un basco azzurro e ha le mani legate dietro la schiena. Quando lo girano, Joseph vede che gli hanno rotto gli zigomi; ha la faccia avvallata in dentro. «Per un mese» dice il capitano spingendogli le costole col piede, «questo parassita ha pilotato un aereo che bombardava i paesi a est di Monrovia.»
L’uomo cerca di mettersi a sedere. Gli occhi gli vanno alla deriva nelle orbite in modo osceno. «Sono un cuoco» dice. «Vengo da Yekepa. Mi fanno, prendi la strada per Monrovia. Ci provo. Ma poi mi arrestano. Per piacere. Preparo le bistecche. Non ho bombardato nessuno.»
I ragazzi sulle sedie da giardino sbuffano. Il capitano toglie il basco all’uomo e lo fa volare oltre la recinzione. A Joseph il dolore in testa si fa più acuto; vorrebbe accasciarsi; vorrebbe sdraiarsi all’ombra e dormire.
«Hai ammazzato un sacco di gente» dice il capitano al prigioniero. «Perché non dici la verità? Perché non confessi quello che hai fatto? In quei paesi sono morte madri, bambine. Secondo te non c’entri niente col fatto che sono morte?»
«Per piacere! Sono un cuoco! Cuocio le bistecche allo Stillwater Restaurant di Yekepa! Andavo a trovare la mia ragazza!»
«Bombardavi le campagne.»
L’uomo cerca di dire qualcos’altro ma il capitano gli preme la scarpa da ginnastica sulla bocca. Si sente un suono lontano di qualcosa che si sgretola, come ciottoli che sfregano dentro uno straccio. «Tu» fa il capitano indicando Joseph. «Sei quello a cui hanno ammazzato la madre?»
Joseph sbatte le palpebre. «Vendeva verdura al mercato di Mazien Town» risponde. «Non la vedo da tre mesi.»
Il capitano estrae la pistola dalla fondina e la porge a Joseph: «Questo parassita avrà ammazzato un migliaio di persone. Madri e figlie. Mi fa vomitare solo guardarlo». Mette le mani sui fianchi di Joseph; lo attira a sé come se stessero ballando. La luce che si riflette sul campo da tennis è abbagliante. I ragazzi guardano seduti, bisbigliano. Il soldato che ha portato qui Joseph è appoggiato alla recinzione e si accende una sigaretta.
Le labbra del capitano sono nell’orecchio di Joseph. «Fai un favore a tua madre» gli mormora. «Fai un favore a tutta la tua nazione.»
Joseph ha la pistola in mano; il calcio è tiepido e scivoloso per il sudore. Il mal di testa si fa ancora più vivo. Tutto quello che ha davanti – le file di alberi immobili e polverose, il capitano che gli respira nell’orecchio, l’uomo sul cemento, che ora cerca debolmente di strisciare, come un bambino malato – si dilata e si sfoca; è come se gli si fossero liquefatte le lenti degli occhiali. Pensa a sua madre che si incammina per l’ultima volta verso il mercato, al sole e all’ombra del lungo sentiero, al vento che si fa strada tra le foglie. Doveva andare con lei; doveva andare al suo posto. Doveva essere lui a sentirsi aprire il terreno sotto i piedi, lui a scomparire. L’hanno vaporizzata con una bomba, pensa. L’hanno ridotta in fumo con una bomba. Perché lei pensava che ci servivano i soldi.
«Vale meno del sangue che ha in corpo» sussurra il capitano. «Vale meno dell’aria che ha nei polmoni.»
Joseph alza la pistola e spara in testa al prigioniero. Il suono del colpo viene assorbito presto, dissipato dall’aria spessa, dagli alberi pesanti. Joseph cade in ginocchio; dietro gli occhi gli esplodono razzi di luce luccicanti. Gira tutto, bianchissimo. Si accascia sul petto e sviene.
Si risveglia a terra, dentro la villa. Il soffitto è spoglio e crepato e una mosca ci ronza contro. Joseph esce incespicando e si ritrova in un passaggio senza porte ma con in basso gli alberi della gomma che si stendono praticamente fino all’orizzonte. Ha i vestiti bagnati; i soldi – anche quelli sotto le solette degli stivali – non ci sono più.
Sulla porta ci sono due ragazzi buttati su poltrone. Fuori, oltre la recinzione del campo da tennis, Joseph vede il corpo dell’uomo che ha ucciso, insepolto, riverso sul cemento. Scende attraverso le lunghe file di alberi e nessuno dei soldati gli fa minimamente caso. Cammina per un’ora o giù di lì, arriva a una strada; fa un gesto alla prima auto che passa e gli danno acqua e un passaggio fino a Buchanan, fino al porto.
Buchanan è in pace: niente bande di ragazzi armati a pattugliare le strade, nessun aereo a rombare in cielo. Si siede sulla riva e guarda l’acqua sporca avanzare e ritirarsi contro i pali dei moli. Ha in testa un nuovo tipo di dolore, sordo e tremante, che non lo buca più; è il dolore dell’assenza. Vorrebbe piangere, vorrebbe buttarsi nella baia e annegare. Non c’è modo, pensa, di andare abbastanza lontano dalla Liberia.
Sale su una nave cisterna che trasporta prodotti chimici e implora che gli lascino lavare i piatti. Sfrega le stoviglie con cura, sotto la spruzzaglia tiepida che gli si riversa addosso mentre la nave arranca da una parte all’altra dell’Atlantico, nel golfo del Messico e attraverso il canale di Panama. Quando è in cuccetta studia gli altri marinai e si chiede se si capisca che lui è un assassino, se se lo porta scritto in fronte. Di notte si sporge dal parapetto di prua e guarda lo scafo che fende le tenebre. Tutto sa di vuoto e di lacero; ha l’impressione di essersi lasciato dietro mille cose incompiute, mille libri mastri sbagliati. Le onde continuano il loro viaggio anonimo. La nave cisterna si spinge a nord, lungo la costa del Pacifico.
Sbarca ad Astoria, nell’Oregon; la polizia di frontiera gli dice che è un rifugiato di guerra e gli rilascia un visto. Qualche giorno dopo, nell’ostello in cui dorme, gli fanno vedere un’inserzione su un giornale Per la stagione invernale cercasi guardiano in gamba per la tenuta di Ocean Meadows (36 ettari) con frutteto e abitazione. Siamo disperati!
Joseph fa il bucato nel lavandino del bagno e si esamina allo specchio: ha la barba lunga e aggrovigliata, e attraverso le lenti degli occhiali gli occhi hanno un aspetto giallo e deforme. Si ricorda la definizione che dava il dizionario di sua madre: Disperato: che non ha speranza di salvezza, privo di vie d’uscita.
Prende il pullman diretto a Bandon, con cui fa una cinquantina di chilometri sulla 101, e poi percorre a piedi gli ultimi tre chilometri su una strada sterrata senza indicazioni. Ocean Meadows: una piantagione di mirtillo palustre fallita e trasformata in luogo di svago estivo. La casa originaria è stata demolita per costruirci una villa di tre piani. Joseph si fa strada tra la distesa di cocci di bottiglie di vino sulla veranda.
«Mi chiamo Joseph Saleeby e vengo dalla Liberia» spiega al proprietario, un uomo atticciato in stivali da cowboy che si chiama signor Twyman. «Ho trentasei anni, il mio Paese è in guerra, cerco solo pace. Posso riparare le scandole, la veranda, tutto.» Mentre parla gli tremano le mani. Twyman e la moglie si allontanano e si strillano delle cose al di là delle porte della cucina. La figlia smunta e taciturna trascina sul tavolo una ciotola di cereali, mangia in silenzio e se ne va. L’orologio appeso alla parete suona una volta e poi un’altra.
Alla fine Twyman riappare e lo assume. Sono due mesi che mettono annunci, spiega, e l’unico che si è presentato è lui. «È il tuo giorno fortunato» dice e osserva con cautela gli stivali di Joseph.
Gli danno un paio di vecchie tute da lavoro e l’appartamento sopra il garage. Il primo mese la tenuta è stracolma di ospiti: bambini, neonati, giovanotti sulla veranda che gridano nel cellulare, una sfilata di donne sorridenti. Hanno fatto i milioni con qualcosa che c’entra con i computer; quando scendono dalla macchina controllano se ci sono graffi sulla portiera; se ne trovano uno si leccano un pollice e cercano di farlo sparire. Vodka-tonic lasciati a metà sulle balaustre, musica di chitarra dalle casse trascinate in veranda, il ronzio delle vespe attorno ai piatti mezzi pieni, sacchi della spazzatura rigonfi che si accumulano nel capanno: è quello che resta di loro, è il lavoro di Joseph. Aggiusta un fornello della cucina a gas, spazza via la sabbia dai corridoi, gratta via salmone dalle pareti dopo che gli ospiti si sono tirati le cose da mangiare. Quando non lavora, sta seduto sul bordo della sua vasca da bagno e si rimira le mani.
A settembre Twyman gli porta un elenco di lavori da svolgere in inverno: installare le controfinestre esterne, arieggiare i prati, eliminare ...