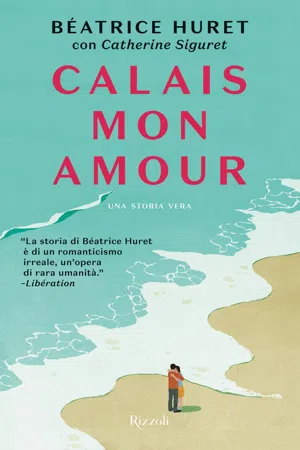![]()
1
Il giorno in cui la vita si capovolge non si annuncia mai come un giorno particolare. La mattina somiglia a tutte le altre mattine, si compiono gli stessi gesti, in automatico e all’ora di sera la vita è cambiata per sempre. In meglio o in peggio.
Quel mercoledì 2 marzo 2016 mi sono svegliata con calma perché ero in ferie, con molto caffè e una bella scorta di sigarette, faccia incollata al computer come al solito. Ogni mattina aprivo Facebook, leggevo articoli a destra e a manca, blog di gente che dava una mano nella Giungla di Calais, che si trovava a trenta chilometri dal mio paesino di campagna, Wierre-Effroy. Mia madre, sempre solerte, si affrettava attorno al tavolo della sala da pranzo portandomi caffè, una fetta di dolce, frutta, crêpes… Insostituibile vecchia cuoca della mensa! A settantasei anni, continua a darsi da fare in cucina come se fossimo in dieci, a tavola, mentre invece siamo solo tre con mio figlio Florian, che ha diciott’anni, perlomeno quando non invito gente, cosa che accade spesso. È una casa dove si vive così bene che nel 2010, quando sono diventata vedova, ci sono tornata, pensando che non esistesse posto migliore, per una ripartenza, dei luoghi della mia infanzia. È nascosta su una delle rare colline della regione, non lontano dal paesino. Finestre e portefinestre dalle intelaiature quadrettate si affacciano sull’ampia campagna e su un boschetto. Al primo piano c’è la mia stanza e quella di Florian, al pianterreno quella di mia madre, contigua a un grande salone che comprende anche la sala da pranzo, collegati a loro volta alla sua amatissima cucina. Scendendo ancora, uno stanzone immenso, al piano seminterrato, dà sul retro della casa e sul giardino, per via di un dislivello. Lo stanzone serve da ripostiglio, se necessario da stanza supplementare, ed è il luogo ideale per serate karaoke o da passare davanti al caminetto. È una casa piena di vita. I miei amici diventano presto anche amici di mia madre, che è una persona discreta e simpatica. Talmente discreta e simpatica che, quella mattina, ha lasciato che mi svegliassi con calma, senza forzarmi a chiacchierare. Si è limitata a chiedermi come sempre: «Novità?».
Ho alzato le spalle.
«La solita merda alla Giungla.»
«A che ora ci vai?»
La domanda non era più se andavo alla Giungla. Ormai era normale che ci andassi tutti i giorni, quand’ero in ferie, e in caso contrario quasi tutte le sere dopo il lavoro.
«Adesso. Vado subito.»
Le ho dato un bacio e sono uscita, con un paio delle borse di vestiti che mettevo insieme durante l’anno e che distribuivo a poco a poco.
Erano le undici del mattino quando sono arrivata alla Belgium Kitchen, uno dei punti di distribuzione dei pasti, che era gestito da una onlus belga. Sbucciavo, tagliavo, lavavo, riordinavo: per due o tre ore, a volte di più, secondo i bisogni. Avevo le mie abitudini, proprio come Ingrid, un’altra volontaria. Arrivando, le ho visto in faccia un’espressione preoccupata.
«Vieni, andiamo dagli iraniani» mi ha detto con voce seria, «ieri si sono cuciti la bocca…»
«Cuciti… la bocca? Ma che cosa dici?»
Ho sbarrato gli occhi e l’ho fissata.
«Sì, si sono cuciti la bocca! In segno di protesta per come vivono da quando hanno smantellato la zona sud, con le persone tutte ammassate, e per la violenza dello sgombero, e per tutto…»
Non avevo mai sentito in vita mia una cosa del genere. Non credevo fosse possibile fare una cosa del genere. Ancora prima di vederli, mi veniva da piangere.
L’ho visto non appena sono entrata: Mokhtar.
Di migranti, in due anni di volontariato alla Giungla, ne avevo incrociati migliaia. C’erano quelli belli, quelli gentili, quelli che ti parlavano, che cercavano di rimorchiarti, che tentavano il colpo di fortuna: «Buongiorno! Mi porti da te?». Ma non ero certo interessata, all’amore in generale e tantomeno con un migrante della Giungla. Mi sembrava non fosse né il luogo né il momento. E ormai ero diventata brava a sfoderare la risposta che li zittiva: «Mi dispiace, sono sposata, non credo che mio marito sarebbe d’accordo». Rispettavano molto la famiglia, l’istituzione del matrimonio, e non insistevano mai troppo.
Mokhtar però non mi ha parlato. E non senza motivo: faceva parte di quelli nuovi, delle Bocche Cucite, come li avrebbero chiamati in seguito. Sono semplicemente «caduta» nel suo sguardo. I nostri occhi si sono sfiorati e io ho visto come un lampo, ho proprio avuto l’impressione della luce di un fulmine, è stata una sensazione fisica, concreta. Non perché Mokhtar fosse bello – anche se sì, lui è bellissimo! Chi se ne frega della bellezza. Non è questo che mi ha scombussolata in pancia. Sono stata catturata dal suo sguardo, come da una calamita, dalla dolcezza dei suoi occhi. Emozione che è stata subito eclissata dalle circostanze, da quegli iraniani riuniti al cosiddetto Punto Informazioni, dove io non avevo mai messo piede prima. Lì di solito si spiegava ai nuovi arrivati come funzionava la Giungla: dove potevano mangiare e dove dormire, a chi potevano rivolgersi per sapere quali fossero i loro diritti. Era un luogo strategico per attirare l’attenzione tanto delle onlus quanto dei media. Gli iraniani, a prima vista tra i venti e i quarant’anni, erano seduti tutti in fila, vicini. La bocca cucita, dunque. Non si riusciva a guardarli. Ho stretto loro le mani, uno dopo l’altro, come si fa con i parenti del defunto per condividere il dolore il giorno del funerale. All’estremità della fila, del resto, c’era Joannes, il prete della Giungla. Molto gentile da parte sua, visto che, nella mia mente, tutti gli iraniani erano anche musulmani.
Ero talmente sconvolta che mi sono accasciata su una sedia davanti a loro, come uno zombie. Guardavo a terra per non vederli, e per non incrociare di nuovo lo sguardo incredibile di quell’uomo del quale ignoravo ancora il nome. Ma il caso ha voluto che fosse lui ad alzarsi per andare a prepararmi un tè. Quando mi ha allungato la tazza, ho sussurrato: «Thank you». Malgrado il filo che gli bucava le labbra, lui mi ha detto qualche parola in inglese, che non ho capito, perché infatti lo parlo poco. Poi è tornato a sedersi, con quella dolcezza che lo caratterizza, con il suo passo felpato. Mi sono scaldata le mani al calore della mia tazza di tè, scacciando dalla mente quell’attimo di défaillance, che non era da me, gli occhi incollati a terra, in modo da ritornare, per così dire, a me stessa, cioè a loro. A quella desolazione. Ho cominciato a piangere. Tenevo il viso basso perché non mi vedessero. Come avevano fatto ad arrivare a tanto?
Non si può dire che quello fosse un gesto tipico del loro Paese; ma gli iraniani avevano nondimeno replicato il modo di protestare dei detenuti politici, di un popolo perseguitato, minacciato, che viveva in una nazione governata dagli ayatollah. Quello era un modo spettacolare e mediatico di gridare: «Non abbiamo il diritto di aprire la bocca? Agli ordini!». E al tempo stesso era anche un modo per «subire» uno sciopero della fame, perché infatti potevano soltanto bere attraverso una cannuccia. Alcuni rifugiati iraniani l’avevano già fatto in Grecia per protestare contro le pessime condizioni di vita di un campo profughi. Un altro iraniano si era offerto di eseguire su di loro quell’operazione dolorosissima.
Volevo andarmene da lì. Andarmene via dal campo. Uscire a prendere un po’ d’aria, da sola, camminare, e finalmente piangere. Di fronte a me, Ingrid si era seduta vicino a uno degli iraniani, di nome Dara. Gli dava dei colpetti affettuosi sulle mani. Sono uscita fuori a camminare, dopo aver aspettato abbastanza per non dare l’impressione di voler scappare come un coniglio. Mokhtar mi ha poi raccontato, in inglese, cosa era successo. Nell’attimo esatto in cui varcavo la porta, lui aveva pensato: Shit! Who is that girl?
E con aria innocente aveva domandato a Ingrid: «Chi è quella ragazza? Non l’abbiamo mai vista…».
Ingrid aveva risposto evasiva: «No? Ah già, è vero… Dà una mano alla Belgium Kitchen».
«Ah… ma non la vedremo mai?»
E lei gli aveva risposto questa cosa straordinaria – non riuscivo a credere alle mie orecchie, quando Mokhtar me l’ha ripetuta: «Oh be’, sai, il marito, i bambini… non ha molto tempo libero».
Il marito e i bambini! Ingrid sapeva benissimo che mio marito era morto, che non c’era nessuno nella mia vita e che mio figlio era un ragazzo, ormai.
Ho dovuto camminare per mezz’ora attraverso la Giungla prima di tornare in me. Sono andata a preparare i pasti alla Belgium, come sempre, ma ero completamente stranita. Non si faceva che parlare degli iraniani. Il loro gesto aveva lasciato allibiti tutti, migranti e volontari. Ero abbattuta, ma anche arrabbiata: sarebbe bastato, quell’atto, a sensibilizzare i politici, i media, e spingerli ad agire? Dopotutto, forse, gli iraniani avevano fatto la scelta giusta. Ma stentavo a crederlo. Gli iraniani, i migranti, la Giungla: ormai ci avevamo quasi fatto il callo, e tutti se ne fregavano, dal momento che se ne stavano nel loro cantuccio a crepare, belli tranquilli, da soli…
Andando via, a metà pomeriggio, ho guardato il ponticello sul sentiero delle Dune che costeggiava la Giungla, e ho pensato: Bisognerebbe che un bravo cittadino francese facesse un gesto spettacolare! Potrei mettermi una corda al collo su quel ponte, per esempio, e minacciare di ammazzarmi, se non prenderanno misure adeguate per far sì che il campo diventi un luogo dignitoso. Potrei parlare con i giornalisti, dal mio ponte. Urlare!
Guidavo verso casa completamente ossessionata da questi pensieri. Mi ripetevo: Calmati. Cosa puoi fare per aiutarli? Sii pratica. Continuavo a rimuginare: Vediamo… Cosa potrebbero mandar giù per sostentarsi? Serviva una cannuccia più larga che si infilasse tra le cuciture, così almeno avrebbero potuto mangiare una minestra, una vellutata di verdure, e bere del succo d’arancia, che era ricco di zuccheri… Perciò sulla via del ritorno ho fatto un salto al supermercato, riempito di cibarie una grossa busta, e una volta a casa mi sono precipitata da mia madre, alla quale non ho lasciato il tempo di dire una parola.
«Mamma, gli iraniani si sono cuciti la bocca!»
«Cuciti la bocca? Non è possibile» ha detto lei. «Non è possibile…»
Mio figlio ci ha sentite parlare e ha esclamato: «Non è vero, cazzo, ma è pazzesco!».
Ho raccontato a tutti e due la mia idea del ponte. Mia madre ha sgranato gli occhi neri.
«Non dire sciocchezze, non servirebbe a niente.»
Mio figlio l’ha spalleggiata. Ha piantato entrambe le mani aperte sul piano del tavolo e sentenziato: «Ha ragione lei. E se poi ti senti male? Se cadi? E se scivoli e muori? Bella figura di merda che ci facciamo».
Florian aveva ragione. Aveva già perso suo padre, non potevo essere così irresponsabile. Eppure ero ossessionata a tal punto da quell’idea che sono andata avanti a parlarne per tutta la sera, e per giorni; non appena un amico passava a trovarmi, era quella la sola cosa che dicevo. La replica che ricevevo era sempre la stessa, categorica: «Béa, piantala con questa storia. C’è un limite a tutto! E comunque non servirebbe a niente». Ho lasciato perdere, ma non facevo che pensare a loro, agli iraniani. Sì, ho detto loro. Perché quel colpo di fulmine l’avevo scacciato dalla testa, facendomi da me uno dei miei soliti discorsetti sensati e logici: Datti una regolata. Questo tizio è un migrante. Ha la sua vita, andrà in Inghilterra. Tu hai la tua. E fra l’altro, il tizio è molto più giovane di te! Lui aveva trentacinque anni, io quarantaquattro.
Ogni sera, dopo il lavoro, passavo al Punto Informazioni per assistere gli iraniani. Portavo cibo, ma loro ne prendevano sempre meno. L’appetito diminuiva. C’erano dei dottori di Médecins du Monde che passavano ogni giorno a controllare come stavano. L’unica preoccupazione dei volontari e delle istituzioni era che il loro gesto non venisse emulato: non volevano degenerazioni, ovvero non volevano ritrovarsi con un’epidemia di bocche cucite. La situazione, a quel punto, sarebbe diventata ingestibile. Io con loro scambiavo soltanto qualche: «Hello», e semmai un: «Good luck». Il mio inglese era davvero pessimo.
Ho capito però che erano tutti ben integrati nel loro Paese, e nonostante questo erano fuggiti perché avevano idee contrarie a quelle di chi stava al potere, o non accettavano che l’Islam fosse la religione di Stato. Nel loro Paese rischiavano di essere perseguitati, il che significava la possibilità concreta di morire. Non conoscevo le singole motivazioni che li avevano spinti ad andare via, e nemmeno i loro nomi e cosa facevano di lavoro. Più tardi ho saputo che Hossein lavorava in un autolavaggio, Ismael faceva il muratore, Réza l’insegnante di body-building, che Omide gestiva un narghilè bar, che Mahmoud faceva il gioielliere, Dara il tatuatore – aveva un’enorme corona tatuata sul collo, simbolo dello scià di Persia – e che Sassan – lui aveva solo diciassette anni – studiava ancora. Proprio Sassan era sempre più pallido. Esausto. Li lasciavano vivere e dormire al Punto Informazioni, al riparo e al caldo. C’era gente che andava e veniva tutto il giorno per stare con loro: il prete, i volontari, ma anche molti attivisti inglesi dei movimenti per i diritti civili. Qualche avvocato tentava di convincerli a interrompere lo sciopero. Ricordo in particolare un volontario, Simon. Era inglese, longilineo, con i capelli corti mossi e rossi, e un look molto british alla Hugh Grant, per capirci, perlomeno quand’era fuori dalla Giungla. Il suo compito era quello di rollare le sigarette per le Bocche Cucite. Gli iraniani, ovviamente, non riuscivano più a leccare le cartine, e poi bisognava rollarle sottilissime perché potessero infilarsi tra i punti di sutura.
Sempre da lì passavano i giornalisti, inglesi o francesi. La maggior parte degli iraniani si faceva vedere ma a volto coperto, per non allarmare la famiglia rimasta in patria o per paura di rappresaglie. L’Iran chiedeva di riavere indietro i suoi fuoriusciti, con tanto di nome e cognome specificati. E loro erano terrorizzati dall’idea dell’estradizione: sapevano perfettamente a cosa sarebbero andati incontro, nel caso. Mokhtar, essendo l’unico che accettava di parlare a viso scoperto, era il più esposto, ma del resto era anche il solo a parlare bene inglese. I giornalisti lo cercavano, e lui era diventato una specie di portavoce. Le Bocche Cucite hanno occupato le prime pagine dei giornali per tre giorni, poi più nulla. Ormai non facevano più notizia, e potevano pure crepare. Io, nel giro di tre settimane, mi ci sono ammalata.
L’insegnante di body-building, che nella Giungla aveva già perso parecchi muscoli, era emaciato. Tutti erano molto dimagriti e cominciavano ad avere lo sguardo spento e a muoversi lentamente. Sassan, il più giovane fra loro, era bianco come un cencio, al limite delle forze. Si addormentava non appena toccava la sedia. Mi faceva paura. E io in passato ho fatto l’aiuto infermiera, quindi so di cosa parlo. Dopo la mia visita quotidiana al Punto Informazioni, andavo a dare una mano alla Belgium per preparare i pasti da distribuire la sera. Ma ormai non vivevo più. C’è voluto quasi un mese di sciopero della fame perché il governo si impegnasse ufficialmente a riprogettare la parte nord della Giungla, sovrappopolata dopo lo smantellamento della zona sud. La gente, infatti, non se n’era certo andata: semplicemente, si erano ammucchiati tutti da un’altra parte! I politici facevano promesse: avrebbero facilitato l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici, dicevano, migliorato l’assistenza ai minori, più vulnerabili che mai per via della promiscuità, e pavimentato un sentiero per permettere l’accesso delle ambulanze. Le Bocche Cucite l’hanno considerato un segno di buona volontà, e il 25 marzo, quando sono arrivata davanti al Legal Center (il centro che si occupava di fornire l’assistenza legale), Ingrid mi è venuta incontro, il viso rischiarato da un sorriso.
«Gli iraniani si sono fatti scucire la bocca!» ha esclamato.
Ho provato un sollievo immenso. Non ci dormivo più, ormai. Era stato Mokhtar a occuparsi dell’operazione, aiutato da un volontario di Medici senza frontiere. A lui sarebbe rimasto un piccolo segno indelebile sopra il labbro superiore.
Ero pronta a entrare nella tenda per dire a tutti quant’ero contenta, ma I...