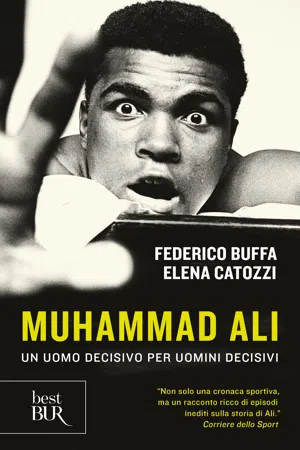![]() Parte seconda
Parte seconda![]()
4
Una persona onesta in uno sport malfamato
| | «L’allenamento con Ali era unico. Non c’era bisogno di incitarlo, era come un jet a propulsione: bastava un cenno perché decollasse.» |
| | ANGELO DUNDEE |
Il mondo dello sport è pieno di sodalizi, di successi legati a binomi inscindibili, quelli in cui medaglie e titoli sembrano naturalmente divisi in parti uguali tra chi va sul campo a guadagnarli e chi quel campo lo occupa apparentemente a latere e in borghese, ma combattendo simultaneamente a fianco del campione, senza neanche bisogno di incitarlo perché con il campione vero non è necessario.
Il modo con cui Cassius Clay e Angelo Dundee si sono scelti affonda le radici in un destino che potrebbe spiegarsi solo nel mondo dei miti greci, come se le loro vite epiche lo fossero davvero, e nei miti nulla è casuale, ma tutto è inevitabile. Proprio come lo fu il loro primo incontro nel 1957, in quella camera d’albergo di Louisville, dove il già esperto manager si trovava col suo pugile Willie Pastrano.
Ma, perché le strade di Angelo e Cassius potessero finalmente incontrarsi per la vita, quest’ultimo, ormai avviato al professionismo, sarebbe dovuto passare prima per le mani e la palestra di Archie Moore. Così aveva stabilito il Louisville Sponsoring Group, i businessman del Kentucky che lo amministravano. Soprattutto dopo aver visto Cassius vincere, ma non convincere, nel suo primo match da professionista nell’ottobre 1960 alla Freedom Hall, nel centro dell’Università di Louisville.
Archie Moore era un pugile ultraquarantenne in piena attività nella categoria dei mediomassimi, nato a Benoit, Mississippi, non si sa bene quando, probabilmente quando non c’era ancora il sonoro al cinema, che aveva aperto un eremo da qualche parte in California dove allevare giovani pugili. L’ideale per Clay.
Salt Mine era una vecchia fattoria poco lontana da San Diego, in cui Moore aveva ricavato una palestra chiamata Blood Bucket, Secchio di Sangue, con un teschio inchiodato sul varco d’ingresso e grandi macigni disseminati all’esterno su cui spiccavano i nomi dei grandi campioni del pugilato.
Quando arriva, Cassius si accorge che la località è idilliaca e soprattutto che le figlie di Moore sono già innamorate di lui. Bene fuori dal ring, non così tanto bene sul ring. Sono due personalità troppo forti, non possono stare a lungo assieme soprattutto perché Moore vuole far diventare Clay un pugile che quest’ultimo non pensa di dover diventare, e i suggerimenti del maestro circa tecniche e colpi per giungere presto al K.O. vengono respinti al mittente con ribellione da un ragazzo che non vuole certo essere l’ennesimo Archie Moore, bensì la nuova stella dei massimi.
Inoltre alla fattoria non c’è personale di servizio e i pugili sono tenuti a collaborare alle pulizie, cosa non esattamente congeniale al giovane Cassius, destinato a lasciare presto Salt Mine con buona pace di Moore, che per quanto ci abbia provato, non è riuscito a “imbrigliarlo” come avrebbe voluto.
«Amo Ali, perché è stato la gallina dalle uova d’oro. Quelli come me hanno dovuto farsi strada ciascuno per conto proprio, poi è arrivato lui e ha sfondato la porta» dirà molti anni dopo ricordando ad Hauser i tempi di Salt Mine.
Quando nel dicembre ’60 William Faversham, mente dello Sponsoring Group, contattò Angelo Dundee per proporgli di allenare il loro pugile, «quanto è certo che Dio creò le mele, il giorno dopo mi ritrovai Cassius insieme a suo fratello davanti a casa mia, a Miami». Si stava per avverare ciò che era stato scritto in quella camera d’albergo nel 1957, e Cassius scalpitava per ricongiungersi con l’unico altro uomo che aveva già in mente, proprio come lui, la roadmap fino al titolo mondiale.
Ora: perché una persona che di cognome fa Dundee, nata a Philadelphia, Pennsylvania, nei suoi ricordi distilla pura saggezza meridionale italiana? Perché Angelo si chiama Angelo, ma di cognome in realtà non fa Dundee.
Quando a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento dall’Europa arrivarono negli Stati Uniti milioni di italiani, irlandesi ed europei dell’Est, si dovettero giocoforza accomodare sull’ultimo piolo della scala sociale. Ma gli irlandesi avevano un grandissimo vantaggio: la lingua. Già la parlavano, e i loro cognomi erano anglosassoni. Per gli altri invece era un problema. I polacchi, che avevano una vocale ogni mezz’ora, vedevano i cognomi completamente squartati. Gli italiani pure, per non parlare poi di quelli che venivano dai ghetti ebraici dell’Est Europa, che già li volevano cambiare di per sé.
Un giorno da un paese che si chiamava, e si chiama, Roggiano Gravina, provincia di Cosenza, sbarcarono i Merenda. Per molti aspiranti cittadini americani il primo approdo era Ellis Island, isola artificiale costruita poco lontano da Manhattan con le rovine degli scavi della metropolitana di New York.
Dopo aver superato la quarantena, i Merenda diventarono Mirena e successivamente si stanziarono a Philadelphia. Ebbero dei figli maschi, il primo si chiamava Chris e il secondo Angelo. Chris voleva boxare, ma non si sentiva di farlo con il cognome di famiglia, desiderava un riconoscimento sociale più forte e quindi optò per Dundee, ispirandosi a Salvatore Lazzara, un palermitano che già si faceva chiamare Joe Dundee, un buon pugile degli anni Venti. E il fratello minore? Poteva a quel punto rimanere Angelo Mirena? No! Lui pure diventò Dundee, Angelo Dundee.
Nel 1950 i fratelli si stabilirono tra la Quinta strada e Washington Avenue, a Miami, e aprirono la palestra che diventerà celebre nel mondo, quella 5th Street Gym in cui si forgeranno diversi campioni del mondo, e uno in particolare.
Angelo Dundee sapeva bene che quando lavori con un pugile «devi essere un chirurgo, un ingegnere e uno psicologo», eccellendo in ognuno di questi mestieri ed enfatizzando con Cassius le sue doti all’ennesima potenza. «L’allenamento con lui era unico, una storia a sé rispetto a buona parte degli altri pugili» raccontò a Thomas Hauser. «Non c’era bisogno di incitarlo, era come un jet a propulsione: bastava un cenno perché decollasse.»
E decollarono insieme praticamente per vent’anni, planando a volte su montagne impervie, altre sorvolando pianure verdeggianti, ritrovandosi in mezzo a tempeste e sfiorando spesso il suolo, ma riprendendo quota con ogni mezzo possibile, anche quando le ali del pugile sembravano immobili e il suo volo troppo incerto: un solo sguardo di quell’uomo sopraffino in camicia bianca e dalle montature vistose regalava a Cassius il paracadute che lo avrebbe protetto da qualsiasi schianto.
La memoria dell’illuminato manager venuto da Roggiano Gravina sarà per sempre legata a espressioni come «boxe allo stato puro», come lo appellò il collega medico Ferdie Pacheco, oppure «il cornerman che accompagnò al titolo mondiale i più grandi pugili della storia», ma soprattutto a ciò che ne disse il giornalista sportivo Dick Schaap: «Una persona onesta in uno sport malfamato», «Il quartiere a luci rosse dello sport», come lo definì Jimmy Cannon, il più grande reporter della boxe a stelle e strisce, titolare sul «New York Post» della celebre rubrica Nobody asked me, but, il cui titolo tempo dopo sarà ripreso anche da Dan Peterson per i suoi interventi sulla «Gazzetta dello Sport».
Non doveva essere facile rimanere un uomo onesto in quell’ambiente e in quei tempi. E forse solo in quell’America che accoglieva milioni di persone dando loro nuove possibilità poteva succedere che un giovane ribelle afroamericano affidasse praticamente tutto se stesso a un emigrato bianco di origini calabresi, tra paure, intemperanze, difficoltà, e soprattutto speranze.
Solo un uomo come Angelo, cresciuto molto più a suo agio tra gli afroamericani che in mezzo a coloro che avevano sì aperto le porte alla sua famiglia ma sempre sotto un velo di diffidenza, solo un uomo che aveva conosciuto bene quella sensazione di essere considerato “diverso”, straniero, avrebbe potuto gestire e indirizzare la strabordante intelligenza di quel pugile.
Angelo Dundee rimase al fianco di Ali in tutti i suoi match tranne due: il primo contro Hunsaker e incredibilmente nel 1971 contro Jimmy Ellis, perché essendo stato manager e allenatore anche di Ellis, quella sera, di comune accordo con Ali, era all’angolo opposto. Rimase al fianco di Ali fino all’ultimo incontro e la fine di quella carriera sembrava non dovesse arrivare mai, nemmeno con lo straziante match di Manila contro Joe Frazier, dopo il quale Ali continuò a combattere pur avendo lasciato la sua anima più profonda in quell’arena nelle Filippine. Il capolinea fu Nassau, Bahamas, quell’11 dicembre 1981, in cui perderà contro un certo Trevor Berbick, un giovane pugile cresciuto nel suo mito che alla fine del match non farà altro che ringraziarlo.
«Quel maledetto pazzaglione (soprannome che usava per la stampa italiana), con tutto il bene che gli volevo, bastava che incontrasse qualcuno che gli diceva che c’era un altro match, che c’era una buona borsa, che magari era anche in un bel posto, e lui ci andava» raccontò Dundee in un’intervista rilasciata a Gianni Minà.
Il primo giorno di febbraio del 2012, a novantuno anni, il “Paisà” che per la sua storia poteva essere uscito da un film di Roberto Rossellini, e che aveva condotto per mano al titolo mondiale ben quindici fuoriclasse in varie categorie, tra cui Sugar Ray Leonard, Willie Pastrano, José Nápoles, George Foreman, lasciò per sempre l’angolo occupato per più di mezzo secolo, dopo aver dimostrato al mondo come quella angusta parte di piano all’incrocio delle corde possa essere lo spazio dell’attesa e della crescita, quello in cui ci si siede da vinti per rialzarsi, forse, da campioni.
E Angelo, di quella prodigiosa convessità, custodiva ogni segreto.
Prima di andarsene era riuscito a partecipare alla festa per i settant’anni del suo adorato allievo Ali, di cui aveva abbracciato le battaglie senza interferire mai.
Gli era stato vicino durante la conversione all’Islam, la renitenza alla leva e le tante altre turbolenze come solo un vero amico sa fare. Anche se la caducità della vita li aveva fatti scendere dal ring e salire su una carrozzina, i miti restano al loro posto per sempre e quel pugile che accolse nella sua palestra di Miami, ancora gli telefona al mattino presto per dirgli che vuole tornare ad allenarsi con lui.
Sappiamo che lo stanno facendo, e lo faranno per sempre, ovunque ci siano delle corde e dei guantoni, per vincere il quarto titolo mondiale.
![]()
5
Il team della 5th Street Gym
| | «Vola come una farfalla, pungi come un’ape.» |
| | DREW “BUNDINI” BROWN |
Se è vero che certe storie non possono prescindere dai luoghi in cui si sviluppano, è altrettanto vero che in rari casi essi ne diventano protagonisti al pari dei campioni e degli uomini straordinari che li hanno popolati.
Quello della 5th Street Gym di South Beach, Miami, è uno di questi.
L’intero gotha della boxe del secondo Novecento è transitato tra le sue mura, eppure non vi è una singola persona che sia passata per quei locali – campioni, spettatori, sparring partner, manager, medici o semplicemente curiosi – che non abbia contribuito a farne la storia. Dal primo giorno fino a quello in cui il giovane Cassius vi entrò quasi felpatamente, un po’ riscrivendola, un po’ rimanendone investito, perché in fondo quel luogo era davvero sotto un incantesimo.
In quello spazio sono state possibili intese tra uomini di comunità diverse e apparentemente in odore di conflitto, alleanze oltre il quadrato del ring, l’avverarsi di solidarietà e amicizie che forse, in altre città, fuori da quelle mura non sarebbero state altrettanto facili.
Fin dagli anni Cinquanta la popolazione di Miami era costituita in larga parte da immigrati cubani, tendenzialmente bene inseriti in un tessuto sociale reso elastico dal loro flusso continuo, e la commistione tra le varie comunità diede luogo a un melting pot in cui le identità convivevano senza dover negoziare la propria appartenenza, evitando di impattare le une sulle altre, a volte amalgamandosi, altre semplicemente sopportandosi. Del resto per Cuba la Florida rappresentava il varco d’accesso agli Stati Uniti d’America, e quella miscela esplosiva di umanità sembrava coesistere apposta per sfornare talenti. Almeno nella boxe.
La palestra dei fratelli Dundee originariamente si trovava tra la Quinta strada e Washington Avenue, ed era al secondo piano. Sotto c’era una drogheria e, per raggiungere la palestra, bisognava passare da lì e salire una scala. Sulla soglia c’era un pensionato senza denti che esigeva 50 centesimi da tutti quelli che si presentavano all’ingresso per assistere agli allenamenti. Un coro, una giuria. Avevano anche un soprannome: “The Cardinals”. Il loro verbo, quasi sempre, era Vangelo. Per metà erano cubani, i più critici di tutti. Anche con Cassius: «Nah! Questo ragazzo non va bene, Angelo! Saltella, vuol sempre colpire alla testa… ma cosa fa, balla? Nooo, no es cubano».
Già, non è cubano, viene da Louisville.
Anche Angelo Dundee inizialmente vorrebbe correggerlo, solo che ha già intuito, da uomo di rarissima intelligenza qual è, che il ragazzo sa già molto bene cosa vuole diventare.
Angelo, nella sua incantevole ingenuità, sistema Cassius al Mary Elizabeth Hotel, in una zona, diciamo così, non residenziale di Miami. I clienti dell’albergo che non abbiano trascorso almeno una sera al fresco nella loro vita non si possono contare perché non ci sono: sfruttatori, biscazzieri, prostitute, trafficanti di vario materiale, tutti hanno qualcosa che non va. E, vedendosi arrivare un novellino, facilmente avranno pensato: “Ah, ecco la nostra prossima vittima”. Ma nel giro di dieci giorni a Cassius succede quello che sempre accadrà nella sua vita: tutti quelli che entrano in contatto con lui finiscono per proteggerlo.
«Hey, ma hai visto quel negrettino lì? Io ho una portoricana giusta!»
«No! Nessuna portoricana per il nostro ragazzo, si sta allenando.»
«Ho una pastiglietta di quelle…»
«Nooo! Si sta allenando.»
E di proteggerlo c’era davvero bisogno. Tutte le mattine Cassius doveva raggiungere Miami Beach partendo da downtown ed era un bel viaggio, doveva farsi di corsa tutto il MacArthur Causeway, un ponte che sembra interminabile. In una città segregata come Miami, non poteva passare inosservato. Troppo bello. Soprattutto troppo nero. Un giorno, proprio all’altezza della drogheria, si ferma una macchina della polizia. Niente sirene, gli agenti vogliono solo fare due chiacchiere.
«Angelo! Quel negro smilzo che tutti i giorni si fa avanti e indietro sulla Causeway è tuo?»
«Sì, ragazzi, quello è mio, è a posto.»
«Angelo, you kn...