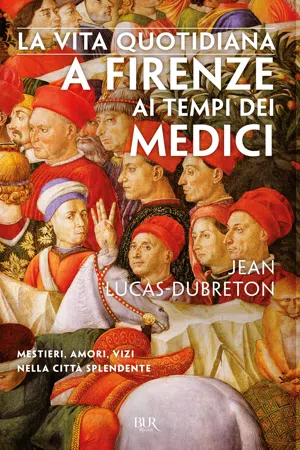![]()
XVIII
La vita nella città assediata e asservita
Con la morte (4 maggio 1518) del giovane Lorenzo duca di Urbino, padre di colei che diventerà Caterina de’ Medici, si è estinta la linea diretta e legittima dello scaltro Cosimo il Vecchio, e Leone X può dichiarare di non appartenere più alla casa dei Medici, ma alla casa di Dio.
Tuttavia nel dicembre del 1521, lo stesso Leone X muore, a quarantasette anni, forse avvelenato, e la rinascita del movimento repubblicano a Firenze sembra possibile.
Ma il cardinale Giulio vigila; ha già fatto giustiziare due giovani cospiratori che frequentavano i giardini Oricellari, e quando, nel novembre del 1523, viene eletto papa, il suo primo interesse è di assicurarsi l’obbedienza della sua patria.
Vi manda Passerini, il cardinale di Cortona, prelato autoritario, cupido e di un servilismo a tutta prova, che ha l’incarico di sorvegliare i due bastardi della famiglia Medici: il giovane cardinale Ippolito, bastardo di Giuliano (fratello di Leone X), e Alessandro, bastardo del papa stesso, che l’avrebbe avuto da una schiava mora: Alessandro effettivamente ha l’aspetto di un uomo di colore con i capelli crespi.1
Per dare un’idea del regime a cui erano sottoposti i fiorentini in questo periodo, ecco un esempio tipico: durante il conclave per l’elezione del papa, c’era l’abitudine di fare scommesse sul cardinale che sarebbe stato scelto; un certo Piero Orlandini ha scommesso contro il cardinale Giulio, e dopo il successo di quest’ultimo, invitato a pagare cento scudi, risponde che prima vuol vedere se l’elezione sarà considerata valida, data la nascita illegittima di Giulio. Lo scommettitore vincente denunzia subito Orlandini ai magistrati, che senza alcuna forma di processo lo fanno giustiziare in quella stessa sera. Non bisogna lasciare la via aperta a discorsi di questo genere.
La competizione tra Francesco I e l’imperatore Carlo V è allora al culmine, e sull’Italia le nubi si vanno addensando. Dopo molto tergiversare Clemente VII trascina nella lega santa contro l’imperatore i fiorentini, che sono duramente tassati: 26.000 fiorini d’oro al mese. E con quale risultato! I francesi sono vinti e cacciati dalla Lombardia; l’armata imperiale, un’accozzaglia di tedeschi e di spagnoli affamati al comando del conestabile Carlo di Borbone, cala a precipizio sulla Toscana nell’aprile 1527. Firenze, minacciata e divisa tra il timore delle truppe imperiali e di quelle della lega, che devastano il paese in sincronia, prepara la propria difesa. Scrive il Machiavelli all’amico Vettori:
Pertanto si è qua deliberato, se domani egli [il conestabile] muove, di pensare alla guerra affatto, senza haveie un pelo che pensi più alla pace [...] Con questa tramontana conviene che voi ancora navichiate, et resolvendosi alla guerra, tagliare tutte le pratiche della pace, et in modo che i collegati venghino innanzi senza rispetto alcuno, perché qui non bisogna più claudicare, ma farla alla impazzata: et spesso la disperazione truova de’ rimedii che la electione non ha saputi trovare.2
Ma questo slancio veramente tragico rimane senza eco; un tafferuglio diretto contro i Medici, è vero, scoppia davanti al Palazzo della Signoria, durante il quale un braccio del David di Michelangelo viene spezzato, ma l’ordine è ristabilito presto, e Firenze deve impegnarsi a pagare 250.000 ducati per allontanare le truppe imperiali, cupide di saccheggiarla.
Giorni di calamità: peste, carestia, disoccupazione; i cittadini, grandi e piccoli «eransi adunque universalmente [...] risentiti e alterati, ma più nondimeno si commosse e fece viva quella parte, la quale aveva sempre il vivere più libero, ed il governo della città alquanto più largo desiderato».3 Nella città si vedono più cappe che mantelli, più soldati che cittadini; si passa senza osare di alzare gli occhi, per vergogna o per timore; si diffida degli altri e di se stessi; le botteghe chiudono presto, e la gente si confina in casa propria.
All’improvviso, il 12 maggio 1527, a Firenze giunge una notizia sconvolgente: quella del sacco di Roma, avvenuto sei giorni prima per opera delle truppe imperiali. Il santuario della cristianità profanato, le sue ricchezze depredate, il papa Clemente VII prigioniero! Il sacco di Prato sembrava impallidire al confronto. E i partigiani della libertà risollevano la testa. Il cardinale Silvio Passerini, legato del papa a Firenze, pensava che la grandezza dello stato consistesse nel farsi obbedire ma «aveva né ingegno da poter conoscere i cervelli fiorentini, né giudicio da saperli contentare, quando bene conosciuti gli avesse».4 Servile creatura del papa, spogliava la gente con disinvoltura, e «quel contadino di Cortona» era odiato.
Buona occasione per cambiare governo: la rivolta scoppia. Il cardinale Passerini, tremante di paura, è cacciato insieme con i due bastardi Medici, Alessandro e Ippolito, e quando essi passano per la via Larga, molti cittadini dicono che un giorno ci si pentirà di esserseli lasciati scappare.
Così questa interessante famiglia di banchieri, già espulsa nel 1443 e nel 1494, conosce l’esilio per la terza volta; i suoi stemmi, le sue armi sono demoliti a martellate, e le ordinanze repubblicane vengono rimesse in piedi; i fiorentini acclamano di nuovo la libertà, l’anima del Savonarola sembra rivivere.
La prima domenica di giugno del 1527 si svolge una solenne processione, dietro il quadro dell’Annunciazione attribuito a Giotto; partita dal Duomo, è salutata davanti al palazzo dai membri della Signoria vestiti di nero, poi attraversa il Mercato Vecchio e termina con una messa solenne. In tutta fretta, lavorando giorno e notte, si restaura la sala del Consiglio Maggiore, quale era prima del ritorno dei Medici, e il 21 giugno più di duemila cittadini vi si ammassano; la costituzione abbattuta dai tiranni è ristabilita, e il savonaroliano Niccolò Capponi è eletto gonfaloniere.
I fiorentini, avendo riconquistato la repubblica, fanno professione di ascetismo, e si ritorna al regime severo del Giudice che aveva consacrato la loro città al Cristo: si chiudono le taverne, s’impongono regole al vestiario femminile e alle attività delle cortigiane, si rinnovano i provvedimenti contro gli ebrei, i dissoluti, gli invertiti, i bestemmiatori, e come dimostrazione pubblica si distruggono, all’Annunziata, le statue di cera raffiguranti Leone X e Clemente VII: «la qual cosa fu molto, e per mio giudizio con molta ragione, dagli uomini buoni e prudenti biasimata».5
Tuttavia la peste, comparsa, come sappiamo, nel 1522, compie di nuovo devastazioni. Le persone agiate, applicando il principio: «Parti presto e torna tardi», si rifugiano il più lontano possibile «in diversi luoghi alle lor ville»;6 coloro che restano fanno buona guardia, non comunicano direttamente tra loro, si parlano tenendosi alla larga, e dicendo: «Stiamo chiaretti», vale a dire manteniamo le distanze; escono soltanto la sera tardi, aspirando a ogni passo certe droghe che, dicono essi, risanano il cervello, e alla mattina, prima di lasciare il letto, si frizionano con elettuari.
Disgraziatamente i medici sono stati i primi a fuggire, quindi i fiorentini sono ridotti a stravaganti misture, preparate da ciarlatani. Quasi tutte le botteghe delle arti maggiori – seta, lana, spezie – sono chiuse, o vengono aperte soltanto per metà, con una sbarra di protezione, perché nessuno si possa appoggiare alla porta; il denaro non si prende in mano, ma su vassoi di legno o di ferro; poi non si ripone nella cassa, ma in un recipiente pieno d’acqua. Gli animali domestici, cani e gatti sono stati quasi tutti sacrificati.
Si è provveduto alla nomina di ufficiali sanitari, i quali, volontariamente e per l’amor di Dio, vegliano agli ingressi della città, per impedire l’entrata dei viaggiatori provenienti da Roma; i fiorentini sospetti devono portare sulla spalla o alla cintura, in maniera ben visibile, un pezzo di tessuto bianco; e questo segno è appeso anche alle campanelle delle case colpite. Gli appestati vengono curati in un apposito ospedale, e quando questo è pieno, si costruiscono fuori dalle mura, da Porta Santa Croce alla Porta di Prato, capanne di legno e di paglia, dove più di seicento ammalati sono affidati alle cure della Compagnia della Misericordia.
Secondo un testimone, era cosa miserevole e degna di compassione il vedere questa città così fiorente quasi vuota, e alla mercé della più vile feccia della plebe, che pensava soltanto ad appropriarsi i beni altrui e a darsi al bel tempo, senza rispetto né timore delle leggi. I giustizieri, in maggioranza, mancavano, e i due che erano rimasti non bastavano. L’insicurezza era tale che la gente faceva testamento sulla pubblica via o sul tetto, e la stessa cosa accadeva per le confessioni.7
Per sbarazzarsi dei bambini, i piccoli mendicanti che rubavano nel Mercato Vecchio e altrove, si finì per mantenerli a spese del comune in una residenza della Sala del Papa a Santa Maria Novella, dove essi erano nutriti e dormivano ammucchiati. Nel frattempo i predicatori, nelle chiese, pensavano soltanto a esaltare il nuovo regime e ad attaccare il papa.
Il nervosismo è al colmo. Un parente del gonfaloniere Capponi, uscendo dal consiglio, nota alcuni giovani che montano la guardia: «ringraziato sia Dio, che pur di qui si leverà questa fanciullaia». Lo sente Jacopo Alamanni, che ribatte: «tu sarai prima impiccato che questa guardia di qui si levi».8 A questo punto un altro parente di Capponi, Leonardo, rimprovera a Jacopo di essere troppo suscettibile. Jacopo se n’ha a male e, presso la Giuditta di Donatello, estrae il pugnale e si precipita su Leonardo, che cade. Jacopo, credendo di averlo ucciso, fugge: «basta che Jacopo veggendosi Tommaso e la famiglia degli otto alle costole, cominciò a chiamare il popolo, che l’aiutasse, ma preso da loro [...] gridò: – guardia, guardia!». Nessuna eco. Arrestato, viene condotto nel palazzo, di cui la Signoria fa chiudere le porte. Si vota senza indugio e Jacopo, esclusa una fava bianca, è condannato all’unanimità per aver tentato di sollevare il popolo e chiamato la guardia. Egli muore coraggiosamente, e il suo capo viene mostrato alla folla dalla finestra.
La peste non ha fatto che rendere la situazione più penosa. I dirigenti e per primo il gonfaloniere, il quale non è il più coraggioso degli uomini, vedono anche troppo chiaramente il pericoloso isolamento di Firenze abbandonata dai francesi, e che non può fare affidamento su Venezia, la sua rivale mercantile. Venezia, d’altronde, non crede che i fiorentini siano disposti a una lunga resistenza e pensa che perfino di fronte a un esercito nemico essi non guardino all’interesse generale della loro città, ma all’interesse particolare della loro setta.
Gli eventi dimostreranno esattamente il contrario.
Le sconfitte francesi turbano senza dubbio l’opinione pubblica, ma la risoluzione di difendersi da tutti e contro tutti – contro l’imperatore Carlo V e le sue bande, contro il papa Clemente VII che vuol rimettere le mani sulla città – rimane incrollabile. Si mobilitano tutti i cittadini dai diciotto ai trentasei anni, le milizie care al Machiavelli9 e i vecchi soldati, vedendo passare le nuove ordinanze dietro i loro stendardi, ben vestite, disciplinate, in bell’ordine, «mentreché nel far la mostra facevano la chiocciola e sparavano gli archibusi,10 stranamente si maravigliavano e smisuratamente li lodavano». Nello stesso tempo il flagello della peste, che è stato un bene almeno in questo, di aver sbarazzato la città dai paurosi, va via via scomparendo.
L’ascetismo favorisce il patriottismo: come dice Umberto Dorini, il risveglio delle antiche virtù della stirpe agisce sui giovani aristocratici, sugli intellettuali, e di riflesso sul popolo. I puri, i duri – qualcosa come i giacobini dell’epoca – rimproverano perfino al gonfaloniere Capponi di mancare di energia: promettono ch’egli verrà fatto a pezzi perché si è limitato a cambiare il tappo, ma il vino è rimasto lo stesso: il popolo esige invece che sia il vino a esser cambiato.
Ma Capponi non è uomo da risoluzioni energiche; si barcamena, e un giorno viene scoperta una lettera cifrata, che rivela senza alcun dubbio le sue trattative con il papa; a Venezia gli avrebbero tagliato la testa; cosa stupefacente, i repubblicani fiorentini si accontentano di relegarlo fuori dalla città, e nominano al suo posto un mercante di moralità discutibile – ha fatto bancarotta due volte – ma noto antipapista, Francesco Carducci.
Nel resto d’Italia l’atmosfera è ritornata pacifica, ma per Firenze, esclusa dai trattati firmati da Carlo V con i francesi e con il papa, è la guerra, e si comincia a fortificare la città sotto la direzione del «governatore e procuratore dei lavori» Michelangelo, il quale, abbandonando la cappella dei Medici dove stava scolpendo le tombe dei «tiranni», fa il suo apprendistato d’ingegnere, e ispeziona le fortezze della Toscana. In quel tempo a Firenze si stima il valore delle case e dei conventi che devono essere demoliti.
Quindi questi artigiani che lavorano durante il giorno e per una parte della notte, portano balle di stoffa e tengono i loro libri dei conti con meticolosità, sanno dimostrare grandezza d’animo, all’occasione. L’ordinanza sulla milizia entusiasma la gioventù che, disabituata com’era ai combattimenti, passava il suo tempo ciarlando sui banchi e dicendo male dei passanti; a questo punto, sembra che una benevola Circe abbia trasformato queste bestie in uomini, per la salvezza della patria.
Quello che manca è il denaro: i Medici hanno talmente «medicato» il paese che gli hanno levato la pelle; il sacco di Roma ha rovinato parecchi mercanti, e il bilancio è in deficit di 450.000 ducati. Allora il fisco si dà da fare: prestiti forzati, decime alle quali sono sottoposti sia gli ecclesiastici sia i laici; l’argento trovato nelle chiese e nei conventi viene spedito alla zecca e trasformato in monete che recano da un lato il giglio fiorentino e dall’altro la croce con la corona di spine.
Ormai la milizia, rinforzata dai contadini delle campagne, arriva a tredicimila uomini, settemila dei quali sono nella città stessa, sotto il comando del condottiero Malatesta Baglioni di Perugia. Costui è figlio di un altro condottiero decapitato per ordine di Leone X, Giampaolo Baglioni: si può quindi sperare che, essendo nemico dei Medici, non tradirà.
L’uomo che l’imperatore Carlo V ha incaricato di conquistare Firenze – questa Firenze la cui libertà, in mezzo al servaggio italiano, si presenta come uno scandalo – è un transfuga francese, il principe di Orange, il quale conta sulla pusillanimità degli abitanti, degli aristocratici attaccati ai loro palazzi e alle loro ville. Invece, sono i proprietari stessi che si precipitano a devastare quei loro possedimenti che potrebbero distu...