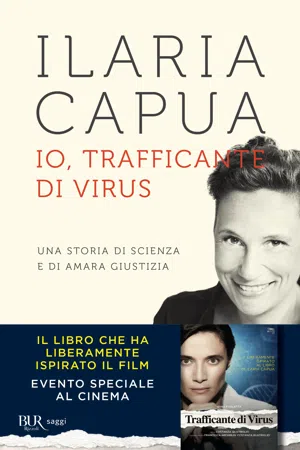![]()
1
«Ladies and gentlemen, we are now about to land in Orlando, Florida.» La voce metallica mi risveglia dalla trance di dieci ore di volo. Fuori, dice il comandante, il cielo è terso con una temperatura di ventotto gradi: tempo splendido, cosa aspettarsi dal Sunshine State? Guardo l’orologio e penso che mancano venti minuti buoni per scendere; che faccio, do un’altra occhiata all’articolo sul virus Zika? In Florida ci sono tante zanzare, quasi come in Veneto. È un problema serio. Sarà una delle prime cose di cui dovrò occuparmi.
Zika è soltanto l’ultima delle virosi emergenti, si è manifestata da circa sei mesi in Brasile con un’impennata di casi di microcefalia nei neonati. Di questo virus si sa poco: che è trasmesso dalle zanzare, che nell’adulto provoca una forma febbrile passeggera e benigna, ma nella donna incinta può portare a danni irreversibili al nascituro. Come se in Brasile avessero bisogno anche di questa emergenza.
No, l’articolo può aspettare. Sono venticinque anni che giro per il mondo come una disperata, e sul treno o sull’aereo ormai sono abituata a fare di tutto. Non oggi: questo è un viaggio un po’ diverso; non sto andando a un convegno o a una conferenza: oggi, 16 giugno 2016, negli Usa 6/16/2016, inizio una nuova vita. E svolte come questa hanno bisogno di un po’ di spazio interiore e di silenzio per sedimentarsi.
Allora chiudo gli occhi e mi rilasso contro lo schienale. Niente da fare, la mente non sta ferma, non si libera. Mai dormito in viaggio, figurarsi oggi, e forse in vita mia avrò visto solo un film durante un volo. Di solito lavoro: siamo io e i paper, io e il computer, la carlinga che mi isola dalle nuvole e dalle distrazioni come una bolla di concentrazione. Perché il tempo è importante: è l’unica risorsa su cui abbiamo pieno potere, e non si deve buttare. Mai. Ah, ecco, la lista delle cose da fare: primo, telefonare a Rich sfruttando l’attesa dei bagagli. Secondo: ritirare l’auto, quindi prendere la Florida’s Turnpike fino all’immissione nella Interstate Highway 75. Direzione Gainesville, la mia nuova città. Dopo Roma, Perugia, Teramo, Padova. E tutte le altre che sono state parte della mia vita: Londra, Edimburgo, Atlanta, Washington, Amsterdam, Parigi. Ma anche Istanbul, Tokyo, il Cairo.
Guardo il mio anello azzurro. Che bello, sembra fatto di acqua.
L’aereo atterra con un sobbalzo e una frenata brusca. Punto in avanti le gambe come al solito, mi fa sempre un po’ paura l’attimo in cui si tocca terra… Mi alzo, i piedi gonfi, mi gira leggermente la testa, tiro giù il trolley dalla cappelliera, e subito arriva fedele la fitta alla spalla. Ah, che male, è sempre una coltellata. «Cosa credi di fare?» mi domanda come una compagna antipatica e onnipresente. «Hai cinquant’anni!» Ha ragione, li ho compiuti meno di due mesi fa. Proprio una bella età per cambiare Paese, lingua, abitudini. Per lasciare gli amici, le persone e le cose che ami. Ma che devo fare? Crescere significa pure questo, mettersi in gioco, essere pronti ogni volta a iniziare da capo: lo ripetevo sempre ai miei collaboratori, no? Del resto, qual è l’alternativa: nascere, vivere e morire sempre nello stesso posto? Non ce la posso fare, ho bisogno di ossigeno.
Sono partita stamattina alle 10 da Venezia; mi ha accompagnato mamma, forte come sempre, non lascia trasparire la sua amarezza. Mamma è così, una roccia, quando ce n’è bisogno. Scalo a Francoforte e poi, mannaggia, l’aereo ha un’ora e più di ritardo, quindi alle 13,40 di nuovo a bordo. Controllo l’orologio: qui in Florida sono le 18,40, ma in Italia è quasi l’una di notte. Quattordici ore di viaggio, di cui dieci di volo ininterrotto, sono faticose. Ma a pesare non sono gli anni, sono i chilometri, diceva il vecchio Indiana Jones. Guardo il trolley, l’altro fedele compagno di vita, il guscio che mi porto appresso. Dentro, i documenti, il lavoro, il portatile e la pashmina fucsia, regalo degli amici di Ancona per i miei cinquanta. L’aria condizionata in aereo è terribile ma io ormai conosco il nemico. Dentro il trolley nero ci sono anche i gioielli: la spilla di nonna Rosaria, il bracciale di nonna Anna. Le perle che mi ha regalato mamma. L’anello di fidanzamento, l’anello azzurro invece ce l’ho al dito.
Mi alzo e mi metto in fila per scendere, saluto veloce hostess e steward; scendo e, con il mio passo deciso, mi incammino nel tunnel che porta direttamente al terminal. Quando entro in quel tubo di congiungimento fra cielo e terra, mi gira sempre la testa, sempre. A Venezia siamo arrivati in pullman sulla pista, qui c’è un’apoteosi di vetro e acciaio, tutto grida modernità, efficienza, soldi, denaro e potere. È l’America, bellezza, land of opportunity.
Me ne vado ripercorrendo la scaletta delle cose da fare quando mi sento chiamare. «Ehm, excuse me…» Fermo la mia marcia e mi giro, il mio sguardo interrogativo si incrocia con quello, imbarazzato, del copilota. Porca miseria, la gatta! La gabbietta che alza con la mano è la risposta a tutte le mie domande. «Ops» sibilo imbarazzata mentre risalgo la corrente dei passeggeri in uscita. Mi guardano severi, manco avessi lasciato sull’aereo un neonato urlante. Che figura. Mi faccio sempre riconoscere, e pensare che sono pure veterinario. L’amica degli animali… sì, proprio. «Scusa, Potti, non avrai pensato…» Il suo sguardo, mezzo tramortito da tutte le ore di viaggio e di immobilità, è a dir poco interdetto. Quindi adesso arranco verso i nastri dei bagagli trascinandomi anche la gabbietta. Ho giusto il tempo di prendere un carrello per caricare le due grosse, enormi valigie da venti chili l’una. Dentro, tutta la mia vita, o quasi. La spalla destra mi fa malissimo, per fortuna c’è la sinistra. Evito di sistemare sul carrello la gabbietta e quindi me la trascino con il trolley che cerco di tenere come una polpessa con otto tentacoli. Potti pesa molto più del previsto (eppure non mi pareva obesa) e non la posso impilare sulle valigie: se dovesse scivolare e farsi male mia figlia mi strozzerebbe.
«Ciao, Rich, sono appena scesa dall’aereo. Tutto bene… No, ovviamente non sono riuscita a chiudere occhio. Come sempre.»
Mia dorme. Se penso che è giugno e lì di giorno non ci sono nemmeno venti gradi, ho subito la percezione della confusione in cui è stata gettata la mia vita. Ma ce la posso fare, ce la possiamo fare. Perché tutto è risolvibile, se gestito con calma. Il mio motto è: «Ora faccio tutto, una cosa alla volta». Adesso tocca all’ufficio immigrazione. Il colloquio per il visto l’ho già fatto a Roma, all’ambasciata, quindi l’operazione scorre abbastanza liscia. L’addetto scarica un timbro sul mio passaporto e sui documenti di Potti. È un ragazzo lentigginoso ma abbronzato, capelli a spazzola e tempie lucide, sorriso regolare e accecante.
«Welcome to the United States, professor Capua.»
Ci siamo, inizia il nostro sogno americano. Mentre esco, ho un attimo di smarrimento. Ripenso ai tanti che mi hanno preceduto in questo stesso percorso. Negli anni, milioni e milioni. Certo, io non arrivo in una cabina di terza classe con le valigie di cartone, ma con un volo in business e un contratto con un’università importante. Dirigerò un centro di ricerca che mira a diventare in qualche anno leader internazionale: una nuova sfida, avvincente ed esaltante. Eppure sento dentro qualcosa di strano, come se una mano mi afferrasse le viscere e me le torcesse. Chiamatelo magone, o anticipo di nostalgia. Amarezza. Un sentimento che nelle ultime settimane ho cercato di seppellire da qualche parte dentro di me. Che ci faccio qui? Probabilmente la maggior parte delle persone sarebbe contenta di cominciare un’avventura come questa… Io no. Non l’ho scelta io, non sono io ad aver voluto abbandonare l’Italia; sono stata costretta. Per una volta ho dovuto arrendermi, ritirarmi nel mio guscio. Ecco come mi sento: arresa, retratta per sopravvivere.
Florida: qui le palme sono dappertutto, pure dentro l’aeroporto. Nel grande atrio del terminal, coperto da vetrate, i megaschermi proiettano le immagini della visita del presidente Obama, in corso proprio oggi e proprio in questa città, teatro di un’orribile strage. Che tragedia la carneficina nel locale Pulse di Orlando. E io sto andando a un’ora e mezzo di strada dal luogo del massacro. Ho paura? Sì.
Non è la prima volta che vengo qui. Ci sono già stata per il colloquio di lavoro, poi sono tornata per definire i termini del contratto e per cercare casa. La firma? Online! Click here to sign. La casa? Abbiamo scelto il terreno, visto che la stanno ancora costruendo. Abbiamo concluso tutto a tempo di record: siamo andati dai costruttori e abbiamo valutato centinaia di opzioni: lo stile, i materiali, i colori e le finiture. Scordatevi le file al Comune per le autorizzazioni, i documenti da decine di pagine da compilare, l’aria di mistero che circonda geometri e architetti. Qui in un paio d’ore hai la stampa in 3D della casa, poi una webcam ti informa in tempo reale dei lavori. Il «fast food» dell’edilizia, e non solo di quello. Avanti, passo dopo passo, ma la direzione è quella giusta? Meglio non farsi troppe domande, quindi accelero verso il box dell’autonoleggio.
«Vorrei un’auto fino a Gainesville, per favore. Ci dovrebbe essere una prenotazione a nome Capua. Con la C, non la K. Basta una qualsiasi, ho solo il gatto e un paio di valigie.»
«Oggi abbiamo la promozione per le cabrio» mi risponde il commesso. «Vuole approfittarne?»
Io su una decappottabile? Ma anche no. Io che detesto guidare, tra l’altro. Sembrerei una cretina, e poi mi si annoderebbero i capelli. Dall’altra parte, però, c’è un ragazzo dalla faccia furba, di Trinidad, armato di un sorriso simpatico. Ha intercettato l’accento e mi dice in italiano: «Wow Italia, belle macchine». Un tempo avrebbe detto: «Belle donne».
Alla fine mi ritrovo nel parcheggio alla ricerca dell’auto. Un caldo soffocante. Ed ecco qui la Camry rossa con tanto di strisce da corsa… e ovviamente, accanto, la mia Fiat 500X. Perché sì, bisogna restare con i piedi per terra: non siamo Thelma e Louise, ma Ilaria e Potti, una donna scienziato italiana e una gatta dal genere incerto: è femmina, ma sembra un maschio, due specie un po’ sfigate e assolutamente non protette. E questo non è un viaggio verso la libertà, o forse sì? Domani mattina ho già il primo incontro all’università. Però anche la mia macchinetta è rosso fiammante, e soprattutto è italiana. «Prendo questa.»
Un ultimo sforzo e riesco in qualche modo a buttare i miei due bauli carenati sui sedili posteriori. Quanto pesano. Nuova fitta alla spalla, più forte. Devo ricordarmi di farla vedere appena possibile. Devo andare in palestra. Mi sistemo, metto la gabbietta di Potti sul sedile del passeggero. È allora che incontro il suo sguardo implorante. «Va bene» dico, «ho capito. Tu però prometti di non fare la pazza.» Interpreto il silenzio come un sì e apro la gabbietta. Se mi beccano a circolare con un gatto in libertà nell’abitacolo mi sbattono in prigione, penso. Infatti, dopo due carezze e qualche croccantino, la rimetto dentro. Mi chiedo per quale fatalità o scherzo del destino questa avventura debba iniziare proprio con lei e non con Mia e Richard. Ma la risposta la so già: era semplicemente la cosa più razionale da fare. Io ho preso sulle mie robuste spalle femminili l’ultima parte del trasloco, mentre loro ne hanno approfittato per andare a trovare la nonna a Ayr, Scozia del Sud. Un po’ di tranquillità mentre io scavo la trincea che proteggerà il loro sbarco.
L’aria è vestita di una luce tersa, quasi accecante nella sua luminosità. Da noi non è così, sarà l’oceano, anche se qui non è proprio vicino. Mi siedo, prendo la borsa e rovisto un secondo… Trovato! Collego l’iPod all’autoradio e ascolto partire la musica; Back to Life di Giovanni Allevi, la prima traccia della compilation che Richard ha preparato per me. Il bello di avere un musicista come marito. Una musica semplice, che sgorga quasi naturalmente e senza pretese, senza invadenza. Una canzone che fotografa quella malinconia alla quale proprio non dovresti cedere all’inizio di un’avventura.
E allora, Rich, scusami, ma adesso proprio no. Non ce la faccio. Sono distrutta da quattordici ore di tragitto e da settimane dedicate a traslochi, saluti, viaggi tra Roma, Padova, Milano e Istanbul, lampi di ottimismo e burroni di depressione. Lacrime trattenute e lacrime sgorgate. Occhi lucidi che, quando si chiudono, generano una perla che si appoggia sulle ciglia.
Ho ancora due ore di guida su strade che non conosco, verso un letto che non è il mio. Sono sola, spersa in un Paese enorme, senza alcun salvagente affettivo se non Potti, la mia borsetta di medicinali e me stessa. Insomma per malinconia e introspezione ci sarà tempo, adesso ho bisogno di energia pura. Torno a rovistare nella borsa. Eccola qui, la mia arma segreta. Seleziono nel lettore e scorro avanti la playlist.
Mentre esco dal parcheggio parte il suono della chitarra, di quella chitarra, e subito dopo la voce calda e imperfetta di Mark Knopfler. Alzo il volume e si compie il miracolo di Sultans of Swing dei Dire Straits. Non riuscirò mai ad abituarmici: è la mia canzone preferita da sempre, fin da ragazza. Ne conosco ogni versione. D’un tratto mi sembra di non aver dato solo un giro alla chiave, ma anche al mio umore, alla mia vita intera. Mentre seguo le indicazioni per la Highway, respiro a piene narici quella musica che mi entra nel sangue come fosse ossigeno. Quante centinaia e centinaia di volte l’avrò ascoltata? Mi accompagna fin dalla scuola, da quando viaggiavo tra Roma e Perugia per studiare, poi a Teramo, poi ancora a Padova. È stata parte di me quando mio padre stava male e andavo a trovarlo, consapevole della mia impotenza. E poi in ogni viaggio, prima di ogni relazione o conferenza importante. La ascoltavo a Punta Ala ogni volta che tornavo dal mare. Perché «You feel alright when you hear that music ring», stai bene solo se hai una musica ad accompagnarti, anche solo dentro la tua testa. Peter, mio amico di scorribande, mi aveva introdotto a questo distillato complesso di energia. Sì, nel gruppetto di quattro (io e tre maschi, lo stesso Peter, Paolo e Andrea), lui era quello che più si dava arie di conoscere la musica. Parlava di gruppi dal nome incomprensibile per noi, tipo Led Zeppelin e, appunto, Dire Straits. Faceva un po’ l’esperto, quello che capiva di musica seria. E noi lo prendevamo in giro.
Entro in un’autostrada, sono le 8 di sera e ci sono ancora 160 chilometri da percorrere, anzi 110 miglia; destinazione: la casa che abbiamo preso in affitto per i primi tre mesi in attesa che sia pronta quella che abbiamo comprato. Il sole si abbassa, le ombre delle palme si allungano. Guardo con insistenza il navigatore che mi dice quanto manca. Un’ora e 45, un’ora e 38, un’ora e 29. Mi sembra di non arrivare mai. La stanchezza inizia a farsi sentire. Eppure sono qui, fragile ma sul pezzo, e soprattutto viva. Potti mi ricorda la sua presenza con ripetuti miagolii gutturali… povera bestia.
Sono di nuovo io, Ilaria, e negli ultimi due anni – quasi tre – ho imparato che nemmeno questo è scontato. Ricomincio da capo, di nuovo.
![]()
2
Chiamatela vocazione, fuoco sacro o quello che preferite. Tra le mie compagne c’era chi voleva fare la cantante, chi la sarta d’alta moda, la ballerina, l’attrice: io ho sempre saputo che avrei fatto la ricercatrice. Gli ABBA cantavano «I have a dream, a song to sing», e quando da ragazzina li ascoltavo nella mia camera piccola piccola, sentivo che anch’io avevo un sogno da vivere, una canzone tutta mia da cantare. Non la conoscevo ancora, ma sapevo più o meno il genere. Avrei potuto fare ricerca sul cancro o sui batteri, sugli animali o sui virus, come poi effettivamente è stato. La cosa importante era scoprire, studiare, dedurre, applicare la logica alla natura. La scienza mi interessava, trovavo affascinanti l’evoluzione, la riproduzione sessuata e quella asessuata delle piante. Soprattutto trovavo affascinante cosa potessero fare quelli che voi chiamate microbi. Due batteri anaerobi, cioè che vivono senza ossigeno (pensate un po’), producono delle sostanze potentissime, che hanno un’azione diretta sul sistema nervoso degli animali superiori. Sono il Clostridium tetani e il Clostridium botulinum, responsabili rispettivamente del tetano e del botulino, due malattie che ancora oggi provocano migliaia di decessi nel mondo. A nulla serve la terapia antibiotica, perché non sono i batteri a generare il danno, ma la loro tossina.
A ripensarci, direi che il fisico non avrei potuto farlo, è una scienza troppo dura per me.
In famiglia l’unico ad aver intrapreso una carriera scientifica era stato mio nonno materno, Mario Bandini, illustre (per davvero) cattedratico di Economia e politica agraria. Dalla parte di papà, tutti avvocati. Tranne uno dei nove fratelli di mio nonno, medico tisiologo.
Carlo, mio padre, avvocato di grido, e Maria Grazia, mia madre, figlia dell’illustre di cui sopra. Casa vicino a Porta Pia, poi il trasferimento all’Olgiata, zona residenziale alle porte di Roma. Durante le vacanze estive andiamo a Punta Ala: un bel quadro borghese. Ma burrascoso. Mio padre è brillante, istrionico, elegante come un lord e spiritoso come solo un napoletano sa essere… Un intrattenitore nato, racconta storie della sua infanzia, della professione, del collegio militare, sempre colorate come un quadro impressionista. Mille e mille sfaccettature di colori per descrivere in modo esilarante le peripezie della sua vita. Tutto il contrario di mia madre, bella, elegantissima, più incline al silenzio e alla riservatezza, alla frugalità. Lui è un buongustaio che conosce ogni specialità gastronomica di ogni angolo d’Italia. Lei ci dà i cracker integrali, «che tanto sono uguali al pane». Noi siamo tre: io, la maggiore, seguita dopo un anno e mezzo da Alessandra e, dopo altri sette, da Michelangelo.
Fin da piccola il mio compito è non dare problemi. I miei ne hanno già troppi, a cominciare dal loro matrimonio difficile. Quindi mai lamentarsi, portare a casa buoni voti e soprattutto aspettare. Di andare via. Mica per cattiveria, per sopravvivenza. E loro per aiutarmi ce la mettono tutta. Vado in primina a quattro anni… perché mamma ha da fare con nonno Mario gravemente malato. Lei tra l’altro racconta al preside che di anni ne avevo già compiuti cinque. Per lo stesso motivo passo direttamente dalla terza media alla seconda superiore. La mia famiglia si è ormai sfasciata, mamma è in grosse difficoltà organizzative e logistiche. Mi vuole iscrivere a un liceo internazionale, ma nella classe a cui sarei destinata non c’è posto. È tardi per le iscrizioni – ripete all’inizio il preside –, alla fine è lui, mosso a compassione, a mettermi nell’equivalente della seconda liceo a tredici anni. «Se non ce la fa ripeterà l’anno.» E così, enfant prodige per caso, brucio le tappe. Al St. George’s tutti i corsi sono in inglese, il dono più grande dei miei genitori. Perché imparare bene l’inglese e crescere in un ambiente internazionale mi ha aperto la testa e l’immaginazione, anche quella scientifica.
La mia infanzia fugge via a velocità folle: mi diplomo a diciassette anni, la più piccola del...