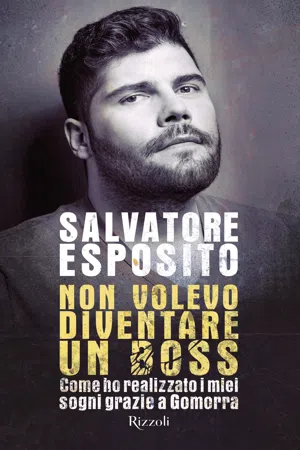![]()
1
Tra i figli dell’Annunziata
Il cortile è luminoso e trasmette un senso di serenità, è una sorta di oasi di silenzio nella frenesia di macchine e motorini che sfrecciano nel quartiere di Forcella, uno dei più convulsi della città. Non sono mai stato all’ospedale dell’Annunziata e non ne so quasi niente. Quasi, appunto. Perché accanto a me c’è mio padre che questo posto, invece, lo conosce molto bene.
Mi hanno invitato, come spesso fanno con i personaggi dello spettacolo, ad andare a trovare dei bambini nel reparto di oncologia pediatrica e io, sebbene poco convinto, ho deciso di farlo, pensando che, in fondo, sia un po’ mio dovere.
Non so dire che cosa mi aspettassi di preciso, ma di certo non ciò che mi trovo di fronte: nel venire qui in taxi oscillavo tra l’immagine di un luogo caotico e degradato e quella di uno spazio asettico e senza carattere. Invece entro in questo cortile settecentesco tranquillo e curato, con alberi folti e uno scalone monumentale a doppia rampa che conduce ai reparti. Mi volto appena verso mio padre che è rimasto pochi passi dietro di me: cammina piano ma non guarda la fontana al centro del cortile, gli alti finestroni che bucano i muri color ruggine, e non legge, come cerco invece di fare io, l’iscrizione in marmo che sormonta il portone d’ingresso.
Le mani dietro la schiena, lo sguardo basso come se i suoi occhi cercassero qualcosa sul selciato. E lì, all’improvviso, mi viene in mente. Quando mi è arrivato l’invito, non ci ho pensato. O forse non ci ho voluto pensare, l’ho semplicemente rimosso. Ma poi vedo mio padre con questo passo lento, incerto, come se cercasse un ricordo, un segno, una traccia. Aspetto qualche secondo che mi raggiunga e, mettendo da parte la tensione per quello che sto per vedere ai piani superiori, per la sofferenza in cui fra poco mi immergerò, tento di catturare i suoi occhi e, appena ci riesco, gli domando: «Papà, che cosa stai rivedendo in questo posto?».
Perché mio padre è cresciuto qui, è stato adottato quando questo luogo era ancora un orfanotrofio, prima che lo trasformassero in un ospedale.
Io lo sapevo da tempo, me lo aveva raccontato lui stesso quando ero diventato abbastanza grande per capire. Però era un’informazione rimasta lì, una rivelazione subito messa in un cassetto e lasciata dormire. Poi, una sera di giugno, trasmettevano la prima serie di Gomorra. Nell’ultima puntata c’è una scena in cui Genny, il mio personaggio, trova in un armadio un CD, grazie al quale scopre cose che non poteva immaginare sulla sua famiglia e sui suoi affetti più cari. Quando la puntata andò in onda ero a casa con i miei: al culmine della scena, per puro caso, mi voltai verso mio padre e vidi il turbamento nei suoi occhi. Aspettai i titoli di coda e mi avvicinai.
«Tutto bene?» gli chiesi.
Lui fece cenno di sì con la testa e dopo una lunga pausa, guardando fisso davanti a sé, mi sussurrò: «Anche io l’ho saputo così. Avevo dodici anni e per caso ho trovato, in una vecchia borsa di mia madre, nell’armadio in camera dei miei genitori, un documento. Un documento in cui si diceva che ero stato adottato. Ero uno dei “figli” dell’Annunziata…».
Torno a guardarlo con l’affetto che un padre sempre presente come lui merita e con il rispetto profondo per chi in questo momento sta rivivendo il dolore della sua infanzia.
Saliamo la scalinata e ad accoglierci c’è un giovane funzionario che per prima cosa ci descrive a grandi linee la storia di questo luogo, il suo essere stato per secoli uno dei brefotrofi più grandi d’Italia. Al secondo piano – racconta questo signore dal sorriso gentile – c’è l’Archivio degli Esposti. Si chiamavano così perché venivano “esposti”, cioè lasciati, su una ruota che girava verso l’interno depositando anonimamente il bambino nelle mani della Casa. La ruota ormai non è più in funzione da tempo, ma i piccoli abbandonati hanno continuato a essere consegnati all’istituto fino a pochi anni fa. In questo archivio c’è tutta la storia delle migliaia di bimbi passati per la ruota: tutto raccolto in faldoni, ciascuno con una scheda. E in ognuno di questi fascicoli c’è una busta sigillata. Con dentro il nome della madre naturale, quando era disponibile, il giorno e l’ora d’ingresso, l’età del piccolo e i segni distintivi con cui era stato consegnato. Un oggetto, un abitino, una piccola moneta, nella speranza di poterlo, in un giorno di miglior fortuna, riconoscere e venirlo a riprendere.
Dopo il racconto della storia dell’istituto ci portano nel reparto. Sono concentrato sull’obiettivo che mi sono prefissato: dare un paio d’ore di gioia e di spensieratezza a questi bambini e ai loro genitori. All’ingresso ci sono i ragazzi della Onlus che si occupa di clown therapy all’interno dell’ospedale. Ad accoglierci con un abbraccio è Francesco Verde: sua sorella Gelsomina è stata una delle più note vittime innocenti della cosiddetta “prima faida di Scampia”. Nel 2004, a ventidue anni, fu torturata a morte e poi bruciata per nascondere le tracce dello scempio che le era stato fatto. A causa di una guerra con cui lei non aveva nulla da spartire. Francesco ha trasformato quel dolore incredulo nella voglia incrollabile di portare un sorriso a chi è meno fortunato.
Tutti mi ringraziano, quando invece vorrei essere io a ringraziare loro per quello che sto vivendo. Prima di entrare in reparto mi passano alcune grandi buste colme di regali che distribuirò personalmente. Il primo impatto è traumatico: bambini di appena un anno senza capelli per gli effetti della chemioterapia, altri attaccati con fili e tubicini a dei macchinari, altri ancora che invece sembrano stare bene. Presto scopro che quelli sono i più gravi, i piccolissimi malati terminali per cui non ci sono più speranze. Molti di loro non sanno nemmeno chi io sia perché a quattro o cinque anni non ti fanno certo vedere Gomorra. In compenso i genitori mi dicono che la sera, quando i bambini si addormentano, si riuniscono in una saletta dotata di lettore dvd a vedere e rivedere le puntate.
Mi sento impotente di fronte a tutta questa sofferenza. Poi una giovane mamma mi prende la mano e mi chiede di raccontarle un po’ di me. Sì, di me, della mia vita, non del personaggio che interpreto. E solo adesso mi accorgo che i pochi minuti di distrazione che porto a queste famiglie hanno un senso. Perché li guardo in faccia uno a uno, quei ragazzi che avranno tutti più o meno la mia età, e penso che oltre al dramma dei bambini c’è quello dei genitori, che sono costretti a lasciare l’impiego o ad accettare di lavorare di notte per assistere un figlio che sta male. E mi sento un privilegiato a poter regalare una nota di simpatia nella giornata di queste madri e di questi padri. Finito il giro, saluto tutti e scendo di nuovo in cortile, ma l’esortazione di quella giovane mamma mi torna in mente con insistenza.
«Parlaci un po’ di te…»
Già. Di me. Non mi hanno chiesto di raccontare di Genny Savastano, non mi hanno chiesto come andrà a finire Gomorra. No. Mi hanno chiesto di Salvatore. Mi siedo sullo scalone e respiro forte. Mio padre questa volta sposta lo sguardo attorno e in alto, mentre sono io a tenere gli occhi bassi a terra.
«… di te…»
Ripenso ai bambini che ho lasciato in reparto e a tutte le storie racchiuse nei faldoni al secondo piano.
Alzo lo sguardo, vedo mio padre e finalmente sorrido. Perché ogni vita è una storia da raccontare, perché le vite non devono essere dimenticate. E perché in questo preciso istante ho deciso di raccontare la mia, di storia. Che parte proprio da qui.
![]()
2
Una famiglia come la mia
Ogni storia comincia con un ricordo, con il primo ricordo. Per alcuni è un luogo particolare, per altri un evento, lieto o meno, per altri ancora un sapore o un odore. Per me è la neve. Per la precisione, io che dal bagno chiamo mia madre e le dico: «Mamma, corri, corri… la neve!».
E visto che dovevamo essere più o meno a maggio, l’evento era se non altro anomalo: in realtà stavo semplicemente lanciando in aria il detersivo in polvere divertendomi a simulare una nevicata.
È quella la prima traccia che ho, o che ritengo di avere, della mia infanzia; perché, a dire il vero, molti episodi me li hanno raccontati i miei genitori più e più volte, fino a farli confondere con i ricordi stessi. Salvatore che, lasciato solo a casa, dà da mangiare al videoregistratore e mamma e papà se ne accorgono solo quando il tecnico lo smonta perché non funziona più e ci trova dentro biscotti, latte andato a male e cereali; o Salvatore che usa lo sportello del forno come base di partenza di uno scivolo improvvisato fino a che quello non si rompe.
Il luogo è sempre lo stesso: la casa dove ancora oggi vivono i miei genitori. Anche se è cambiata, è stata completamente ristrutturata e i mobili non sono più gli stessi di quando ero bambino, è quello il posto dei ricordi. L’unico spazio rimasto uguale a se stesso è lo sgabuzzino, dove mi rifugiavo ogni volta che combinavo un guaio. Se dovessi identificare un luogo della memoria, forse sarebbe proprio quello sgabuzzino.
Essendo un bambino molto estroverso, nel palazzo dove vivevo mi conoscevano tutti. Come spesso accade da queste parti, nei condomini si creano fitte reti di solidarietà: infatti sono cresciuto a stretto contatto con la dirimpettaia, la signora Riccio, e con la signora Fortuna del piano di sopra con cui, alternativamente, mia madre mi lasciava quando doveva andare a fare delle commissioni o quando, esasperata dai miei comportamenti, cercava un attimo di respiro. La signora Fortuna aveva in casa una grande borsa piena di animaletti di gomma con cui giocavo quando toccava a lei occuparsi di me. Sono sempre stato accolto bene da tutti perché ero un bambino solare che si faceva voler bene e ancora oggi, quando torno dai miei, è un po’ una festa per tutti gli inquilini del palazzo.
Il parco era molto grande e c’erano anche un campo di calcio, sebbene in cemento, e delle giostrine; a differenza di altre realtà di periferia dove si tende a costruire all’infinito, il mio era un parco alberato tranquillo e con tanto verde.
La mia infanzia da bambino scapestrato, alla fine, è stata divertente nonostante le intemperanze, che aumentarono esponenzialmente quando nacque mia sorella. Avevo quattro anni e iniziai a sentire la comunissima gelosia che molti primogeniti nutrono: le attenzioni, che fino a quel momento erano tutte per me, si stavano pian piano spostando su chi ne aveva più bisogno. E io, da buon accentratore e da prepotente nato, cercavo sempre di attirare gli sguardi su di me, producendomi in ogni sorta di disastro.
Con mia sorella, negli anni, si è poi consolidato uno splendido rapporto: da nemica si è trasformata nella mia migliore amica, nella mia compagna di giochi. Abbiamo condiviso la stanzetta per anni e, in uno dei primi ricordi vividi che ho di lei – avrà avuto quattro anni –, la costringevo a giocare a calcio con le sue Barbie: una biglia fungeva da pallone mentre con le sue bambole costituivamo le squadre.
Spesso andavamo, e andiamo tuttora, al cinema da soli (a volte ci scambiavano per fidanzati) ed è stata Anna a darmi una mano quando preparavo le scene di Gomorra, mi faceva da spalla e mi dava le battute. Non a caso è con lei che ho aperto una società: quando hai bisogno di qualcuno di cui fidarti ciecamente le prime persone a cui pensi sono i tuoi familiari. Sempre che si abbia una famiglia come la mia…
Leggere di infanzie difficili, tormentate, problematiche, mi fa sentire di essere stato un privilegiato: la mia, tutto sommato, è stata bella.
Quando invece, nel 2009, è arrivato mio fratello per me è stata da subito una gioia immensa, poiché ho vissuto l’evento quasi come se mi fosse nato un figlio. Avevo quasi ventiquattro anni, la stessa età di mio padre quando ha avuto me, quindi è naturale che tuttora io abbia un istinto, verso di lui, molto più paterno che fraterno. Christian adesso è il principe di casa, un ometto divertente che sembra già un ragazzo grande e che non dimostra di avere quasi sette anni: è molto intelligente e va sempre in giro vantandosi di avere un fratello che fa l’attore. Mi piace essere il primo che lo vizia, stando però attento a non trasmettergli la sensazione che possa ottenere e fare tutto ciò che vuole. Per l’intera famiglia il suo arrivo ha rappresentato una gioia enorme, ma per i miei genitori ha significato qualcosa in più, perché un figlio piccolo li farà sentire giovani ancora per tanti anni a venire.
La famiglia è il fulcro della mia esistenza. Affetto a parte, è mio padre a essere sempre al mio fianco nei momenti più importanti: mi consiglia, mi sostiene, mi soccorre. Il rapporto con il padre è spesso il grande cruccio di ogni figlio, perché quello dei genitori è un lavoro per cui non esistono scuole… Però posso dire di essere stato molto fortunato perché sia con mia madre sia con mio padre si è sviluppato, negli anni, un gran dialogo. Mio padre ha cercato di farmi crescere in modo che io sapessi sempre che, qualsiasi decisione avessi dovuto prendere nella vita, avrei avuto una persona accanto a me pronta a valutare le diverse opzioni, ma senza mai obbligarmi a nulla.
Lui è sempre stato il mio primo fan, un’affermazione che può apparire banale, ma che ha un suo peso nella crescita di un individuo, perché significa che è stato il primo ad aver creduto nelle mie potenzialità, nel mio sogno, appoggiandomi sempre e facendo tutti i sacrifici necessari per permettermi di continuare a studiare a Roma. Mi è stato vicino e mi ha supportato quando ho deciso di lasciare il McDonald’s per tentare la carriera d’attore, mi ha sempre accompagnato a Roma a fare i provini e i test d’ingresso all’Accademia: insomma, non è mai stato uno di quei padri che mette i bastoni tra le ruote e tarpa le ali ai figli, ha capito che per me quello era il sogno della vita e che non avrei voluto vivere con un rimpianto.
La frase che mi ha ripetuto più di una volta è stata: «Io credo in te, appoggio questa tua idea e se c’è da fare un sacrificio lo faremo tutti assieme».
Mio padre è un uomo corpulento dal quale ho preso la struttura robusta che mi caratterizza: è un gran lavoratore che ha fatto tantissimo per la famiglia, l’ha posta sempre al centro di tutta la sua vita, non ci ha fatto mancare mai nulla nonostante le difficoltà di un lavoro, quello del barbiere, che sta lentamente scomparendo. Ha fatto sacrifici per permettermi, per esempio, di frequentare le scuole medie in un istituto di eccellenza come il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.
La sua grande vittoria è stata riuscire a farmi capire, fin da quando ero ragazzino, cos’era giusto e cosa sbagliato. Ogni volta che mi trovavo di fronte a una situazione difficile risuonava nella mia mente la sua voce: grazie a lui mi ponevo le domande corrette che sono state poi la mia salvezza.
Lui ha sempre fatto il barbiere, da quando era adolescente, nella stessa bottega in cui lavorava con mio nonno: durante l’estate, quando ero ancora bambino, provavano a farmi stare un po’ al negozio per vedere se mi appassionavo a quel mestiere e se potevo seguire le orme di famiglia.
Io, però, non ne avevo alcuna intenzione e andavo lì solo per leggere i giornali sportivi. Ogni tanto mio padre mi mandava a prendere una volta il caffè per i clienti, una volta il Corriere dello Sport in edicola: mi dava i soldi ma non gli restituivo mai il resto e quando tornavo a casa andavo da mia madre, le mostravo quei soldi e le dicevo: «Guarda, mamma, quanto ho guadagnato oggi…».
Ovviamente mio padre se ne accorgeva benissimo, ma da persona buona, comprensiva e affettuosa qual è sorrideva di queste mie piccole, innocenti mascalzonate.
Mia madre invece è la classica mamma chioccia napoletana che tratta i figli come principi: è in grado di rinunciare a tutto per noi e ci coccola come dei ragazzini anche a trent’anni, non ci ha fatto mai mancare nulla.
Mi ha avuto a ventun anni: credo che ci siano delle donne nate per fare le madri, lei è sicuramente una di quelle ed è sempre bello stare lì da lei.
Quando scoprì di essere incinta di mio fratello Christian, in famiglia era ancora vivo il dolore per la morte del nonno: c’era sempre un’atmosfera un po’ pesante dovuta all’assenza di una persona che aveva vissuto con noi da quando eravamo nati. Ma con quella gravidanza mia madre appariva come ringiovanita di dieci anni e sembrava davvero molto più giovane dei quarantacinque anni che aveva all’epoca. Io le sono stato vicino nel corso di tutta la gravidanza, specialmente quando mio padre era al lavoro, e a volte in ospedale pensavano fossi io il compagno di mia madre: del resto una grossa differenza d’età non è rara, soprattutto ultimamente, in una coppia. È stato bello in quel periodo stare sempre con lei: ho ritirato io le analisi da cui si scoprì che era incinta, ho saputo io per primo il sesso di mio fratello e ricoprire questo ruolo è stato per me molto importante.
Parlavo di più con mia madre che non con mio padre, anche di cose intime, per esempio delle ragazze che mi piacevano: lo so che può apparire una cosa strana, però trovo molto più semplice confidarmi con lei, perché penso che sia la persona in grado di darmi i consigli giusti. È una donna che ha sempre pensato alla famiglia, è di animo buono ed è una madre presente. Forse il motivo per cui ho aspettato tanto prima di legarmi sentimentalmente a una persona è dovuto proprio al fatto che la mia donna ideale dovesse essere simile a mia madre. Per questo Paola, la mia fidanzata, è così importante per me, perché mi ricorda quell’ideale di donna: dolce, forte, che sa cavarsela da sola, ma allo stesso tempo capace di sapersi relazionare con chiunque.
Del resto ai miei genitori devo riconoscere, al di là di ogni cosa, una grande qualità: l’aver avuto un’infinita pazienza con me. Nonostante il faccino d’angelo, da bambino ero un pazzo scatenato: istintivamente sentivo che qualsiasi cosa desiderassi la dovevo prendere. Chissà perché alcune persone nascono con un’indole più tranquilla mentre altre con una da prepotente; non so se dipenda dalla genetica o dal modo in cui sei stato allevato. Io, semplicemente, quando volevo una cosa dovevo averla, a tutti i costi.
Per questo motivo, da piccolo di botte ne ho prese eccome, ma non riuscivano comunque a farmi perdere l’atteggiamento indisponente: mio padre racconta sempre che a sei anni, ogni volta che mi dava un meritatissimo schiaffo, lo guardavo con aria di sfida e gli dicevo: «Tanto non mi fai niente». A sei anni! Gli altri bambini erano poi le vittime predestinate della mia prepotenza e se c’era da fare a botte non mi tiravo mai indietro. Anche a scuola ero tirannico e sbruffone: se capitava che in classe afferrassi un concetto prima degli altri, insultavo chi era più lento di me.
Non comprendevo perché, nonostante ascoltassimo la stessa lezione, loro ci mettessero più tempo a capire. Al primo anno di elementari la maestra ci spiegava le quattro operazioni e io, non so come, riuscivo a risolverle spesso prima degl...