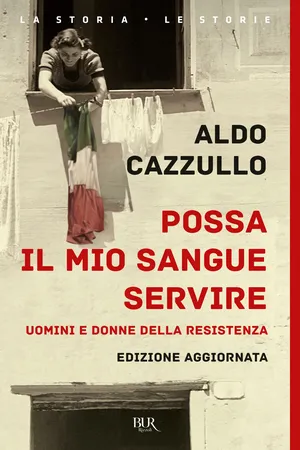![]()
Spoon River su Facebook
Anche stavolta, come per La guerra dei nostri nonni, ho chiesto via Facebook storie e testimonianze dei mesi terribili tra il 1943 e il 1945, non solo sulla lotta di liberazione ma pure sulle varie forme di Resistenza, anche minime e quotidiane, al nazifascismo. Anche stavolta ne ho ricevute alcune straordinarie, altre più normali, talora anche critiche, ma in molti mi hanno chiesto la stessa cosa: parli di mio padre, di mia madre, di mio nonno, di mia nonna, non perché fosse un eroe, ma perché era una brava persona; amava l’Italia, credeva nell’Italia, non si riconoscerebbe nell’Italia di oggi. Sono voci preziose, che restituiscono l’atmosfera di quel tempo. Ringrazio chi ne ha fatto dono a me e ai lettori.
Tutti alzammo la mano
Dal diario di mio padre. 18 settembre 1943. Un ufficiale tedesco parlò all’interprete, il quale si rivolse a noi dicendo: «Il capitano tedesco chiede se già sapete che il Duce è stato liberato». Nessuno rispose. Il capitano salì sul tavolo con l’interprete, parlò ancora con quest’ultimo, il quale ci disse: «Il capitano chiede ancora se siete a conoscenza che, dopo la liberazione del Duce, una nuova Italia sta per risorgere». Nessuno rispose. Indispettito, il capitano sussurrò qualcosa all’interprete, che con il megafono gridò: «Chi di voi è fascista alzi la mano!». Nessuno alzò la mano. Allora il capitano, ormai disilluso, fece chiedere: «Chi non è fascista alzi la mano!». Eravamo tanti, duemila o più. Davanti a noi si apriva la strada della prigionia e si delineava un futuro pieno di sofferenza e di dolore: miniere, fabbriche, altiforni… E tutti alzammo la mano.
Graziella Morra
Cambiavamo i cartelli stradali dei tedeschi
C’era già stato l’8 settembre e i tedeschi impazzavano per Roma. Avevo poco più di tredici anni, abitavo a Montesacro, quartiere allora di periferia. I tedeschi non si fidavano dei romani e per girare senza chiedere informazioni, che ritenevano inattendibili, avevano sistemato ovunque grossi cartelli indicanti le più varie direzioni. Proprio in piazza Menenio Agrippa, dove la Nomentana fa un gomito, ce n’erano parecchi. Io, con mia sorella e una altrettanto giovane amica ci «divertivamo», con l’aria più tranquilla e indifferente possibile, a spostare i cartelli, cambiando quindi le indicazioni. La cosa creava imbarazzo soprattutto alle motociclette e noi ci sentivamo importanti. Non credo in questo caso si possa parlare di Resistenza, ma a me, che ormai sono molto anziana, fa piacere ricordare l’episodio. E c’è un’altra cosa di quel periodo che mi torna alla memoria. Stavano arrivando gli americani e i tedeschi avevano minato il ponte Tazio che, sull’Aniene, porta in città. Si disse che l’ingegnere che aveva costruito il ponte anni prima e che viveva a Montesacro fosse andato incontro agli americani per avvertirli, visto che lui poteva sapere dove erano state posizionate le mine. Il ponte venne rapidamente sminato, ma una carica purtroppo esplose, uccidendo un ragazzo, molto giovane, americano. E allora avvenne una cosa bellissima, il giovane fu deposto sopra una jeep, accanto al buco creato dall’esplosione e tutta la popolazione di Montesacro, spontaneamente, lo ricoprì di fiori. Ancora al ricordo mi emoziono.
Mara Felicori
Mimma non aveva più il seno
L’11 dicembre 1944, alle quattro della notte, le squadre fasciste vanno a prelevare Francesca Del Rio, nome di battaglia Mimma, tanto brutalmente che la trascinano via svestita, in ciabatte. Li comanda un certo Luigi Arduini, un vero ragazzo di Salò, diciannove anni, ma aguzzino torturatore. Anziché trattenerla alle carceri di Reggio, viene mandata a Ciano d’Enza, dove ci sono i tedeschi con il loro centro antiguerriglia.
Racconta Mimma: «Indossavano delle tute insanguinate. Avevano dei bastoni, dei manici di scopa che ci infilavano da tutte le parti. Io non aprivo gli occhi, non guardavo, ma non ho mai parlato, non ho mai parlato». Se avesse parlato tutti noi della sua zona saremmo stati arrestati e le case bruciate.
Mimma era in stato di gravidanza abbastanza avanzato e il 10 gennaio ’45 riesce ad andare in bagno, dove c’è un piccolo finestrino. Passa dalla strettoia, sotto c’è la neve. Si aggrappa alla grondaia, le mani spellate sanguinano, deve scavalcare una rete e via nella neve, scalza, svestita. Giunge a Grassano, dove l’aiutano dei contadini. Drammatico il parto, travaglio lunghissimo. Il bimbo non ce l’ha fatta.
Racconta ancora: «Fui sottoposta a torture, ma di queste non voglio parlare. Ho impiegato tutta la vita a cercare di dimenticare. Soffro troppo ancora a questi ricordi». Non le ha raccontate nemmeno al marito. Confessa di averne parlato soltanto da poco a un medico, un professore, perché aveva un tumore al seno. «Lui si è messo seduto davanti a me e ha detto: “Mi racconti; siamo soli io e lei e io sono il dottore, devo sapere”. Perché ha visto che non avevo il capezzolo, insomma, era tutto tagliuzzato. Il dottore alla fine si è messo a piangere».
Ha allattato tre figli con un seno solo. Ha sofferto tantissimo per i piedi congelati, chiedeva di tagliarglieli tanto era forte il dolore, invece ha sopportato venti operazioni. Dice: «Ho ancora i miei piedi, ma mi sembra sempre di portare scarpe di ferro». Mimma è morta nel 2010.
Teresa Vergalli
Sulle spalle di mio padre sotto le bombe
Nel settembre 1943 avevo sei anni. Da alcuni mesi mi trovavo ricoverato agli Ospedali Riuniti di Salerno per un delicato intervento alla gamba. La guerra imperversava e ogni giorno le notizie di uno sbarco alleato nel Golfo di Salerno si facevano più insistenti.
Preoccupati dal precipitare degli eventi, i miei genitori, partendo da Campagna (35 chilometri a sud di Salerno), raggiunsero l’ospedale dove ero ricoverato, decisi a riportarmi a casa prima che scoppiasse il finimondo. Così, in un clima di fuggi fuggi generale, in breve tempo mi ritrovai fuori, portato in braccio da mio padre perché la mia gamba non era ancora guarita. Non si trovavano mezzi di trasporto e le linee ferroviarie erano distrutte. Le strade erano solcate solo da colonne di blindati tedeschi che arretravano velocemente verso l’interno in attesa di far scattare l’«operazione uragano» prevista da Kesselring per contrastare lo sbarco della quinta armata. Avevano già cominciato a ululare le sirene quando, sotto un sole cocente, percorrevamo la strada per Pontecagnano nascondendoci a ogni passaggio dei blindati tedeschi. Mio padre, che mi portava sulle spalle da alcune ore, esausto, chiese di fare una breve sosta. Ci sedemmo su un binario superstite e mangiammo una frittata con le cipolle che mia madre aveva pensato bene di portare. Non facemmo in tempo a finire che si scatenò l’inferno (che poi proseguì per tutto il giorno successivo, giorno dello sbarco): aerei americani volteggiando sulle nostre teste andavano a scaricare il loro carico di bombe sulle postazioni tedesche che rispondevano colpo su colpo con la contraerea. Una valanga di fuoco, proveniente dal mare, si abbatté su tutta la costa.
Terrorizzati riprendemmo a correre tra la strada e i binari in direzione sud. A un tratto sulla via deserta comparve un calesse. A un cenno del conducente salimmo e riuscimmo ad allontanarci dal pericolo e a raggiungere Eboli. Fummo fortunati perché riuscimmo a prendere la corriera che portava a Campagna e prima di sera eravamo a casa. Era l’8 settembre 1943.
Gelsomino Di Chiara
Come mia madre salvò la mia sorellina
Una notte di novembre del 1943, al suono della sirena, mia madre rassettò ogni cosa, spense le luci, chiuse la porta di casa e corse con sole due bambine, Elisa e Maria, verso il rifugio. Quando arrivò si accorse che aveva dimenticato l’altra sorellina, Jolanda, di pochi mesi, nella culletta. Ormai con le porte sbarrate per impedire passaggi di luce – il rifugio non poteva essere più aperto anche per non mettere a rischio l’incolumità degli altri rifugiati – mia madre lasciò le due bambine al sicuro, passò da una piccola finestra e con il rombo degli aerei sul capo, al buio e con tanta paura, attraversò il paese, tornò a casa, prese l’altra bimba che dormiva beatamente e ritornò al rifugio, contenta di avere riunita la propria famiglia anche nel pericolo. Quel gesto di coraggio le valse l’applauso di tutti i presenti nel rifugio e la paura di quella notte di bombardamenti fu per tutti meno grande.
Michele Vinci
Lezioni al mercato per il bambino ebreo
Sono nato da un matrimonio misto, non battezzato e non circonciso, col patto fra coniugi che avrei scelto io la religione da osservare. Nell’autunno 1938 venni ammesso al terzo anno di ginnasio inferiore al Parini, per poi essere «congedato» nella tarda primavera 1939. Ricordo mio padre e mia madre sul marciapiede di via Goito, di fronte al Parini, che conferivano con il mio amatissimo professore Ernesto Squinobal, che li ascoltava addolorato e mormorava: «Mi falciano il fiore della classe». E a mio padre che gli chiedeva come fare perché io potessi affrontare gli esami, ormai prossimi, rispondeva che ci avrebbe pensato lui: «Come se ci incontrassimo per strada, di ritorno dal mercato, e invece di parlare del prezzo della verdura e della frutta, parleremo di italiano, di latino, di storia e geografia». Per sua volontà inoltre, i banchi degli espulsi – di Carlo Maino, anche lui figlio di un matrimonio misto, di Brock, cittadino cecoslovacco, e mio – non poterono essere occupati da nessuno sino alla fine dell’anno. E poiché io ero il più bravo in italiano, Squinobal, che aveva abitudine di dar lettura ogni settimana dello svolgimento migliore del tema assegnato, così continuò a fare, premettendo: «Anche questa volta il tema migliore è stato quello di Finzi, ne do lettura». E di fronte a lui sedeva il nipote del fanatico giornalista fascista Appelius, fanatico fascista anche il nipote.
Maino e Brock non ci sono più, come non ci sono più Edoardo Ceva ed Eugenio Garimberti, miei fraterni compagni. A testimoniare resto solo io, ma posso assicurare che racconto il vero.
Bruno Finzi
Le donne andavano a veder fucilare i fascisti
Nel 1945 avevo otto anni. Mi ricordo un amico che mi disse: «Mio papà fa il sbianchino però anche il partigiano, e ci è andato addosso ai fascisti con la moto». Alla Borletti avevano issato le bandiere rosse. Chiesi perché non quelle italiane e mi zittirono con un calcio. A «las cinco de la tarde» le donne del popolo si vestivano di rosso e andavano alla Borletti a vedere fucilare, tutti i giorni, i fascisti. Davanti alla mia scuola, in piazza Sicilia, i partigiani hanno messo al muro un ingegnere, che ha chiesto di fumare l’ultima sigaretta. In piazza Po è arrivato un fascista in divisa, che ha fatto resistenza. I partigiani gli hanno sparato e mandato un bambino a prendergli le scarpe. I partigiani hanno portato anche il pane con un camion: grande delusione perché era fatto con la meliga, il granoturco.
Giancarlo Buzio
Mio zio Primo Levi
I Formiggini abitavano a Bologna e il padre di mio cognato Franco produceva lambrusco. Le leggi razziali rendono difficile la loro vita, ma hanno dei mezzi. Un giorno alcuni soldati italiani reduci dalla campagna di Russia offrono al padre di Franco degli argenti che provengono dall’est Europa, ed egli scopre che sono oggetti ebraici, e decide che comunque staranno meglio in una casa ebraica che fusi o dispersi. Quindi li seppellisce in giardino, prima di fuggire.
All’arrivo dei tedeschi, quando i Formiggini erano già sfollati da Bologna e avevano sistemato presso dei contadini amici la nonna molto anziana sotto falso nome, iniziarono il loro viaggio in treno verso la Svizzera. Erano papà, mamma e Franco di pochi anni. Lasciarono la casa di notte e presero il treno, ma nel viaggio vennero segnalati varie volte a causa della fasciatura al dito infetto della mamma. Si fermarono in un albergo la notte prima di varcare clandestinamente la frontiera con la Svizzera e, poche ore dopo, i tedeschi entrarono in albergo per catturarli.
Quando vennero emanate le leggi razziali molti non li avevano più salutati, come per esempio i compagni del liceo classico di mia mamma a Torino, che attraversavano la strada pur di non incontrarla. Altri tuttavia dimostrarono di essere uomini: mio padre venne obbligato a passeggiare per via Italia a Biella a braccetto con un amico, perché l’amico voleva dimostrare ai biellesi che nulla era cambiato.
I racconti dei miei genitori parlavano di fame e non si trattava di campi di sterminio: mio padre in Svizzera mangiava le bucce di patate che trovava, mia mamma invece sopravviveva con una «schiscetta» di ravioli vegetali in brodo e la sua merenda erano i frutti del carrubo che di solito si danno agli asini. Non dimentico poi mio zio Primo Levi, che assaggiava tutte le cortecce o erbe quando si andava a passeggiare nei boschi molti anni dopo…
Anna Treves Cohen
Papà tornò a casa per ultimo
A settembre del ’45 mio papà Carlo Asola, Italian Cooperator addetto all’approvvigionamento di materiale sanitario, tornò alla sua casa di Alba. Nessuno lo aspettava. La mamma, Pierina, indicando il mobilio ridotto all’essenziale, raccontò che per riscaldarsi avevano sacrificato quattro sedie del Settecento e l’armadio camolato della camera-granaio di Neive.
Carlo domandò dei fratelli: «Partigiani, sono stati» rispose mamma. «Persino Renzo, staffetta a quattordici anni. Su quella salita Renzo, con il suo faccino d’angelo, portava dispacci e merci fra Alba e Neive. Un giorno gli toccò caricare un morto su un carretto. Nascose il cadavere sotto uno strato di fieno; dall’altra parte del carro dispose del letame per confondere il fiuto dei cani. Pochi metri dopo vide un contadino sul lato opposto della strada che gli indicava la parte posteriore del carro. La piccola staffetta guardò. Da sotto il fieno, spuntavano i piedi del morto, su fin sopra la caviglia; Renzo, vincendo la ripugnanza, lo risospinse sotto il cumulo di fieno.»
Carlo pensò a come la guerra avesse frantumato la famiglia spargendola fra Africa, Francia, Alba e le colline circostanti, mentre il papà lavorava fuori Italia e la mamma e il fratellino minore tiravano avanti in Alba con una botteguccia di generi alimentari. «E Cornelio?» domandò pensando al suo amico, figlio del maestro, che sapeva arruolato nei carabinieri. «Cornelio è stato in Istria, a Parenzo, dove è stato catturato dai tedeschi l’8 settembre, e spedito dritto a Mauthausen. Ma poi, quando tornò per miracolo dal campo di concentramento» disse Pierina «Cornelio passò prima da casa nostra.»
Avevano tutti fatto ritorno. Anche il suo amico, prima di lui.
Teresio Asola
Ennio, in divisa a 14 anni contro i nazisti
Il trenino del dopolavoro è per i bambini buoni. Per Ennio, no. Al figlio di Panfilo – reo di aver aderito a uno sciopero – niente diploma di primo classificato e premio in denaro nella gara ciclistica. Non è opportuno che i bravi ragazzi del regime giochino col figlio del socialista.
Dopo l’8 settembre, la campagna è invasa da migliaia di fuggiaschi usciti dal campo di concentramento di Fonte d’Amore; Ennio ne raccoglie tre e li porta a casa. Panfilo si mette in contatto con le organizzazioni patriottiche locali e li aiuta a mettersi in salvo.
Nei vicoli del Borghetto si sentono le cantilene dei bambini che piagnucolano: «Ho fame». La sentinella del forno tedesco è metodica: fa sempre lo stesso numero di passi; il tempo per rubare una pagnotta, mentre è di spalle, dovrebbe bastare. Ennio ci prova, ma un passante fa la spia e la fuga viene accompagnata da colpi di fucile. La pagnotta sarà divisa con le sorelline affamate. Sorpreso, un giorno, con un sacchetto di carbone, viene accompagnato al comando, schiaffeggiato e abbandonato tumefatto e sanguinante prima di essere liberato.
Panfilo si infortuna lavorando, peggiora e abbandona la madre terra. Ennio, ancora coi calzoni corti, si scopre capofamiglia. Si industria come può. Non s’intende di politica, ma non ha digerito i risultati dell’armistizio. Cresciuto nel culto delle armi, dell’Italia imperiale e del re soldato, vede i giganti della sua fantasia dissolversi come neve al sole. L’Italia è allo sbando e in mano ai nemici.
L’inverno 1943-44 passa nell’attesa degli Alleati. Finalmente, a giugno i tedeschi si ritirano e arriva un gruppo di personaggi armati e vestiti alla meno peggio. Non sono i tanto attesi liberatori, ma le avanguardie della Banda Maiella che, per rifiuto a prestare giuramento al re, opera nell’organico dell’ottava armata britannica. A Sulmona la banda viene sciolta, ricostituita e aggregata alle truppe del 2° corpo polacco. Dopo la liberazione d’Abruzzo, si sposta nelle Marche. Ennio fugge da casa con un amico e si presenta a Recanati per essere arruolato. Non ha l’età, ma mentendo e contando sulla sua prestanza fisica riesce a farsi accettare quale diciassettenne. Raggiunto dalla madre per essere ricondotto a casa, si rifiuta categoricamente. Ancora oggi si commuove, al ricordo di quell’incontro.
Dopo un addestramento sommario, la prima notte di guardia è la notte del pianto, ma decide di «essere uomo». Se può essere considerato adulto per venire schiaffeggiato dai tedeschi, deve essere adulto per combatterli. In seguito, viene scoperta la sua vera età e viene adibito a servizi lontani dalla linea del fuoco. Accompagnerà la brigata (già «Banda») fino al suo scioglimento. Si arruola nell’Arma dei Carabinieri, ma deve nascondere il suo passato partigiano: i «banditi della Libertà» non sono particolarmente amati fra i «regolari».
Verrà poi il momento di emigrare...