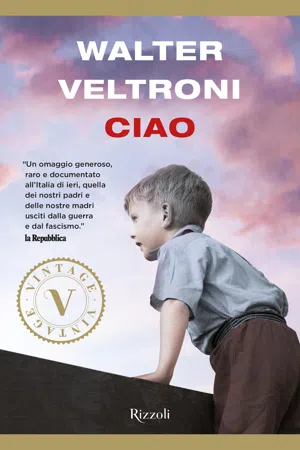![]()
1
Il giorno di ferragosto Roma è sempre meravigliosa. È silenziosa, stanca, vuota. Il tempo è dilatato, un minuto ci mette un’ora a passare. I vecchi si trascinano verso un’ombra, cercando un po’ di compagnia. I negozi sono chiusi, ancor più di quanto lo siano nel resto dell’anno, dall’inizio della recessione, quella che non finisce mai.
Quando ero bambino la città si mostrava così quasi tutta l’estate e ogni anno «Il Messaggero» pubblicava la stessa foto: via del Corso deserta, da piazza Venezia a piazza del Popolo. Nemmeno il titolo dell’articolo cambiava, Il grande esodo. E i romani che leggevano il giornale in spiaggia, tra bambini urlanti e palloni che gli piombavano addosso, provavano una certa inspiegabile nostalgia.
Le cose sono cambiate. Folle di turisti, sbarcati da voli a basso prezzo, trasbordano le loro anime e i loro zaini su e giù per il centro e «Il Messaggero» ha smesso di pubblicare quell’immagine, che ormai potremmo vedere solo grazie a Photoshop.
Eppure oggi il Parco dei Daini, che per me, e forse solo per me, è il cuore di Villa Borghese, sembra via del Corso nel 1965. Non c’è anima viva, adesso che il pomeriggio sta per finire.
Ci sono arrivato quasi senza accorgermene. Rimasto a Roma per scrivere un romanzo da consegnare per tempo, ho lavorato tutto il giorno. La famiglia in vacanza, la casa vuota. Di ogni cosa, cibo compreso.
Gli uomini lasciati da soli, o forse io in particolare, sono una catastrofe. Stracchino, prosciutto, dolci confezionati, meglio se facili da scartare. Al massimo una botta di alta cucina con i “Quattro salti in padella”, un primo surgelato da preparare in pochi minuti. L’occhio in queste situazioni deve sempre andare alla data di scadenza stampata sulle buste dei cibi reperiti nel frigorifero. Può capitare altrimenti di mangiare uova di quando c’era Fanfani al governo. E di trovarle buone.
Cammino per questi viali alberati che conosco a memoria. Il Parco dei Daini è una enclave nell’incantevole sistema di Villa Borghese. Il più bel parco del mondo, con la sua forma a cuore. L’unico spazio verde dove si possono ammirare, insieme, il Davide con la testa di Golia di Caravaggio, nella Galleria Borghese, Il Giardiniere di Van Gogh, in quella di Arte Moderna, Il Sarcofago degli sposi, al Museo Etrusco di Villa Giulia, e dove si può vedere un capolavoro restaurato alla Casa del Cinema o ascoltare i versi di Shakespeare sotto un cielo di stelle al Globe Theatre. E poi gli animali del Bioparco o i burattini del San Carlino che una mano fatata o semplicemente sensibile ha posto nel viale dei Bambini, e la statua a Franca Florio nella casa di Pietro Canonica o i Cavalli in riva al mare di Giorgio de Chirico al Museo Bilotti.
In quale altro frammento di mondo si può trovare, concentrata, tanta bellezza? E tanta diversità, che della bellezza è garanzia e promessa? Per tacere dei luoghi naturali: il Giardino del Lago, Piazza di Siena, il Pincio, la Valle dei Cani, il Galoppatoio. Il verde, con la sua pace e i suoi suoni, insieme alle emozioni suscitate dal talento degli uomini.
È il paradiso? No, è Villa Borghese.
Ho sessant’anni, secondo i più accreditati exit poll. La notizia mi sorprende, dato che ne ho trenta. Ma in effetti, se osservo i miei giorni, se li sfoglio, nella misura che la memoria mi consente, mi sembra di aver vissuto cento vite e cento tempi storici diversi.
Bambino, ho visto vincere Livio Berruti alle Olimpiadi, guardando lo schermo di un apparecchio che si accendeva con il trasformatore. Sono cresciuto quando intorno a me c’era solo la sensazione di un’estate permanente, in spiaggia si sentiva Abbronzatissima e si mangiava il ghiacciolo Arcobaleno e si prendevano le gomme americane al distributore, tre per una monetina da dieci lire. E c’era la bottiglia di vetro del latte, da riportare lavata, perché il “vuoto” ha un valore, sempre. Ho visto mia madre sorridere felice mentre ci mostrava la Seicento bianca, lucente, con le portiere controvento: l’aveva orgogliosamente acquistata firmando cambiali per cinquecentomila lire, 250 euro di oggi. Nel silenzio della mia stanza di bambino divisa con mio fratello Valerio ho letto i libri di Gianni Rodari, con le copertine rigide e le illustrazioni di Munari, tuffandomi nel suo mondo e imparando una cosa che avrei cercato di portare con me per tutta la vita: non smettere mai di usare la fantasia per immaginare ciò che non c’è e persino ciò che non può esserci.
Volevo essere tra i bambini che inseguivano il pallone nella sigla di I racconti di padre Brown, ho ascoltato i consigli di fede di Padre Mariano, che vedevo passeggiare silenzioso al Parco dei Daini, con la sua lunga e francescana barba; ho provato le mie prime pulsioni innamorandomi di Virna Lisi e di Georgia Moll a Carosello e di Nancy Sinatra sentendola cantare Like I Do. Ho pianto a veder morire Laura Efrikian in David Copperfield e mi sono straziato per la sorte del mio coetaneo Andrea in Incompreso, libro e film. Ho perso un prezioso bottone di pelle del mio cappotto nella calca di spettatori in attesa febbrile davanti alla porta di vetro serrata del cinema Radio City, che aveva sede dove oggi è il Ministero dell’Economia, nel quale veniva proiettato 007 – Missione Goldfinger. Ho fatto la fila alla Rinascente insieme ad altri adolescenti per ascoltare da strani telefoni la musica di 45 giri che forse avrei comprato, come With a Girl Like You dei Troggs o Waterloo Sunset dei Kinks. Ho frequentato le lezioni di catechismo oppresso dal senso di colpa solo perché mi piaceva da morire una ragazzina dello stesso corso.
Ho comprato regolarmente «Giovani» e «Ciao Ragazzi» in edicola e ho sbirciato, sulla copertina di «Playmen», Brigitte Bardot nuda, a parte una collana che le copriva i capezzoli. Ho letto mille giornali quando Luigi Tenco si è suicidato e non riuscivo a spiegarmi perché anche le persone belle, intelligenti, famose provassero dolore.
Ero al teatro Sistina quando i Giganti stravinsero contro Claudio Villa in un match di popolarità tra giovani organizzato per lanciare una nuova rivista.
Il giornale si chiamava «Dopodomani» e infatti chiuse al secondo numero.
Al Brancaccio ascoltai rapito una conferenza di Herbert Marcuse, ma non capii nulla. Mi piacque di più, nello stesso luogo, un concerto dei Jethro Tull con Ian Anderson che suonava Bourée. A Bandiera gialla ho votato per Donovan contro i Canned Heat, che mi sembravano troppo duri. Ho ballato A Whiter Shade of Pale stretto alla figlia di un noto parlamentare comunista, sperando che nessuno venisse con la scopa a chiedere il cambio di coppia. Ho visto – e mai lo dimenticherò – Pasolini che prendeva appunti nell’angolo di una sezione del Pci dove ci riunivamo, noi del comitato di base del liceo Tasso, e ho ragione di credere che sia venuto da quelle assurde discussioni di figli della borghesia romana l’incipit della bruciante invettiva dopo gli scontri di Valle Giulia:
Avete facce di figli di papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete paurosi, incerti, disperati
(benissimo!) ma sapete anche come essere
prepotenti, ricattatori e sicuri:
prerogative piccoloborghesi, amici.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti!
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da periferie, contadine o urbane che siano.
Ho fatto collette per il Vietnam, ho pianto per i miei coetanei chiusi nello stadio di Santiago, ho protestato, con Pasolini, per un ragazzo garrotato dalla Spagna di Franco. Non ho manifestato in solidarietà di Jan Palach, come avrei dovuto fare ascoltando il mio cuore ragazzo. Ho odiato Breznev e amato Kennedy e questo mi sembrava normale, entrando nel Pci di Berlinguer. A tredici anni, uscito da scuola, corsi verso casa con in mano l’edizione straordinaria di «Paese Sera» quando Bobby fu ucciso. Avevo voglia di dividere con qualcuno, subito, il mio dolore stupito, ma non c’era nessuno.
Ho riso quando Paolo Villaggio scendeva a precipizio le scale promettendo cammellini di peluche, ho fatto una domanda a Ornella Vanoni una volta che ero tra il pubblico a Speciale per voi. Domanda fessa e cuore a mille. Durante la proiezione di Fragole e sangue o di Sacco e Vanzetti al Nuovo Olimpia ho scandito slogan politici insieme ad altri ragazzi come me, stesso eskimo e stessi pantaloni di velluto. Sono stato al Palazzo dello Sport a vedere l’Orlando Furioso con Edmonda Aldini rossa e altera. Mi sono annoiato tanto, ma ero ragazzo. E non stava bene dirlo.
Una sera, sempre al Palasport, sentii un concerto dei Rolling Stones, anche bello, nonostante fossi beatlesiano, corrente McCartney. Ma alla fine la metropolitana era chiusa, avevo perso gli amici, e allora feci l’autostop. Si fermò un signore che mi face salire e dopo poco mi toccò una gamba, una gamba di quattordicenne. Mi gelai, fu gentile, mi fece subito scendere sulla Cristoforo Colombo. Tornai a casa a piedi e non ne parlai mai con nessuno. Capii che il mondo, ad andare avanti, era più complicato di quanto sembrasse.
Ero malato il giorno in cui scoppiò la bomba a piazza Fontana e la febbre mi salì per la paura. La stessa che avevo provato quando due fratelli romani, due come Valerio e io, erano stati uccisi in via Gatteschi, poco lontano da casa. «Dove arriveremo…» sussurrò mia madre, guardando sul giornale i volti dei fratelli Menegazzo. Organizzavo assemblee a scuola e leggevo tanto, in modo confuso. Divoravo saggi e romanzi, sottolineando gli uni e gli altri, come se dovessi fare rifornimento per un lungo viaggio.
Provai sinceramente a leggere Lenin, edizione economica di Stato e rivoluzione acquistata alla libreria Feltrinelli di via del Babuino. Ma mi arenai presto, preferendogli Billy Bis. Amai i libri di Cassola e quelli di Vittorini, di Pavese e della Ginzburg. E, tanto, la letteratura e il cinema sudamericano, da García Márquez a Manuel Scorza. Vidi e rividi Antonio Das Mortes di Glauber Rocha, ogni volta convincendomi di averlo capito. Impazzii per Il giovane Holden mentre mi respinse Sulla strada, troppo alternativo per un ragazzo di buone maniere come me.
A pranzo, tornato da scuola, appoggiavo ai bicchieri l’edizione economica Sansoni del Dizionario dei film di Sadoul e compulsavo febbrilmente la filmografia dei miei autori preferiti.
Non era maleducazione, ero solo. Mia madre era al lavoro, Valerio chissà dove. Mi facevano compagnia Frank Capra e Charlie Chaplin, mentre mangiavo le cotolette panate.
Ero stato nel mio tempo, come allora era inevitabile. Esiste un esperanto, fatto di film, di musica, di programmi televisivi, di cortei e di rabbie, che unisce chi ha vissuto, giovane, quella stagione. Siamo stati la prima generazione dei tempi di pace, che disponeva, in tutto il mondo, di codici comuni, perché universali. Insomma così volò il “caro tempo giovanil”, che però mi sembra ieri e non un puntino lontano.
Molto di quel tempo l’ho passato qui, al Parco dei Daini. Da bambino ci venivo tutti i giorni, se non pioveva.
Il pallone, un Super Santos arancione, era messo nella stessa retina in cui venivano stipati i cibi della spesa, con totale incuranza della differenza.
Per arrivare a Villa Borghese facevo sempre la stessa strada, la prima abitudine della mia vita. Percorrevo via Isonzo, dove c’era il barbiere di famiglia. Il proprietario Emilio, un tipo alla Pedro Armendáriz o alla Fred Buscaglione, aveva aperto la bottega negli anni Quaranta. Un quadro molto colorato sul muro di fronte alla sua postazione di lavoro, naturalmente la più in vista del negozio, lo ritraeva insieme al suo socio Franco. Sorridevano entrambi davanti al locale, alle spalle una di quelle insegne tricolore a spirale che allora segnalavano, in modo indiscutibile, la presenza di un “Salone per barba e capelli”. Lì erano andati mio nonno e mio padre. Lì andai anch’io appena ebbi l’età ed Emilio, che intanto si era dolorosamente separato da Franco, mi faceva sedere su due cuscini e poi, cresciuto, su uno solo, per farmi stare alto il giusto. Le prime volte mi cingeva la testa con una specie di salvagente a forma di paperella, per evitare che acqua e shampoo mi andassero negli occhi.
Passavo poi per via Tevere, dove c’era la concessionaria Fiat il cui responsabile era il padre di un mio compagno di classe. Così ebbi il privilegio di vedere per primo, appena arrivata in negozio, l’attesissima 850 dal terribile azzurrino, che costituì per lungo tempo il sogno proibito della famiglia Veltroni.
Sfioravo, per un breve tratto, la mia scuola di allora, la Grazioli Lante della Rovere, dove avevo visto il primo film della mia vita: Toby Tyler. Doveva essere il 1961 e, mentre tutti i miei compagni facevano un gran casino e si menavano, io ero l’unico con gli occhi fissi al piccolo schermo sul quale scorrevano, incerte, le immagini dell’otto millimetri proiettate da un bidello affetto da terribile miopia. Era il cinema, la più potente macchina per la fantasia, che scoprivo isolandomi da quella cagnara.
Provai un’emozione inedita che si sarebbe ripetuta migliaia di volte: le persone erano più grandi di me, sullo schermo. Da bambino in fondo era normale, tutto lo era. Ma proprio per questo quell’incanto rimane sempre e anzi si rafforza: le persone proiettate dal fascio di luce non smettono di essere tanto grandi da farti sentire piccolo, per tutta la vita. È il cinema, che prolunga l’infanzia.
Toby Tyler racconta l’avventura di un orfanello che scappa dalla casa degli zii e trova pace e serenità in un circo. Il primo film della mia vita era stato, così, la storia di un bambino orfano. Forse per questo, nel baccano dei miei amici, io ero attratto, quasi magneticamente, da quel personaggio. Parlava di me, quella favola.
Proseguendo per via Tevere passavo davanti a un palazzo che di lì a poco sarebbe divenuto motivo d’orgoglio per l’intero quartiere. ...