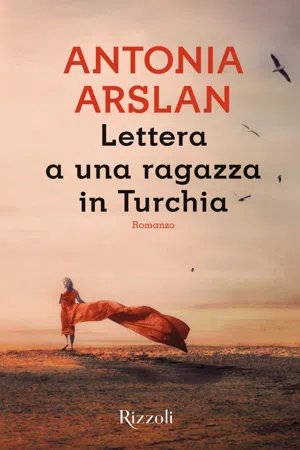![]()
Iskuhi e Khayel
Correva l’anno di grazia 1862. Michael Arslanian, fervido di voglia di vivere e di mille curiosità, ma con qualche timidezza da provinciale, arriva nella grande città, la Bolis delle fantasie di ogni armeno, la splendida Costantinopoli. Ha vent’anni, abbastanza soldi in tasca per passare qualche mese da bohémien, folti capelli neri e intensi occhi marroni, e vuole diventare avvocato. Ha il passo veloce del ragazzo che è ancora. La scuola di legge della capitale lo attira, e ancora di più la possibilità di entrare in contatto con gli amirà, gli armeni che contano, quelli di successo, che hanno palazzi e carrozze e vivono sfarzosamente, all’occidentale, gestiscono il patriarcato e sono vicini al sultano.
Tutti sanno che gli architetti della corte sono per diritto ereditario i Balian, di generazione in generazione; tutti sanno – anche nella lontana Kharpert, dove lui è nato – che molti pascià e ministri appartengono al popolo armeno, di cui il sultano si fida molto. La loro è la sadyka millet, la nazione fedele: fra tutte le minoranze che abitano il variegato impero ottomano, sono sempre stati gli armeni quelli meno inclini a complottare e a tradire, quelli che non sognano l’indipendenza.
Ma c’è un grande distacco fra la maggioranza che vive nelle regioni orientali, dove sono quasi tutti contadini e pastori, e la minoranza aristocratica, mercantile e faccendiera della capitale, spesso troppo coinvolta nei suoi affari e nelle alte frequentazioni per ricordarsi dei fratelli anatolici meno fortunati e delle condizioni disagiate o addirittura primitive in cui spesso sono ridotti a vivere. Michael – che tutti chiamano familiarmente Khayel – è nato però da una famiglia agiata, ha studiato con passione e profitto, è serio e furbo. Vuole inserirsi nella crema della capitale, vuole imparare e diventare qualcuno, anche se il suo vero scopo è di essere primo nella sua città, non uno fra molti a Bolis.
Perché a Kharpert non ci sono solo paesani. È il luogo di un’antica fortezza (e infatti così si chiama la città vecchia arrampicata in collina), ma oggi – insieme alla cittadina gemella di Meziré, sorta nella zona pianeggiante, dove ci sono gli uffici amministrativi del vilayet – è una città colta e industriosa, celebre per lo splendore delle sue pianure, le famose golden plains, e l’abbondanza dei raccolti, dove si coltiva di tutto e molto si esporta. È nota anche per i numerosi paesi e villaggi abitati completamente da armeni sparsi nel territorio e per l’eccellente livello culturale dei suoi istituti scolastici, come il famoso Euphrates College, il Collegio Francese e le moltissime scuole elementari, che sorgono dappertutto vicino alle chiese. Eppure molti soffrono, la convivenza coi turchi è difficile, qualche volta i curdi scendono dalle loro montagne e si prendono un vitello, sacchi di grano, una donna... Khayel vuole fare qualcosa per il suo popolo, ma ancora non sa esattamente in che direzione muoversi: il suo cuore vorrebbe aiutare tutti, ma l’acuta percezione della realtà e un’innata prudenza gli suggeriscono di guardare, imparare e aspettare, come gli ha sempre suggerito la saggezza popolare di mamma Arshaluys.
La vedova da cui ha affittato due stanze gli è stata raccomandata da uno dei padri cappuccini del Collegio Francese di Meziré, dove sta la sua famiglia. Nei primi giorni è andato a iscriversi alla scuola di Diritto e si è comprato dei libri di studio. Ma per il momento li ha solo spolverati e ricoperti di una bella carta traslucida che ha trovato dal vecchio libraio armeno del Patriarcato, insieme a grandi etichette fiorite di arabeschi, sulle quali ha tracciato i titoli in perfetta calligrafia. Il giorno dopo ha cominciato a sfogliarli, perplesso e intimidito, senza nessuna voglia di cominciare a leggerli. Ci sarà tempo, pensa; e intanto annusa il profumo della salsa di peperoni della vedova Julita e guarda noncurante i fianchi rotondi della figlia di lei, che gira per le stanze cercando di suscitare la sua attenzione. Poi si siede in terrazza a fumare, con aria disinvolta: ma rimpiange le sgridate della madre, il cinguettio delle sorelline, l’odore di casa, e quasi vorrebbe non essersene andato.
Dura poco però questo umore fra il riservato e il meditabondo. Un paio di visite al caffè dei greci dirimpetto, una partita di tavlì in cui è entrato quasi per caso, per sostituire un ragazzotto evidentemente sprovveduto che non sapeva proprio giocare, un invito a casa del vecchio signore che ha lasciato vincere... La squisita ospitalità della moglie, le chiacchiere: dopo un po’ si sono ritrovati quasi parenti, e sono seguite nuove occasioni. E poi ha conosciuto altri studenti appena arrivati in città, e ha fatto amicizia – e sarà un sodalizio che durerà una vita – con un ragazzo pallido di Hussenig (un altro villaggio della piana di Kharpert), l’orgoglioso, intelligente, permalosissimo figlio di una sarta a giornata, vedova da molti anni. Bedros Azarian diventerà la sua ombra fedele, il suo fratello d’anima, la persona con la quale fino alla vecchiaia condividerà ogni moto del cuore, ogni scelta, ogni turbamento. L’unico da cui si lascerà prendere in giro, ricambiandolo; e Yerwant, il figlio maggiore, colui che a tredici anni se ne andrà per sempre in Italia, solo con Bedros manterrà corrispondenza, e da lui avrà notizie di casa, nei lunghi anni di lontananza.
È facile avere vent’anni nella grande città. È facile anche perdercisi, smarrirsi nel vuoto affollato di sconosciuti, lasciarsi convincere da un abile discorso, da un sorriso furtivo. Khayel scopre i giornali scritti in armeno, nel fluente linguaggio moderno che è molto diverso dall’armonioso krapar della liturgia antica, è pieno di idee nuove e parole nuove, espressioni fresche ed efficaci, derivate dal francese, dal turco, dal persiano. Tutta la comunità si sta svegliando dal suo lungo secolare letargo. L’indipendenza della Grecia è diventata un mito, tutti ne parlano, tutti ammirano il risultato di quella impari lotta fra quel miserabile pugno d’uomini – i palikari delle montagne e i marinai corsari delle isole – e il potente impero ottomano: molto più che Davide e Golia, nell’infiammata immaginazione armena.
Ma quello che più impressiona è il fatto che per la prima volta l’impero ha ceduto. Il trattato di Adrianopoli del 1829 ha segnato nelle loro menti eccitate l’inaspettato spartiacque dopo il quale tutto diventa possibile: anche sognare l’indipendenza per l’Armenia, anche rifondare la loro nazione intorno al monte Ararat, come negli antichi tempi. Fioriscono i racconti epici, le gesta degli eroi vengono descritte nei toni di una sublime epopea romantica, si ricorda con ammirazione il coraggioso Gregorio V, patriarca greco di Costantinopoli, impiccato come traditore all’inizio dell’insurrezione, mentre contemporaneamente il gran dragomanno Konstantinos Mourouzis veniva decapitato.
È a questo punto che si insinua nella mente degli armeni un sogno, una speranza che presto si tramuterà in certezza: la convinzione che le potenze che sono intervenute militarmente per dare la libertà ai greci faranno lo stesso per gli armeni. Francia, Inghilterra e Russia si sono alleate, credono gli ingenui idealisti, in nome della libertà, quella stessa libertà dei popoli che hanno invocato per abbattere il dominio napoleonico. Basterà svegliarsi, insorgere, mandare uomini fidati nelle capitali europee: il giogo del turco pesa sugli armeni da secoli, il diritto alla terra patria vale anche per loro.
Ma è una certezza che posa su scivolose basi di sabbia, che si incarna in un pensiero desiderante che non ha molto riscontro nella realtà di un popolo che vive sottomesso da secoli, e in fondo non desidera altro che sopravvivere in pace, pagare tasse eque, limitare il potere assoluto del sultano e la corruzione endemica della burocrazia ottomana.
“Noi dobbiamo aiutarlo a riscoprire se stesso. A far rinascere la nostra antica cultura” pensa Khayel, “la grande stagione del luminoso Medioevo, con le sue smaltate miniature, i suoi mistici, i monasteri grandiosi sulle vie della seta, pieni di virtuosi copisti, pittori, scultori, studiosi, mercanti. E farlo vivere meglio, costruire ospedali e case per gli anziani, e scuole. Soprattutto scuole.”
Ai suoi occhi infiammati di gioventù e di passione, ma anche eredi di una lunga pratica mercantile, appare tuttavia sempre più chiaro che l’unica vera attività politica, la vera via di salvezza per gli armeni, più che nei vani sogni di insurrezioni consiste nel rinforzare quel legame fra passato e presente che è il retaggio più prezioso dell’antica patria perduta: la croce, l’alfabeto, la lingua.
Consiste “nel renderci orgogliosi di ciò che fummo, pensando a ciò che saremo”, come dice la frase di Kazaz Artin Amirà che ha fatto sua e che ripete sempre («bella, ma purtroppo dimentica l’oscuro presente» commenterà amaro suo figlio Yerwant, tanti anni dopo). Kazaz Artin è un mito per tutti gli armeni: è uno dei pionieri dello Zartonk, il Risveglio, e il fondatore dell’ospedale di Surp Prghiç (il Santo Salvatore) nel 1834.
Funziona da alcuni anni, l’ospedale armeno, quando Khayel arriva a Bolis, e ha successo. È un segno importante di modernità e di rinnovamento civile, ma non è certo l’unico: tutta la comunità è in fermento. Propone, inventa, realizza. Ai potenti greci del Fanar, malvisti e sospetti dopo la conclusione della guerra per l’indipendenza, nella fiducia del sultano si sono sostituiti gli amirà armeni. Sono ricchi e abili, intrecciano rispettose amicizie coi notabili musulmani, non sfidano la potenza ottomana, anzi la sostengono; e una delle più ambite ricompense è per loro la concessione – assai rara – di vestirsi alla turca, cioè di portare gli abiti dei dominatori. Simon Dadyan, capo dell’Imperiale Fabbrica delle Armi, è uno di questi, e si misura alla pari con il celebre Garabed Balian, l’architetto di corte, il più noto della famosa dinastia di costruttori del sovrano.
Si sente un po’ provinciale, Khayel, rispetto a questi personaggi; ma tuttavia è convinto di essere in grado di assorbire da loro la difficile arte del gestirsi in una società così rigida: assumere la veste e l’apparenza del sottomesso e, sotto la superficie, rivelare le capacità del dominatore, diventare indispensabile, conoscere tutta la macchina del potere. Vuole conoscerli, vuole farsi conoscere.
Tuttavia non si sente ancora pronto ad affrontare quel mondo. Nei primi mesi, mentre impara ogni angolo della città e la percorre in lunghe camminate, meditando sui nostalgici resti del suo passato bizantino, mangiando nei chioschi e bevendo acqua colorata dagli acquaioli, Khayel è felice. Ammira le belle donne vestite all’orientale e spia arrossendo eccitato le occidentali disinvolte avvolte nelle loro sete aderenti: ma non ha ancora acquistato né sicurezza né uso di mondo. E la sua mente si ingarbuglia.
C’è una ragazza che si affaccia alla finestra ogni volta che lui esce di casa. C’è una fontana antica che dispensa la sua acqua nella rientranza del palazzo genovese nel quartiere di Pera dove lei abita, al pianterreno. C’è anche una panca di pietra levigata dall’uso di centinaia di anni, dove le donne sostano dopo aver riempito le loro brocche, e una cortina di capelvenere sporca e stracciata che pende sopra la fonte. Nella vasca piena d’acqua torbida, sotto, si vedono i ciottoli lisci che i bambini ci buttano dentro nelle ore calde, quando non c’è nessuno intorno. E poi, quando sono stanchi di tirare pietre, ci mettono i piedi dentro, tutti insieme, sciaguattando. È allora che Bedros Shugarian lo sciancato tira fuori la pagnotta di sua madre fornaia e la divide solennemente fra tutti. «È mezzogiorno, l’ora di Dio» dice la vecchia Rakel l’ebrea, a cui tocca l’ultimo pezzetto, che lei bacia con fervore prima di mandarlo giù.
Qualche volta si ferma là anche Khayel, di ritorno da una delle sue cam...