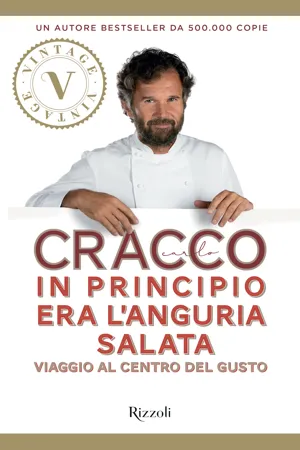![]()
1
De gustibus
Partiamo dalla domanda delle domande: che cosa vuol dire mangiare? È un’azione che si ripete così tante volte nel corso delle nostre giornate che forse non ci facciamo neanche più caso. Di sicuro è la soddisfazione di un bisogno primario ed è un momento che ci accomuna tutti. Cambiano le situazioni, le abitudini, gli ingredienti e le quantità, ma tutti mangiamo. Secondo me però c’è anche qualcosa di più, perché mangiando noi siamo attraversati da un’infinità di sensazioni e di stimoli. Nel cibo ritroviamo colori, forme, profumi, consistenze, sapori e suoni, che si mescolano e si intrecciano, e diventano parte della nostra storia.
Allora credo che un po’ ci faccia bene ricordarlo: mangiare non è solo mettere in bocca qualcosa, ma è un viaggio fantastico che comincia dai sensi. E a dire il vero questo viaggio prende il via ancor prima di mangiare, perché un ingrediente all’inizio lo vediamo e lo annusiamo, poi lo ascoltiamo e lo tocchiamo. In poche parole: lo avviciniamo, lo corteggiamo, cerchiamo di capirlo per poterlo preparare al meglio e poi alla fine lo assaggiamo. In questo i sensi sono il nostro punto di riferimento, e lo sono da subito.
Guarda guarda…
L’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un vapore carico di aromi, si scorgevano poi i fegatini di pollo, gli ovetti duri, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi impigliate nella massa untuosa, caldissima dei maccheroncini corti cui l’estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo
Ogni banchetto, pranzo o cena che sia, comincia sempre con uno spettacolo per gli occhi. Ciò che vediamo è come una porta socchiusa: se quello che c’è sul piatto ci convince, la porta si apre e ci invita a entrare, viceversa, se c’è qualcosa che non torna, il passaggio si stringe – o addirittura si chiude – e bisognerà capire come andare avanti. In ogni caso la vista è fondamentale perché, se da un lato ci condiziona, dall’altro ci guida e ci permette di orientarci.
Immaginiamo di essere seduti a tavola e di venire serviti. Che cosa vediamo?
La prima cosa che ci arriva, forte e chiara, è il colpo d’occhio generale, per cui il nostro sguardo si ferma subito sul piatto e va a controllare come le pietanze sono presentate, ragionando su quello che tecnicamente corrisponde all’impiattamento. Qui vorrei fare una piccola premessa, perché “impiattamento” è una parola entrata nel nostro vocabolario in tempi piuttosto recenti, sollevando un bel po’ di polverone. Impiattamento sì, impiattamento no… A qualcuno questo termine fa storcere il naso, qualcun altro lo usa invece senza farsi problemi. Lo sapete? In merito si è espressa anche l’Accademia della Crusca, che alla fine ha riconosciuto la validità e la correttezza di questo modo di dire. Certo, fuori e dentro il web c’è chi propone delle alternative, dei sinonimi che pure vanno bene. Per esempio “comporre il piatto”, un’espressione forse più elegante. Meno specifica, ma più raffinata. Noi sicuramente useremo “comporre” ma anche “impiattare” perché, nei limiti della correttezza, la lingua – come la cucina – è fatta di libertà e di gusto personale.
Dicevamo quindi dell’impiattamento. Quando ci avviciniamo al cibo, questo è il nostro primo step, il momento in cui la parte estetica ci arriva con evidenza, direi quasi con prepotenza. Se ci pensiamo, la presentazione degli ingredienti è un po’ un biglietto da visita: è lì che troviamo le prime informazioni su quello che mangeremo, è da lì che cominciamo a capire se quello che abbiamo davanti ci interessa. Non si tratta ancora di decidere se il cibo è buono, ma di interrogarci sul suo aspetto. È questione di pochi secondi e non c’è bisogno di avere chissà quali competenze, perché, se un piatto è messo giù bene, lo capiamo velocemente e lo capiamo prima di tutto con gli occhi.
Perciò – punto numero uno – davanti al cibo andiamo a cercare l’equilibrio, ossia l’armonia di forma, colore, movimento, proporzioni. E allora andiamo a vedere quali colori ci sono nel piatto, se sono bene accostati, se c’è movimento, se la parte della salsa o del condimento è ben integrata alla pietanza, se c’è uno sviluppo orizzontale o verticale, se le forme sono armoniche, se il risultato è elegante, raffinato. Non è detto che l’impressione finale sia sempre di bilanciamento, perché non tutti sanno impiattare, o meglio, non tutti dedicano alla composizione del piatto la stessa cura. Però io credo che questa sia una parte molto profonda e importante del fare cucina. Perché? Perché impiattare non è solo combinare in maniera piacevole colore, forma e taglio degli ingredienti, ma è anche disporli in una rappresentazione coerente, in modo che le singole parti trovino un loro significato nell’insieme. E allora, quando un impiattamento funziona? Quando il piatto “parla”, ossia quando esprime l’intenzione che il cuoco ha avuto nel prepararlo, e questa intenzione è chiara e comprensibile anche a chi mangia.
Ecco dunque – punto numero due – che, quando il cibo è sotto i nostri occhi, dobbiamo essere capaci di vedere se tutto torna. Se per esempio abbiamo ordinato un Carré d’agnello con patate e carciofi, abbiamo delle coordinate importanti, perciò partiamo da quelle. Ci dovremo aspettare l’agnello, che è il protagonista, poi le patate e i carciofi. Occhi bene aperti, quindi, perché se l’agnello è sepolto sotto una montagna di carciofi evidentemente qualcosa non va, non ci vuole molto per capirlo. I carciofi non devono essere predominanti, a partire dalla presentazione. Se sono “troppi” nel piatto, probabilmente saranno “troppi” anche all’assaggio, e il risultato non sarà equilibrato.
Noi allora proviamo a ragionare su quello che potrebbe essere l’impiattamento più corretto.
Tanto per cominciare, quando leggiamo il nome della ricetta non abbiamo ancora visto il piatto. Nel menu abbiamo trovato scritto Carré d’agnello con patate e carciofi, ma il carré è un taglio che può essere preparato in modi diversi e, in base alla via che verrà presa in cucina, il modo di comporre il piatto cambierà. Per esempio, gli ingredienti potranno essere preparati separatamente servendo delle costolette, o potranno essere cotti insieme facendo uno spezzatino. Ci saranno due preparazioni diverse, e due modi differenti di impiattare.
Iniziamo dal procedimento. Se parliamo di costolette, per prima cosa bisogna rosolare a fuoco vivo il carré d’agnello scalzato (cioè il nostro taglio con le ossa pulite) con burro, aglio in camicia e timo, facendo bene attenzione a non lasciar bruciare il burro. Una volta ben dorato, il carré viene passato per 4 minuti in forno caldo a 200 °C. A parte si fanno bollire delle patate novelle in acqua salata, si lasciano raffreddare, si tagliano a rondelle e si condiscono con olio extravergine, sale e menta a julienne. Rimane ora la parte del carciofo, per cui in un’altra padella ancora si scalda un cucchiaio di olio e si salta velocemente a fuoco vivo un carciofo a fette (di solito io prima lo taglio a metà, poi da ogni metà ricavo delle fette sottili). Un pizzico di sale e finalmente è il momento di impiattare. E allora dal carré intero si ricavano delle costolette e si sistemano sul piatto, disponendole a ventaglio. Poi bisogna fare spazio per le verdure, perciò si prendono patate e carciofi e si dispongono tenendo a mente che saranno l’accompagnamento della carne, quindi dovranno starle vicine ma non “addosso”. Si sistemano a fianco delle costolette, senza che si mescolino tra loro. Le verdure dovranno confinare e se vogliamo anche sfiorarsi, ma appena appena, come se fossero due innamorati: sono vicini e tendono uno verso l’altro, ma ognuno conserva la propria… autonomia. Chiaro, no?
In alternativa si può muovere la composizione verso l’alto, sistemando le costine in verticale, la carne a contatto con il piatto e le parti con l’osso appoggiate o incrociate in alto. In questo caso, si andrà a completare l’impiattamento con le verdure a fianco, come visto prima.
Se invece si è optato per lo spezzatino, come ci si può muovere? Si lavorano gli ingredienti tutti insieme, senza accendere il forno, usando solo due pentole e facendo una cottura veloce, che richiede attenzione, perché qui è un po’ più facile sbagliare. Se si sgarra sui tempi, infatti, la carne potrebbe risultare stopposa e difficile da masticare, compromettendo il piatto.
All’inizio bisogna dunque disossare il carré, separando la polpa dall’osso e tagliandola a pezzettoni.
Poi in una padella si rosolano le patate con un po’ di cipolla a julienne (o a fette) e si lasciano sudare per 4-5 minuti. A questo punto si uniscono i carciofi mondati e tagliati in quarti, continuando a cuocere e regolando di sale e di pepe. Nel frattempo si rosola anche la carne, in una pentola a parte con poco olio. Quando è ben dorata, la si trasferisce nella padella delle verdure in cottura, sfumando con un po’ di vino bianco e cuocendo ancora per 4 minuti. Alla fine la carne dovrà risultare morbida e piacevole da passare sotto i denti.
E per impiattare che linea si può seguire? Visto che la carne e le verdure sono state cotte insieme, anche nella composizione del piatto bisognerebbe mantenersi coerenti con questa idea, raggruppando gli ingredienti e dando all’impiattamento uno sviluppo più verticale, con un letto di patate, la carne appoggiata sopra e i carciofi disposti tutto intorno. Un’altra possibilità è creare un fiore, disponendo i carciofi lungo tutta la circonferenza esterna del piatto (in modo che la parte con il gambo sporga leggermente in fuori), e mettendo all’interno di questa corolla verde la carne con le patate. Scegliete voi se mescolare i pezzi di agnello con le patate o se alternarli.
In alternativa è possibile servire direttamente lo spezzatino nella pentola. Qui a dire il vero l’impiattamento un po’ si perde, perché ognuno si serve da sé, e il focus si sposta dal piatto singolo alla convivialità. Ma è anche questa una bella soluzione per vivere la tavola con gioia.
Gli esempi che abbiamo fatto ci aiutano a capire che la composizione del piatto è molto più di un fatto estetico: vorrei dire che è al tempo stesso forma – perché la costoletta è diversa dallo spezzatino –, sostanza – perché davanti agli occhi ritroviamo un oggetto, quindi agnello, patate e carciofi – e significato – perché un impiattamento funziona bene quando rispecchia in maniera coerente un percorso di preparazione. In realtà l’impiattamento inteso così è un concetto molto recente. Una volta era diverso, un tempo si guardava più all’effetto generale della presentazione che non alla composizione del piatto. Nella stagione d’oro dei banchetti c’erano grandi “sculture di cibo” in cui si puntava più sull’effetto di insieme, sul colpo d’occhio scenografico. Dare senso al piatto è qualcosa che è venuto molto dopo.
La presentazione nei banchetti
La stagione d’oro dei banchetti è il momento in cui la presentazione del cibo raggiunge la sua massima espressione. A quest’epoca (tra Cinquecento e Ottocento) l’esperienza della tavola ha un fortissimo aspetto scenografico e celebrativo. Durante le feste e i banchetti c’erano infatti delle grandi pièces a gradoni sulle quali venivano disposte le pietanze, ed erano in genere delle strutture in legno o altro materiale realizzate da un architetto e poi allestite. Nel presentare il cibo si seguiva un ordine crescente, per cui in basso si trovavano le pietanze più semplici e più ordinarie, poi a mano a mano si saliva fino agli ingredienti più pregiati che occupavano la parte alta della piramide.
L’obiettivo era suscitare stupore e meraviglia, e tutto girava intorno alla pièce da cui ci si serviva o si veniva serviti. Una cosa da tenere in considerazione è che a quei tempi si toccava molto di più il cibo, lo si toccava proprio con le mani, per cui questo tipo di presentazione condizionava anche le preparazioni. Secondo voi perché erano tanto in voga i cibi in crosta? Perché mettere la crosta – che poteva essere una pasta di pane, una brisée o una sfoglia – serviva a evitare che il cibo venisse contaminato durante la preparazione o durante il servizio. La crosta aveva una funzione protettiva e infatti di solito non veniva mangiata. Si scartava perché in tanti l’avevano maneggiata e, siccome l’igiene allora era piuttosto approssimativa, la crosta doveva salvaguardare dalle contaminazioni la parte più pregiata delle pietanze, cioè quella che stava al suo interno.
Di sicuro un tempo c’era anche un andamento più verticale nelle presentazioni, mentre oggi ragioniamo su piani orizzontali, per cui impiattare è più simile a dipingere un quadro che non a modellare una scultura.
E se il piatto è un quadro, che cos’altro andiamo ad apprezzare al suo interno? Siamo sempre nel campo d’azione degli occhi, quindi parleremo del colore e della forma.
In cucina il colore è un fatto abbastanza recente, direi che ha preso importanza negli ultimi trent’anni. Prima non c’era interesse a valorizzare l’aspetto cromatico degli alimenti; visivamente era tutto piuttosto piatto e uniforme. Al massimo esistevano delle gamme, per cui l’arrosto era scuro e il bollito chiaro, ma non ci si spingeva molto più in là. Poi si è capito che, prestando un minimo di attenzione al momento della cottura, era possibile conservare i colori originari, soprattutto nel caso delle verdure, che si ossidano facilmente e assumono tinte scure e spente. Ecco allora che, sfruttando il freddo e le cotture brevi, i fagiolini non diventano marroni, i broccoli non prendono quel verde sciupato. Quindi, se dobbiamo trattare le verdure verdi (broccoli, piselli, fagiolini eccetera), possiamo tenere sempre a mente un paio di regole. Prima di tutto andiamo a tuffarle in acqua bollente salata, cuocendole finché non saranno al dente e risulteranno croccanti e consistenti alla masticazione. Naturalmente anche a livello di gusto dovremo assaggiarle e sentire che hanno un bel sapore cotto. A questo punto le scoliamo e le passiamo in un bagno di acqua e ghiaccio, lasciando trascorrere il tempo necessario perché si raffreddino (dovremo proprio toccarle e sentire che sono fredde). Poi le scoliamo, le asciughiamo e le teniamo da parte. Questo trattamento ci permetterà di fissare i colori – che resteranno vivi e brillanti – e di conservare tutte le caratteristiche di sapore, gusto e consistenza delle verdure.
E se dobbiamo preparare gli spinaci? In questo caso dobbiamo avere cura di non lessarli prima e saltarli poi, ma di cuocerli direttamente in padella con una nocciolina di burro e un pizzico di sale. Li facciamo appassire velocemente (contiamo 30 secondi, più o meno) e li serviamo. Ecco, saranno i migliori spinaci che possiamo desiderare, a partire dal colore, che apparirà bello e vivace e ci farà venire l’acquolina in bocca.
Quando invece abbiamo delle verdure rosse, come una cipolla di Tropea o un ravanello, un trucco utile da ricordare è aggiungere un cucchiaio di aceto bianco all’acqua bollente per mantenerne intatto il colore.
Un grande chef come Jean Troisgros, uno dei protagonisti della nouvelle cuisine, dava molta importanza al colore e diceva che in un piatto ci vorrebbe sempre un po’ di verde. Come a significare che la tonalità viva e brillante del verde è il tocco che completa ed esprime al massimo una preparazione, che dice che il piatto va bene ed è completo.
Verde o non verde, la tendenza di oggi è capire l’ingrediente e valorizzarlo, per avere anche a preparazione ultimata un colore che sia il più vicino possibile a quello di partenza. E non è un fatto puramente visivo. Certo, a livello estetico, avere un verde vivo piuttosto che un marroncino poco attraente è meglio, non ci sono dubbi. Ma se l’alimento è di qualità, il colore brillante ci svela qualcos’altro. Può dirci che quel piatto non è solo bello da vedere ma con tutta probabilità è anche buono da mangiare. Perché spesso l’alimento che ha ricevuto una cottura rispettosa ha conservato le sue proprietà nutritive.
Sul colore influisce la cottura ma anche la conservazione. Se potessimo viaggiare nel tempo e ci sedessimo a uno di quei banchetti che hanno reso famosa la corte del Re Sole, ci stupiremmo nel vedere che le grandi pièces erano tendenzialmente tutte marroni, pur racchiudendo al loro interno una grande varietà di ingredienti. Perché? La risposta è abbastanza semplice: perché erano sostanzialmente dei trionfi di carne. E la carne andava per la maggiore a quei tempi, perché era più facile da conservare. Si salava, si marinava o si affumicava, e così assumeva colori anche molto diversi dalle gradazioni di partenza. Poi si rosolava insieme agli altri ingredienti, con il risultato che tutto prendeva una nota uniforme, un marrone… da rosolatura.
Un altro fattore da tenere in mente quando andiamo a ragionare sul colore è la lavorazione della materia prima. Se io vi dovessi chiedere di che colore è la liquirizia, che cosa direste? Che è nera? Be’, noi siamo abituati a pensarla scura, perché così la troviamo nei negozi, ma in realtà quel colore l’ha preso durante la cottura. Prima della trasformazione era una radice, con una bella fibra di colore giallo.
E il caffè? Marrone? Sì e no. È marrone dopo la tostatura, ma i chicchi, quando vengono raccolti, sono verdi.
E ancora il rabarbaro. È rosso o verde? Tutti e due. Il rabarbaro è una famiglia con tante varietà al suo interno ed è in genere verde: verde è la foglia, e verde la quasi totalità del gambo. È rossa la parte bassa, quella più vicina a terra, quella che in cottura rilascia la così bella e pregiata tinta che viene utilizzata come colorante. Però la base è verde. Poi sappiamo che vengono prodotte delle specie coltivate in cui il gambo è tutto rosso, perché quel rosso piace e va alla grande, ma è un’altra storia.
Quando si parla di colore, dunque, è interessante pensare a tutte queste cose, perché la gamma cromatica de...