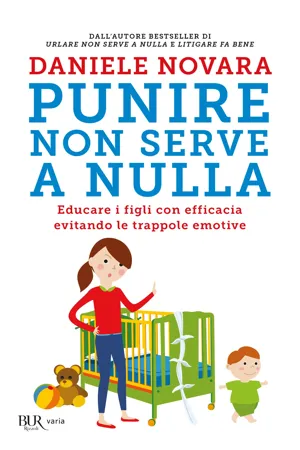![]()
2
SECONDA PARTE
EDUCARE BENE È POSSIBILE
![]()
6
EDUCARE EVITANDO LE TRAPPOLE EMOTIVE
C’era, alla periferia della minuscola città, un vecchio giardino in rovina; nel giardino c’era una vecchia casa, e nella casa abitava Pippi Calzelunghe.
Aveva nove anni e se ne stava lì sola soletta: non aveva né mamma né papà, e in fin dei conti questo non era poi così terribile se si pensa che così nessuno poteva dirle di andare a dormire o propinarle l’olio di fegato di merluzzo quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle.
A. LINDGREN, Pippi Calzelunghe
LA DIFFICOLTÀ A SINTONIZZARSI CON L’ETÀ DEI FIGLI
Trovare un nuovo stile educativo efficace, privo di scontri frontali, dimostrazioni di forza e metodi mortificanti, è possibile.
Da cosa partiamo?1
Prima di tutto è necessario capire con chi abbiamo a che fare.
Le conoscenze che ai nostri giorni abbiamo a disposizione sui processi, anche fisiologici, di crescita e apprendimento dei bambini e dei ragazzi sono enormi. Allo stesso tempo le problematiche nel comprendere l’universo infantile e adolescenziale sono state ampiamente studiate e accomunano tutti gli adulti.
Purtroppo è più semplice capire i figli sul piano della sensazione e della percezione emotiva, piuttosto che nelle loro componenti psicoevolutive, cognitive e di effettiva crescita. È più semplice cogliere la rabbia di un bambino di 2 anni, che i motivi di questa rabbia in relazione alla sua età. È più semplice sentire la paura di crescere di un’adolescente di 13 anni, che accettare questa paura come un passaggio inevitabile della vita. Questo ci induce spesso a decontestualizzare le emozioni che i figli ci trasmettono e quindi, se il nostro piccolo di 2 anni è aggressivo, ne cogliamo solo il comportamento, senza metterlo in relazione alle difficoltà di gestione emotiva dell’età; e se la nostra tredicenne cerca con varie strategie di sfuggirci, tendiamo a notare solo la sua elusività, senza collegarla al necessario bisogno evolutivo di schiodarsi dal nostro stesso controllo.
Prima, quindi, di prendere decisioni azzardate, ricorrendo a punizioni immediate, è sempre buona cosa chiedersi: cosa caratterizza l’età di mio figlio? Quali sono i tratti tipici della sua fase evolutiva?
Bisogna evitare di banalizzare, di buttarla sul carattere e la personalità: «Ho una bambina difficile...», «Mio figlio ha un caratterino...!», «È... strano. Non pensavo che crescesse così... particolare!».
Certo: ogni persona ha le proprie peculiarità e ogni esistenza è diversa. Però la natura non fa salti così sensazionali e alcune componenti del percorso psicoevolutivo sono comuni.
Prendiamo ad esempio il gioco: tutti i bambini vogliono giocare, ne hanno bisogno, e un bambino che non gioca per un mese ne risente in termini di salute psichica. Possono differenziarsi nel modo in cui lo fanno ma l’esigenza ludica è comune a tutta l’infanzia.
Oppure consideriamo la necessità di muoversi: i bambini non stanno mai fermi, saltano, non camminano ma corrono. Questo non succede ai ragazzi o agli adulti. Un adulto non passa da un ufficio all’altro a passo svelto, a meno che non abbia un’emergenza, mentre i bambini si spostano da una stanza all’altra di corsa, non stanno fermi a tavola, si rotolano sul divano. Specialmente tra i 2 e i 7 anni sono sempre in una tensione dinamica dal punto di vista motorio, come se avessero bisogno di attraversare l’aria con il corpo e percepire questo attraversamento veloce; come se correre fosse un’esperienza sensoriale particolare che in età adulta cambia completamente. I grandi in genere sono posati, sanno passeggiare, tenere un certo passo, mentre, come sanno tutti i genitori, fare una camminata con un bambino comporta il fermarsi di continuo, lo scattare dietro le sue corse interminabili, l’incespicare nei suoi cambi improvvisi di direzione, una certa attenzione nel controllarne i movimenti. È compito dell’adulto interagire con questa tendenza in modo costruttivo, senza che passeggiare per strada si trasformi in uno stress continuo o in un pericolo.
PRENDERE TEMPO ED EVITARE LE REAZIONI EMOTIVE
L’arte educativa sta nella capacità di gestire le istanze naturali dei nostri figli, e integrarle in un processo progressivo di adattamento attraverso il quale possano interiorizzare le norme sociali che consentono loro di diventare autonomi e imparare a stare al mondo. Più questo processo è fluido, meno interferito da minacce, urla o punizioni, più l’interiorizzazione avviene in maniera positiva, rafforzando l’autostima dei bambini. I genitori sono sempre preoccupati per l’autostima dei propri figli, ma questa si crea se impariamo a riconoscere le caratteristiche e le competenze che corrispondono alla loro età, senza forzare né ritardare il loro processo evolutivo.
Un bambino di 2 anni non può vestirsi da solo, però a 3 può senz’altro cominciare a farlo; a 1 anno non può lavarsi i denti in autonomia, ma se inizia a 2, magari a 3 ci riesce anche bene; un ragazzo di 12 anni non può stare in piedi fino a mezzanotte tutte le sere, ma può pensare di uscire da solo il pomeriggio per incontrare gli amici al parco o in centro.
Ogni età ha le sue tappe e riconoscerle è importante per evitare di pretendere o negare qualcosa che la natura ancora non concede o, al contrario, già permette ai nostri figli.
Ricordo una coppia di genitori rivoltasi a me per il figlio di 9 anni.Il bambino andava piuttosto male a scuola e le insegnanti segnalavano un comportamento problematico: dava fastidio, prendeva spesso note. E i genitori confermavano che anche a casa era piuttosto nervoso, intemperante, sempre un po’ agitato, oppositivo. Erano molto preoccupati, ma quando chiedevo esempi concreti della sua cattiva condotta facevano fatica a fornirmene. A un certo punto il padre sbottò: «Senta dottore, probabilmente deve essere entrato in preadolescenza!», quasi per suggerirmi una soluzione del problema con una definizione tecnica. Ricordo di averlo guardato con una certa meraviglia, chiedendogli dove aveva recuperato una simile informazione, chiarendo che in quarta elementare siamo in piena infanzia, in particolare i maschi, e che la preadolescenza non avrebbe iniziato a manifestarsi prima di un paio di anni buoni.
Non so se riuscii a convincere quel padre, ma ho ben presente l’episodio perché mi capita spesso di incontrare genitori che, per spiegarsi la difficoltà a gestire i figli, si convincono che sia arrivata l’adolescenza, anche diversi anni prima dell’effettiva possibilità neurofisiologica. Tendono a confondere un comportamento e, in alcuni casi, un linguaggio piuttosto colorito, di fatto tipico dell’età adolescenziale che magari i bambini acquisiscono sentendolo da altri, con la realtà psicoevolutiva, che non può fare eccessivi salti da una generazione all’altra.
Capita poi che i presunti preadolescenti dormano ancora nel lettone, abbiano bisogno dell’assistenza materna per lavarsi e non siano in grado di prepararsi da soli lo zaino scolastico. È chiaro che la confusione è molta.
Mi scrive Carmen, mamma di Giovanni, 2 anni e 4 mesi:
Ho un bambino che da almeno un anno morde, soprattutto me e il papà (ma è capitato anche con i nonni e un cuginetto, un paio di volte) quando ha delle emozioni incontenibili dentro di sé, che siano belle o brutte. Inizialmente lo accettavamo, pensavamo che questa brutta abitudine potesse passare in tempi più brevi, inoltre Giovanni aveva meno denti di adesso quindi faceva meno male. Poi sono iniziati i dubbi sul perché lo facesse e i giudizi invadenti da parte dei nonni su come correggere questo comportamento sbagliato (nonché preoccupazioni del tipo: “E se quando andrà all’asilo morderà i compagni?”).
Il comportamento del bambino di Carmen presenta caratteristiche estremamente tipiche dell’età, lo spiega bene Alberto Oliverio:
“Al di sotto dei 5-6 anni il bambino ha difficoltà a controllare i propri impulsi: può avere delle paure incontrollate, può urlare per divertirsi, fare smorfie inappropriate, vuole mangiare subito ciò che gli piace, come una caramella, fa capricci per ottenerlo, si diverte a dire parolacce, soprattutto legate alle funzioni corporee. Molto spesso i genitori ritengono che un bambino di 3-4 anni sia in grado di padroneggiare le proprie emozioni e di controllare i propri impulsi: se ciò non avviene perdono spesso la pazienza, ignorando che è ancora troppo piccolo per essere ragionevole e adeguarsi alle loro indicazioni e inviti alla calma. A questa età il bambino può avere ancora delle crisi che spaventano o lasciano interdetti i genitori: lancia degli oggetti, si rotola per terra, picchia, morde e graffia le persone, può sbattere la testa contro il muro. Quando il bambino si calma, in genere l’adulto lo sgrida per spiegargli quanto sia stato improprio il suo comportamento, ma il bambino resta generalmente sconcertato e non presta ascolto.2”
Continua Carmen:
Ogni tanto mi rendo conto che lo faccio sentire in colpa quando gli chiedo perché mi ha morso, e anche il papà fa lo stesso, anzi a volte aggiunge un atteggiamento che mi infastidisce molto, tra il fatalista, il remissivo, l’autocommiserante e l’educatore assenteista: si guarda il morso al braccio, lo mostra a Giovanni, alza gli occhi al cielo e sospira; oppure mentre Giovanni lo sta mordendo lo sgrida con un tono di voce e una veemenza eccessivi, inadeguati e poco contenitivi, al limite dell’esibizionista. «Giovanni, Giovanni cosa stai facendo...» gli urla sgranando gli occhi.
Devo dire che di recente capita che Giovanni si avventi su di me ma non mi morda: spalanca la bocca ma non affonda i denti, in una specie di abbraccio “orale”. Un’ultima cosa: quando mi si fionda addosso cerco di non bloccarlo a priori, perché non posso essere certa che voglia mordermi e non mi sembra giusto mortificarlo per una cosa che non è intenzionato a fare, non in quell’occasione almeno.
Sia io sia il suo papà cerchiamo di essere genitori attenti e consapevoli, però mi sto rendendo conto degli innumerevoli errori che continuiamo a commettere con nostro figlio.
A tal riguardo è particolarmente interessante il commento di Isabelle Filliozat, la psicoterapeuta francese di fama internazionale, che scrive:
“Un bambino è un bambino, non si sa ancora esprimere in modo adeguato. Il ruolo del genitore è proprio quello di aiutarlo a usare le parole appropriate e non di gareggiare con lui sul piano emotivo. È naturale che le emozioni dei bambini siano prioritarie rispetto a quelle dei genitori che sono in grado di controllare i loro impulsi.3”
In realtà Carmen sembra capire che il comportamento di Giovanni non è consapevolmente oppositivo, ma segue una sorta di corrente emotiva incontrollabile. Fatica a farsene una ragione e a ricondurre il comportamento di suo figlio entro una cornice accettabile. Questo la porta ad attribuire ai morsi del bambino un peso che non hanno: non coglie il senso della fase evolutiva e non riesce a fare le due o tre mosse giuste che potrebbero contenerlo.
Non è facile per i genitori sottrarsi alla trappola emotiva della reazione immediata, che scatta per la sorpresa e lo sconcerto che suscitano i comportamenti dei figli.
Per questo è necessario darsi il tempo per capire cosa sta succedendo e in particolar modo per sintonizzarci con la loro età, altrimenti il pasticcio è inevitabile, e spesso seguito da magoni e sensi di colpa per aver fatto un intervento sbagliato o improprio.
Sentiamo un’altra mamma.
Ombretta, mamma di Martino, 6 anni
Martino è un bambino di quasi 6 anni e frequenta la prima elementare. A scuola non ha nessun problema, ma a casa... un capriccio continuo da quando apre gli occhi la mattina per lavarsi i denti e vestirsi, fino al momento di andare a letto.
Ma forse la colpa è mia. Dopo avergli detto cinque o sei volte la stessa cosa... inizio a urlare. L’approccio che ha Martino nei miei confronti è sempre quello del «no!». Ultimamente ha iniziato a fare cose incredibili (ad esempio ha sputato a un bambino) e trascorre la maggior parte del tempo in castigo. Non credo che sia un bene punirlo, ma un susseguirsi di episodi come quello che ho citato mi hanno portato a questa decisione estrema.
Martino è un bambino che fuori dalle mura domestiche è indipendente, mentre a casa è lento e alla continua ricerca di aiuto, anche per fare cose che è perfettamente in grado di fare in autonomia. E la cosa sta diventando un grandissimo problema anche nel rapporto tra me e mio marito e tra padre e figlio.
Tentando di spronarlo, una volta mi sono sentita rispondere: «Mamma, abbi pazienza!».
I maggiori momenti di attrito li abbiamo perché non saluta, non sta composto a tavola, perché non vuole mai fare i compiti, perché si distrae di continuo. Mi incolpa di farlo piangere e a volte sembra che mi odii.
Se provo ad assecondarlo su alcune cose, comunque la sua reazione è negativa. Ad esempio gli dico che dobbiamo fare i compiti. Se lui dice che non vuole farli e io gli dico che va bene... allora lui si mette a piangere, e grida che vuole...